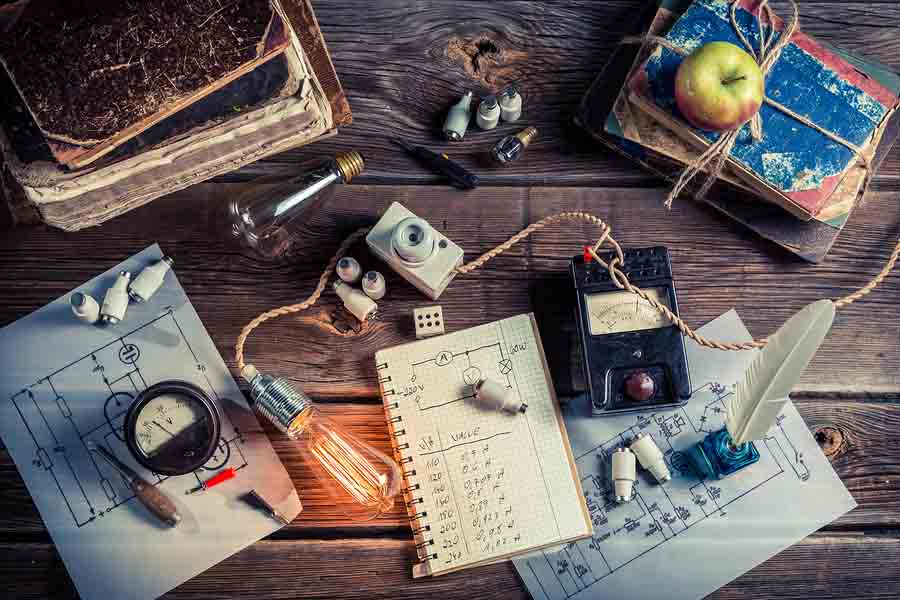- La spinta dei razzi nasce dalla combustione in camera e dall’espansione dei gas nell’ugello, secondo la terza legge di Newton.
- Propellenti solidi, liquidi e ibridi offrono compromessi diversi tra controllo, densità, complessità ed efficienza (impulso specifico).
- Stadi e separazioni ottimizzano il rapporto spinta/peso; siti equatoriali sfruttano la rotazione terrestre; il recupero riduce i costi.

La corsa allo spazio ha reso i razzi protagonisti assoluti della tecnologia del XX secolo e oltre: queste macchine trasformano l’energia chimica dei propellenti in spinta espellendo gas caldissimi a grande velocità, secondo la terza legge di Newton. A differenza di aerei e turbine, non hanno bisogno dell’aria esterna per funzionare: il loro “getto” nasce dentro la camera di combustione, e la reazione uguale e contraria spinge il veicolo nella direzione opposta.
Alla potenza del motore si sommano aerodinamica curata, materiali strutturali leggeri ma resistenti e un’enorme capacità di immagazzinare combustibile e ossidante. Così un vettore può toccare velocità altissime e coprire distanze enormi in tempi ridottissimi, fino a varcare la linea di Kármán e proseguire in orbita o in traiettorie interplanetarie. È un’impresa che ha richiesto decenni di ricerca, ma che oggi è alla base della nostra presenza nello spazio.
Perché un razzo funziona anche nel vuoto
Una domanda ricorrente è: “Dopo aver lasciato la Terra non c’è più aria, quindi la pressione nei razzi su cosa agisce? È solo aria compressa?” La risposta breve è: no, non è aria compressa; la spinta nasce dalla pressione altissima dei prodotti di combustione nella camera e dal loro rapido scarico attraverso l’ugello. I gas spingono sulle pareti della camera e soprattutto sul fondo dell’ugello; uscendone ad altissima velocità, generano la forza che accelera il razzo nella direzione opposta (azione-reazione).
A differenza degli aerei, che “respirano” ossigeno dall’atmosfera, un razzo porta con sé l’ossidante necessario alla combustione. Perciò funziona anche nel vuoto assoluto: la reazione chimica avviene comunque, perché combustibile e ossidante sono stivati a bordo e pompati nella camera di combustione. La legge fisica non cambia che si sia in aria o nello spazio.
Curiosità utile: a parità di pressione di camera e portata di massa, la spinta al livello del mare è generalmente inferiore rispetto al vuoto. Nel vuoto infatti la contropressione esterna è nulla; l’ugello può espandere meglio il flusso e il termine di spinta legato all’uscita aumenta. In basso in atmosfera, la maggiore pressione esterna “soffoca” in parte l’espansione, riducendo l’effetto utile sull’ugello.
Per fugare l’equivoco più comune: ciò che conta non è “spingere contro l’aria” ma accelerare una massa di gas all’indietro. Espellendo rapidamente una grande massa di gas (o una massa minore ma a velocità eccezionale), il razzo riceve una spinta in avanti. Ecco perché, in confronto, una semplice bombola di aria compressa non è un “motore a razzo” efficace: mancano la reazione di combustione e le pressioni/temperature elevate che permettono velocità di scarico e portate massiche adatte al volo.
Se vuoi approfondire elementi e formule fondamentali, puoi consultare un vademecum tecnico come questo estratto: Scarica il PDF.
Combustione, spinta ed equilibrio delle forze
Nei motori a razzo, la combustione può essere descritta in modo schematico così: combustibile + ossidante → gas caldi + energia. I gas prodotti si espandono, la pressione in camera sale e l’ugello trasforma parte dell’energia termica in energia cinetica del getto. La spinta (empuxo) deve superare il peso del veicolo, che al decollo vale m·g con g ≈ 9,8 m/s². Man mano che i propellenti si consumano, la massa del razzo diminuisce e, a parità di spinta, l’accelerazione cresce.
Un parametro chiave è l’impulso specifico (Isp), che esprime l’efficienza di un propellente/motore: in termini divulgativi, indica quanta spinta si ottiene per unità di flusso di massa del getto (spesso espressa in secondi). Maggiore è l’Isp, più “lunga” è la spinta ottenuta per la stessa quantità di massa espulsa. L’Isp dipende dalla combinazione di propellenti, dalla pressione di camera, dal rapporto di espansione dell’ugello e dall’altitudine.
Un altro fattore è la quota: più bassa è l’altitudine, maggiore è la pressione atmosferica sull’uscita dell’ugello, e questo riduce la componente di spinta legata alla differenza di pressione. Al crescere dell’altitudine e verso il vuoto, la spinta tipica dello stesso motore aumenta perché la contropressione diminuisce. Non è magia, è pura fluidodinamica.
Tipi di propellenti: liquidi, solidi e ibridi
I propellenti dei razzi si classificano in tre grandi famiglie: liquidi, solidi e ibridi. La scelta dipende dalla missione, dai vincoli di costo, dal livello di controllo richiesto e da criteri di sicurezza e logistica.
Propellenti liquidi: possono essere “petroliferi”, criogenici o ipergolici. Esempi noti sono il kerosene raffinato (RP-1) con ossigeno liquido (LOX) e la coppia idrogeno liquido (LH2) – LOX, usata anche nello Space Shuttle. Iliquidi consentono un controllo fine della spinta (throttle) e della miscela, ma comportano alta complessità ingegneristica perché richiedono pompe, valvole, linee criogeniche e sistemi di accensione affidabili.
Propellenti solidi: si distinguono in omogenei (single base) e composti (double base o compositi). Nella categoria single e double base rientrano ricette a base di nitrocellulosa e nitroglicerina; nei compositi si combinano combustibili e ossidanti dispersi in una matrice polimerica. I solidi sono densi, semplici da stoccare e relativamente economici, però hanno un profilo di spinta meno modulabile: una volta accesi, è difficile “spegnere o regolare” il motore.
Propulsione ibrida: qui si cerca di unire i punti forti dei liquidi e dei solidi. Tipicamente il combustibile è in fase solida e l’ossidante in fase liquida (o viceversa). L’ibrido offre una certa regolabilità della spinta e migliora la sicurezza rispetto ad alcuni solidi compositi, pur restando meno complesso dei bipropellenti liquidi più avanzati.
Nei razzi liquidi si incontrano due grandi famiglie operative: monopropellenti e bipropellenti. I monopropellenti (come perossido di idrogeno ad alta concentrazione o idrazina in molti micromotori) si decompongono esotermicamente passando su un catalizzatore, generando spinta senza un ossidante separato. I bipropellenti, invece, mantengono separati combustibile e ossidante fino agli iniettori in camera, dove avviene la combustione che produce gas caldi e pressione utile alla spinta.
Architettura e componenti di un motore a liquido
Un moderno motore a propellente liquido è un capolavoro di ingegneria. I suoi elementi principali includono serbatoi, linee di alimentazione, turbo-pompe ad altissima pressione, iniettori, camera di combustione, ugello, sistemi di controllo e di raffreddamento.
Serbatoi di combustibile e ossidante: ospitano i fluidi in comparti separati, dimensionati per resistere a pressioni e temperature estreme (pensiamo al LOX criogenico e all’LH2 a bassissima temperatura). Materiali e isolamento sono cruciali per limitare bolliture e perdite termiche.
Pompaggio e alimentazione: turbine e pompe forzano i propellenti nella camera a pressioni elevate, assicurando il corretto rapporto di miscela e la portata richiesta. Questo è uno dei cuori pulsanti del motore: più alta è la pressione di camera, maggiore può essere la velocità di scarico del getto (a parità di altre condizioni).
Camera di combustione: è il luogo dove combustibile e ossidante si mescolano e bruciano liberando energia. Le pareti devono sopportare temperature e gradienti termici estremi; si usano leghe avanzate e rivestimenti e, spesso, raffreddamento rigenerativo.
Ugello: converte la pressione e la temperatura del gas in velocità del getto. La sua geometria (convergente-divergente) e il rapporto di espansione determinano gran parte dell’efficienza. Un ugello “sovraespanso” a bassa quota può perdere efficienza per eccesso di espansione, mentre in alto nello spazio può lavorare al top.
Controllo del flusso e accensione: valvole, sensori e centraline governano la portata, la sequenza di start e le condizioni operative. L’accensione può avvenire con pirotecnici, accenditori elettrici o tramite autoinfiammabilità (ipergolici) laddove la coppia di propellenti lo consenta.
Raffreddamento: per evitare il danneggiamento delle pareti, si fa spesso scorrere combustibile o ossidante in canaline lungo camera e ugello (raffreddamento rigenerativo) prima di iniettarli, sottraendo calore e migliorando l’efficienza complessiva.
Cicli di funzionamento: aperto, chiuso e rigenerativo
Esistono diverse architetture di ciclo. Nel ciclo aperto (a gas generator, per esempio), una piccola frazione di propellente alimenta una turbina e i gas prodotti vengono scaricati fuori, senza entrare nella camera principale: è più semplice, ma meno efficiente.
Nel ciclo chiuso (staged combustion o expander), parte dell’energia generata torna a beneficio del sistema di pompaggio: i gas pilotano le turbine e poi entrano in camera, o il combustibile si scalda trasferendo calore dalla camera e vaporizzandosi prima di alimentare la turbopompa. Questo aumenta l’efficienza a scapito di complessità e materiali.
Il raffreddamento rigenerativo non è propriamente “un ciclo a sé” ma una tecnica trasversale usata spesso in cicli chiusi: circolare il propellente lungo le pareti calde migliora sia il raffreddamento sia le condizioni di iniezione. L’obiettivo è sempre massimizzare spinta ed efficienza con un margine di sicurezza adeguato.
Stadi, separazioni e retropropulsione
I razzi sono generalmente veicoli a stadi. Ogni stadio è una sezione motorizzata con una funzione precisa; quando ha esaurito il suo compito (e i suoi propellenti), viene sganciato per liberare massa. La separazione può riguardare anche carenature e scudi che proteggono il carico utile nelle fasi di massima pressione dinamica.
Esistono configurazioni in serie e in parallelo. Nel decollo, il primo stadio eroga la spinta massima per vincere gravità e resistenza aerodinamica, condizioni severe per struttura e motori. Terminato il suo lavoro, si separa; subentra il secondo stadio, più leggero e ottimizzato per l’alta quota, che prosegue verso orbita o verso la traiettoria d’iniezione richiesta.
La separazione riduce la massa inerziale e migliora l’accelerazione nelle fasi successive. Oggi alcuni stadi vengono recuperati: aziende come SpaceX progettano rientri controllati con retropropulsione e atterraggio su piattaforme o terraferma, riutilizzando hardware altrimenti perduto.
Velocità di fuga e “budget” energetico
Per rendere l’idea dell’energia in gioco, si cita spesso la velocità di fuga terrestre: circa 11,2 km/s, pari a ~40.320 km/h, ovvero circa 30 volte la velocità del suono nell’aria. Non significa che un razzo debba “saltare” a quella velocità in un colpo solo, ma indica l’ordine di grandezza della sfida energetica.
Lo storico Saturn V, che portò gli astronauti dell’Apollo sulla Luna, sviluppava circa 34,5 milioni di newton di spinta, scalando oltre 100 km nei primi minuti di volo. Numeri così grandi spiegano perché la progettazione di motori, propellenti e strutture sia uno degli sforzi ingegneristici più ardui mai affrontati.
Senza la combustione in corso, la velocità del veicolo resterebbe quella iniziale; la continua espulsione di massa abbassa la massa del razzo e aumenta l’accelerazione, migliorando progressivamente il rapporto spinta/peso. Questo è anche il motivo per cui la separazione degli stadi risulta tanto efficace: togli peso morto eleva le prestazioni complessive.
Siti di lancio, traiettorie e logistica
La Terra ruota più rapidamente all’Equatore, con velocità tangenziale di circa 1.600 km/h. Per questo molti centri di lancio si trovano in regioni equatoriali o comunque a bassa latitudine: si “sfrutta” gratuitamente parte della velocità terrestre per raggiungere più facilmente l’orbita.
Non tutte le missioni però mirano a orbite equatoriali: le orbite polari richiedono altre inclinazioni, e infatti esistono cosmodromi anche a latitudini più alte. La scelta del sito considera anche la sicurezza: gli stadi che rientrano, in assenza di recupero, sono spesso fatti cadere in aree oceaniche predefinite.
Con il progresso recente, i lanciatori “moderno stile” pianificano il ritorno degli stadi su chiatte o basi terrestri. Questa riutilizzabilità ha ridotto i costi di accesso all’orbita e ha reso più frequenti i voli, favorendo nuove applicazioni come mega-costellazioni di satelliti e missioni scientifiche ripetute.
Guida, navigazione e controllo
Il controllo di un razzo può essere autonomo a bordo oppure supportato da terra. Storicamente, tracciamenti con laser hanno offerto precisioni nell’ordine di pochi centimetri (circa 5 cm), mentre i radar basati su radiosegnali hanno errori tipici nell’ordine dei metri (circa 10 m). Le piattaforme inerziali, i sensori GNSS e i sistemi di controllo vettoriale di spinta (TVC) stabilizzano e guidano il veicolo lungo la traiettoria nominale.
L’elettronica di bordo (avionica) integra computer di volo, sistemi di telemetria e gestione propellente, oltre a una rete di sensori. Per chi desidera entrare in questo mondo, esistono percorsi formativi che coprono dai fondamenti fino ai sistemi avanzati impiegati in aviazione e spazio: l’interesse verso ADS‑B, ILS e altri apparati si intreccia con la cultura del controllo d’assetto e della propulsione.
Questa attenzione alla precisione si riflette anche sulle innovazioni: razzi riutilizzabili con atterraggi automatici, motori più puliti, indagini sulla propulsione elettrica (per satelliti e manovre di fino), oltre a studi su micro-lanciatori e motori ibridi che combinano semplificazione operativa ed efficienza.
Motori e scelte di propellente: esempi e tendenze
I motori a liquido più diffusi impiegano ossigeno liquido con kerosene (RP‑1) o idrogeno liquido. LOX/LH2 offrono Isp elevatissimi ma richiedono gestione criogenica sofisticata; LOX/RP‑1 è meno estremo ma molto potente nella fase iniziale del lancio. Esistono poi coppie ipergoliche che s’innescano al contatto (molto comode per piccoli motori di manovra), sebbene presentino criticità ambientali e di sicurezza.
Nei piccoli sistemi di controllo d’assetto, i monopropellenti come l’idrazina o le miscele “green” di nuova generazione offrono semplicità e affidabilità. Ogni missione è un compromesso: prestazioni, sicurezza, costo, riutilizzo e impatto ambientale entrano nella valutazione complessiva.
Tra le tendenze del settore spiccano l’uso di propellenti alternativi meno impattanti, i programmi per estendere i cicli di vita degli stadi, e l’ulteriore automazione dei lanci e dei rientri. Motori più efficienti e leggeri consentiranno missioni lunari e marziane più ambiziose, e piattaforme cargo per infrastrutture orbitali.
Storia e curiosità: dai fuochi cinesi ai moderni vettori
La radice della propulsione a razzo affonda nella storia. Già nel III secolo d.C. in Cina si usavano tubi di bambù con salnitro, zolfo e carbone, antenati dei fuochi d’artificio, per scacciare i “cattivi spiriti”. Quei principi rudimentali di reazione hanno ispirato, secoli dopo, sistemi bellici e poi veicoli scientifici e di esplorazione.
La formalizzazione fisica arrivò con Isaac Newton (1643–1727): la sua legge di azione e reazione è il pilastro per capire i razzi. Non a caso, un testo divulgativo‑tecnico dedicato alla “propulsione e controllo di veicoli aerospaziali” (Propulsão e controle de veículos aeroespaciais – uma introdução, di Emerson Faria Cabral Paubel, Editora da UFSC, Florianópolis, 2002, 196 pagine; prezzo indicativo R$ 20) ha puntato molto su questa base concettuale. Nelle rassegne della stampa scientifica (ad esempio a firma di Denis Weisz Kuck su “Ciência Hoje on‑line”, 12/03/03) è stato evidenziato come la retropropulsione derivi dalla conversione di energia chimica in meccanica tramite combustione, con i gas ad alta pressione che generano spinta premendo sulle pareti della camera e sull’ugello.
Nei portali divulgativi capita di incappare in una “pausa pubblicitaria” tra un paragrafo e l’altro: al di là delle interruzioni, il fulcro resta la fisica della spinta e l’ingegneria che la rende affidabile, dalla scelta dei propellenti alla meccanica delle strutture fino al controllo del volo.
Dal decollo alla separazione: come si svolge un lancio
Il primo stadio affronta le condizioni più dure: spinta massima, peso massimo e resistenze aerodinamiche elevate. Il profilo di spinta e la direzione del getto vengono regolati per superare la gravità, tenere il veicolo in assetto e “girarlo” lungo la traiettoria programmata.
Alla fine della prima fase, arrivano le separazioni: lo stadio iniziale si sgancia, si eliminano carenature divenute inutili e lo stadio successivo accende i propri motori. A quote più alte, l’aria è rarefatta e i motori ottimizzati per il vuoto lavorano meglio, accompagnando il carico verso l’orbita di destinazione.
Negli ultimi anni, il recupero degli stadi tramite rientro controllato e atterraggio propulsivo ha cambiato i modelli di costo e frequenza dei lanci, aprendo la strada a un’industrializzazione più spinta della via d’accesso allo spazio.
FAQ d’autore: chiarire i dubbi più comuni
“Nel vuoto come fa a funzionare, se non c’è nulla da “spingere”?” Il razzo non spinge sull’aria: espelle massa ad alta velocità e, per azione-reazione, riceve una spinta opposta. “È solo aria compressa?” No: sono prodotti di combustione ad alta temperatura e pressione, accelerati dall’ugello. “Il razzo spinge di più sulla Terra o nello spazio?” A parità di condizioni interne, nel vuoto la spinta cresce per via della contropressione esterna minore e della migliore espansione nell’ugello.
“Da cosa dipende la velocità finale?” Dalla quantità totale di propellente, dall’impulso specifico del sistema, dal rapporto di masse e dal profilo di missione. “Perché si separano gli stadi?” Per buttare massa inutile dopo che ha fatto il suo dovere, migliorando il rapporto spinta/peso e l’efficienza complessiva.
La propulsione a razzo è l’incontro tra la semplicità di una legge fisica e la complessità dell’ingegneria moderna: combustione che produce gas ad alta energia, ugelli che li accelerano, stadi che si separano per alleggerire il volo, siti di lancio scelti con criterio orbitale e sistemi di guida sempre più precisi. Dalle polveri del III secolo cinese ai 34,5 MN del Saturn V, fino ai booster che atterrano “in piedi”, la stessa idea – espellere massa per muoversi – ha trovato declinazioni sempre più raffinate, aprendo la strada a satelliti, esplorazione e servizi che usiamo ogni giorno.