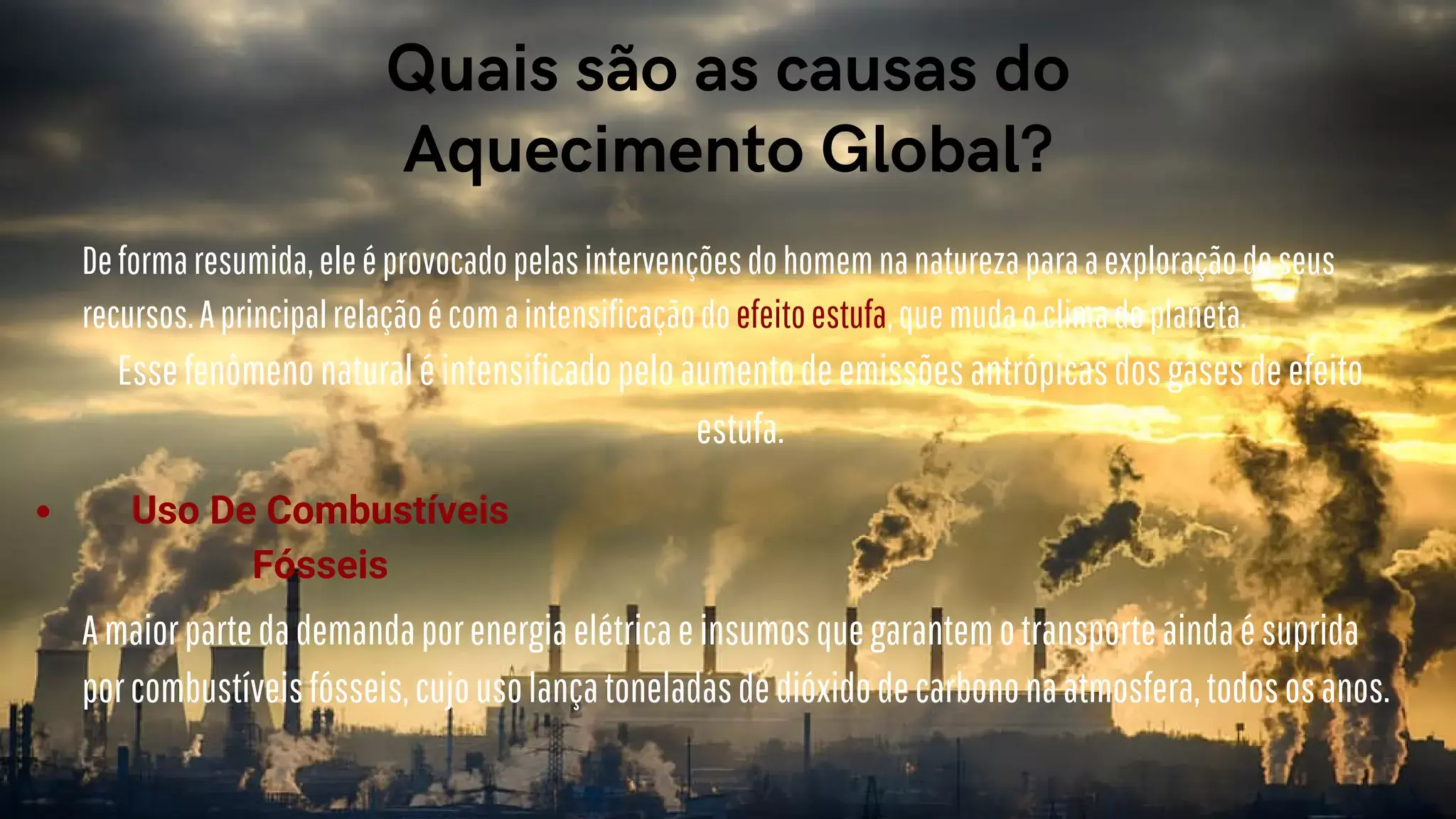- Il riscaldamento globale è dovuto all’aumento dei gas serra legato a energia fossile, industria, deforestazione, trasporti e agricoltura.
- Le prove scientifiche escludono le sole cause naturali: modelli, dati e firma verticale del riscaldamento indicano l’origine antropica.
- Gli impatti sono già diffusi: ondate di calore, oceani più caldi e acidi, eventi estremi, perdita di biodiversità, rischi sanitari e sociali.
- Le soluzioni esistono: rinnovabili, efficienza, stop alla deforestazione, agricoltura sostenibile, mobilità pulita e governance internazionale.
Il pianeta si sta riscaldando più in fretta di quanto registrato in qualsiasi altra epoca storica. Questo non è uno slogan: è ciò che emerge da database climatici di lungo periodo e da agenzie come la Nasa e l’IPCC. Negli ultimi decenni, la temperatura media globale è aumentata ben oltre la variabilità naturale, con incrementi che, rispetto all’era preindustriale, hanno già superato la soglia di un grado. Le conseguenze sono ovunque: ghiacci che arretrano, oceani che si espandono e tempeste che diventano più intense.
All’origine di questo sbilanciamento c’è un meccanismo semplice nella sua essenza ma vasto nelle sue implicazioni: l’intensificazione dei gas serra di origine umana. Combustibili fossili, deforestazione, agricoltura e industria hanno riallineato il bilancio energetico della Terra trattenendo più calore del dovuto nell’atmosfera. Il risultato è un riscaldamento globale che trascina con sé cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, rischi sanitari e sociali e, non ultimo, una forte pressione sulle economie e sulle città.
Che cos’è il riscaldamento globale
Per riscaldamento globale si intende l’aumento anomalo e prolungato delle temperature medie del pianeta rispetto ai livelli preindustriali. Le analisi di serie storiche mostrano che il 2023 è stato circa 1,36 °C più caldo della media preindustriale e che gli ultimi dieci anni hanno fatto registrare le temperature più elevate da quando esistono misurazioni strumentali. Non a caso, nel 2023 il Segretario Generale dell’ONU ha parlato di “ebollizione globale”, a sottolineare la gravità del momento.
Questo aumento non è uniforme: si parla di amplificazione artica quando si osserva che le regioni polari si scaldano molto più rapidamente della media. Dal punto di vista fisico, il riscaldamento globale è l’effetto di un maggiore intrappolamento della radiazione infrarossa in atmosfera, dovuto all’aumento dei gas che assorbono il calore emesso dalla superficie terrestre.
Effetto serra: naturale ma oggi potenziato
L’effetto serra è un fenomeno naturale che mantiene la Terra in un intervallo termico compatibile con la vita. In condizioni normali, una parte del calore irradiato dalla superficie viene riassorbito da gas come vapore acqueo, anidride carbonica e metano, e una parte sfugge nello spazio. Con l’aumento antropico di CO2, CH4, N2O, ozono troposferico e gas fluorurati (tra cui CFC e loro sostituti), la “coperta” si ispessisce e più calore resta intrappolato.
Un aspetto connesso è lo stato della fascia di ozono stratosferico, che filtra i raggi UV. La presenza di composti come i CFC ha ostacolato in passato il ripristino naturale dei “buchi” dell’ozono. La perdita di efficacia protettiva in alcune aree non è la causa primaria del riscaldamento globale, ma altera l’equilibrio radiativo complessivo ed è parte dello stesso quadro di pressione antropica sulla chimica dell’atmosfera.
Come e perché avviene l’aumento delle temperature
Tra il 1750 e il 2005 l’incremento della CO2 atmosferica ha generato una forzante radiativa positiva media di circa 1,66 W/m², sufficiente da sola a spingere verso l’alto la temperatura superficiale. Nel periodo 2010–2019, il riscaldamento attribuibile alle attività umane è valutato in un intervallo probabile tra 0,8 °C e 1,3 °C rispetto al 1850–1900 (stima migliore: 1,07 °C), in linea con l’aumento osservato.
Le emissioni antropiche globali hanno raggiunto nel 2019 circa 59 miliardi di tonnellate di CO2-equivalenti: il 75% CO2, il 18% metano, il 4% protossido di azoto, il 2% gas fluorurati. La concentrazione di CO2 è passata da 313 ppm misurate nel 1958 a 415 ppm nel 2019, valori che non si vedevano da milioni di anni. Tra il 2022 e il 2024 il ritmo di crescita della CO2 ha toccato nuovi massimi anche in concomitanza con condizioni di El Niño.
Fortunatamente, biosfera e oceani assorbono una quota rilevante delle emissioni: circa il 29% viene fissato sulla terra (suoli e foreste) e il 20–30% dagli oceani. Ma questa frazione non è costante: se le emissioni calassero, la percentuale assorbita potrebbe crescere fino al 70%; se aumentassero, la quota relativa assorbita scenderebbe sotto il 40% per effetto di suoli più caldi, siccità, acidificazione e cambiamenti nella circolazione oceanica.
Le 5 cause principali dell’aumento delle temperature
1) Produzione di energia. Elettricità e calore generati bruciando carbone, petrolio o gas restano tra le principali fonti di emissioni di CO2 e N2O. A livello mondiale, solo una quota minoritaria dell’elettricità proviene ancora da rinnovabili come vento e sole, che emettono poco o nulla in fase di generazione.
2) Industria e manifattura. La produzione di cemento, ferro, acciaio, chimica e materiali sintetici richiede energia (spesso fossile) e libera CO2 anche tramite processi industriali intrinseci. La cantieristica e la costruzione contribuiscono ulteriormente, e molte macchine operative usano combustibili fossili.
3) Deforestazione e cambi d’uso del suolo. Taglio e incendio delle foreste per creare pascoli o coltivi liberano il carbonio accumulato nella biomassa. Ogni anno si perdono circa 12 milioni di ettari di foreste. Tra il 2001 e il 2018, il 27% della deforestazione è stato permanente per espansione agricola, il 24% temporaneo per agricoltura itinerante, il 26% per legname e il 23% per incendi forestali. Il risultato è doppio: più CO2 in aria e meno capacità di assorbirla.
4) Trasporti. Auto, camion, navi e aerei funzionano prevalentemente con derivati del petrolio. I veicoli stradali sono i principali responsabili delle emissioni del settore, mentre aviazione e navigazione continuano ad aumentare il proprio peso. Il trasporto vale quasi un quarto della CO2 energetica globale.
5) Agricoltura e produzione di cibo. Il settore emette metano (allevamenti e coltivazioni di riso) e protossido di azoto (decomposizione dei fertilizzanti), oltre alle emissioni indirette da deforestazione e uso di combustibili nei mezzi agricoli. Insieme a imballaggio e distribuzione, il sistema alimentare pesa fortemente sul bilancio climatico.
Consumi, edifici e il ruolo degli stili di vita
Edifici residenziali e commerciali assorbono più della metà dell’elettricità mondiale e, se alimentati da fonti fossili, rilasciano grandi quantità di CO2. La domanda di climatizzazione è cresciuta, così come il parco apparecchi connessi. Non meno rilevante è l’impatto dei consumi privati: le scelte su mobilità, dieta, energia domestica e acquisti determinano una porzione significativa delle emissioni globali, con la fascia più abbiente che incide molto più della metà più povera del pianeta.
Altri fattori climatici: aerosol, albedo, feedback
La fuliggine (black carbon) depositata su neve e ghiaccio aumenta l’assorbimento di luce e accelera la fusione, contribuendo all’innalzamento dei mari. Limitare questi depositi nel Circolo Polare Artico potrebbe ridurre il riscaldamento di circa 0,2 °C entro il 2050.
I cambi d’uso del suolo modificano l’albedo (la quota di luce riflessa). Sostituire una foresta scura con una prateria più chiara aumenta la riflessione solare, ma ai tropici e alle medie latitudini il saldo netto è comunque di riscaldamento a causa della perdita di evaporazione e di altri effetti biofisici. Globalmente, gli effetti diretti di albedo da cambi d’uso hanno dato un leggero raffreddamento, mentre le emissioni da deforestazione hanno nettamente scaldato.
I feedback climatici amplificano o attenuano la risposta del sistema: il feedback del vapore acqueo e quello ghiaccio–albedo sono positivi (rafforzano il riscaldamento), mentre l’aumento dell’emissione radiativa con la temperatura è un feedback di equilibrio (negativo). Le nuvole restano la maggiore fonte di incertezza: se più estese e riflettenti raffreddano, se più alte e sottili trattengono calore.
Forzanti naturali: contributo minimo al riscaldamento recente
Le variazioni dell’irraggiamento solare e il vulcanismo hanno inciso molto poco sul trend osservato dal XIX secolo. Dal 1880 non si registrano trend crescenti di energia solare in ingresso compatibili con l’aumento delle temperature troposferiche; anzi, la stratosfera si è raffreddata, come previsto quando sono i gas serra a intrappolare il calore nella bassa atmosfera.
Le eruzioni esplosive possono raffreddare temporaneamente immettendo aerosol riflettenti o, in alcuni casi, aumentare l’effetto serra con vapore acqueo, ma la persistenza in atmosfera è bassa: l’effetto dura pochi anni e non spiega l’ascesa termica di lungo periodo.
Conseguenze osservate e attese
Temperature più alte significano ondate di calore più lunghe e frequenti, con maggiori rischi sanitari e condizioni favorevoli agli incendi. Gli oceani assorbono la gran parte del calore in eccesso e si scaldano a tutte le profondità, si espandono termicamente e ricevono acqua di fusione da calotte e ghiacciai, con innalzamento del livello marino.
Le tempeste diventano più intense dove l’oceano fornisce energia aggiuntiva (cicloni tropicali), e la maggiore umidità atmosferica alimenta piogge estreme e alluvioni. All’opposto, si accentuano siccità agricole ed ecologiche in molte regioni, con deserti in espansione e tempeste di sabbia e polvere più distruttive.
La biodiversità è sotto stress: tassi di estinzione accelerano per perdita di habitat, incendi e specie invasive e patogeni favoriti dal clima. Gli ecosistemi marini soffrono l’acidificazione legata alla CO2 disciolta, minacciando barriere coralline e catene trofiche che sostentano miliardi di persone.
Il cibo e l’acqua diventano più incerti: rese agricole compromesse da ondate di calore, siccità o piogge torrenziali, approvvigionamenti idrici più instabili, zootecnia in sofferenza. I sistemi sanitari sono sollecitati da malattie, inquinamento e stress termico: l’OMS considera i cambiamenti climatici la più grande minaccia sanitaria globale.
Cambiamenti climatici: segni, fenomeni e soglie
Le trasformazioni del clima riguardano pattern di temperatura e precipitazione a medio–lungo termine. Una delle evidenze più chiare è l’aumento della temperatura media globale di circa 1,1 °C dall’inizio dell’industrializzazione. Se non si riducono rapidamente le emissioni, le proiezioni indicano un possibile avvicinamento a 1,5 °C già nelle prossime due decadi, oltre il quale crescono i rischi di effetti irreversibili.
Fenomeni come El Niño e La Niña stanno mostrando fasi più intense e frequenti; aumentano episodi di freddo estremo in alcuni contesti dinamici, ma il segnale di fondo è un riscaldamento globale pervasivo con estremi di caldo e piogge senza precedenti storici in molte località.
Il caso del Brasile: emissioni e impatti
Il Brasile è tra i maggiori emettitori globali, insieme a Cina, Stati Uniti e Giappone. Qui pesa in modo particolare la deforestazione e l’agro–zootecnia: la fermentazione enterica dei ruminanti rilascia metano, e l’apertura di nuove aree produttive libera e riduce lo stoccaggio di carbonio. Negli ultimi anni, gli incendi come metodo di conversione del suolo hanno aggravato il quadro emissivo.
Il Paese è anche un attore chiave nei negoziati internazionali per via del suo potenziale ambientale, dalla Foresta Amazzonica alle energie rinnovabili. Tra il 2021 e il 2024, ondate di calore diffuse, siccità in Amazzonia e piogge estreme in Bahia e Rio Grande do Sul con inondazioni storiche hanno evidenziato l’urgenza di mitigazione e adattamento.
Le prove del ruolo umano (e perché le ipotesi alternative non reggono)
Quattro linee di evidenza sostengono il ruolo dominante delle attività umane nel riscaldamento recente: 1) la fisica del sistema climatico, con concentrazioni crescenti e proprietà radiative dei gas serra ben note; 2) ricostruzioni storiche che mostrano quanto siano inusuali gli aumenti attuali; 3) i modelli climatici non riproducono il riscaldamento osservato senza includere le emissioni antropiche; 4) le osservazioni delle forzanti naturali (solare e vulcanica) non spiegano il trend, e la firma verticale del riscaldamento (troposfera più calda, stratosfera più fredda) è coerente con l’aumento dei gas serra.
Esistono posizioni scettiche che vedono cicli naturali dietro la tendenza recente o che minimizzano il ruolo umano, ma la convergenza delle evidenze indipendenti rende queste spiegazioni incompatibili con dati, fisica e osservazioni multi–decennali.
Accordi e governance del clima
Dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 alla ECO-92 di Rio de Janeiro, la comunità internazionale ha costruito una cornice di azione culminata in due strumenti cardine: il Protocollo di Kyoto (1997), primo tentativo vincolante di riduzione delle emissioni, e l’Accordo di Parigi (2015), che mira a mantenere il riscaldamento ben al di sotto dei 2 °C e possibilmente entro 1,5 °C.
Questi processi sono affiancati da meccanismi di mercato (crediti di carbonio), finanziamenti per il clima e iniziative su foreste e suolo (REDD, riforestazione). Tuttavia, le emissioni globali continuano a salire e la finestra per centrare gli obiettivi si sta restringendo.
Misure per ridurre il riscaldamento globale
Servono azioni su più fronti: la priorità è decarbonizzare la produzione di energia accelerando su rinnovabili e reti, elettrificando i consumi finali e migliorando efficienza in edifici, industrie e trasporti. Vanno ripensati processi ad alta intensità emissiva (cemento, acciaio), con innovazione e, dove sensato, cattura e stoccaggio del carbonio.
È cruciale fermare la deforestazione, potenziare il ripristino degli ecosistemi e promuovere un’agricoltura più sostenibile, riducendo metano e protossido di azoto. Le politiche pubbliche devono garantire controlli e sanzioni efficaci contro pratiche illegali (disboscamenti, bruciamenti, scarichi), mentre educazione ambientale e scelte individuali (dieta, mobilità, consumi) aiutano a ridurre la domanda di carbonio.
Il settore dei trasporti va trasformato con mobilità elettrica e collettiva, biocarburanti avanzati e logistica efficiente. Negli edifici, isolamento, pompe di calore e gestione intelligente tagliano la domanda di energia. A livello urbano, verde pubblico e progettazione climatica attenuano le isole di calore e migliorano la resilienza.
Domande ricorrenti e chiarimenti rapidi
Il metano degli allevamenti pesa davvero? Sì: una parte rilevante delle emissioni agricole deriva dalla fermentazione enterica dei ruminanti e dalla gestione dei reflui. Nel contesto brasiliano questo contributo è particolarmente significativo.
Ridurre la CO2 serve anche per le piogge estreme? Limitare le concentrazioni di gas serra riduce l’energia disponibile nell’atmosfera e, nel tempo, abbassa l’intensità media degli eventi estremi, inclusi episodi di precipitazioni eccezionali.
L’effetto serra è “cattivo”? No: l’effetto serra naturale rende abitabile la Terra. Il problema è l’eccesso antropogenico che altera il bilancio radiativo e porta a cambiamenti climatici rapidi e diffusi.
Bilanciando le evidenze fisiche, gli impatti osservati e le responsabilità settoriali, emerge un quadro chiaro: il riscaldamento globale è principalmente causato dall’uomo attraverso l’aumento dei gas serra e viene amplificato da feedback come vapore acqueo, nuvole e perdita di ghiaccio. Le soluzioni esistono — dalla decarbonizzazione alla tutela delle foreste — ma richiedono decisioni rapide, collaborazione internazionale e un cambiamento concreto negli stili di produzione e consumo, affinché clima, ecosistemi e società possano mantenere nel tempo condizioni vivibili eque e stabili.