- Strategia UE: 40 GW di elettrolizzatori entro il 2030, obiettivi RED III per industria e trasporti e corridoi come il South H2 Corridor.
- Tecnologia e costi: elettrolisi alimentata da rinnovabili, innovazioni nelle MEA e calo dei costi verso la competitività.
- Applicazioni chiave: mobilità pesante, industria hard to abate, stoccaggio energetico e blending in rete gas.
- Italia e PNRR: Hydrogen Valley, 1 GW di elettrolisi entro il 2026, fondi a trasporti e ricerca con semplificazioni e GO.
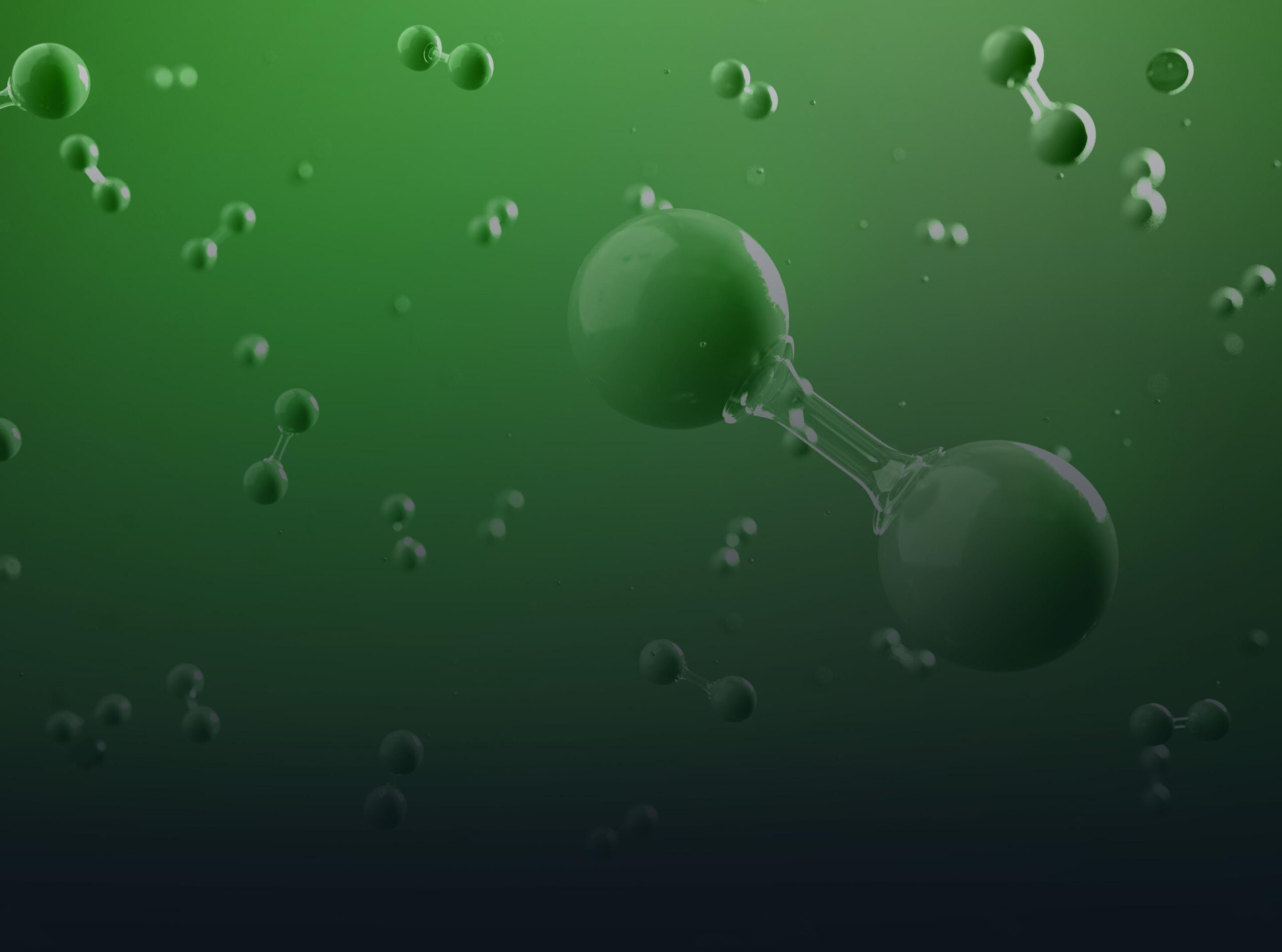
L’idrogeno verde è sulla bocca di tutti perché promette di tagliare le emissioni laddove l’elettrificazione diretta fatica ad arrivare; tra industria pesante, trasporti a lunga distanza e accumulo su larga scala, questo vettore può davvero cambiare gli equilibri energetici. In Europa, la spinta è fortissima: la Commissione europea ha abbracciato l’idrogeno rinnovabile come leva per la decarbonizzazione e la ripartenza sostenibile, una scelta che allinea politiche industriali e obiettivi climatici di lungo periodo.
Il quadro è ambizioso ma concreto: grazie ai progressi tecnologici e all’espansione delle rinnovabili, i costi stanno scendendo e le filiere si stanno organizzando. Dal 2030 al 2050 l’idrogeno verde è destinato a maturare, entrare a pieno titolo nei settori hard to abate e contribuire alla neutralità climatica, riducendo l’uso di combustibili fossili e integrandosi con reti, stoccaggi e mercato.
Cos’è l’idrogeno verde e perché conta
L’idrogeno verde è idrogeno prodotto via elettrolisi dell’acqua alimentata da elettricità rinnovabile, quindi senza emissioni di CO2 nel ciclo di produzione. A differenza dell’idrogeno grigio o blu, che derivano da gas naturale o carbone, la variante green nasce da eolico, solare o idroelettrico e quando brucia genera solo acqua, rendendolo un alleato chiave per la transizione energetica.
Non va confuso con altre tipologie: l’idrogeno grigio è ottenuto da metano con emissioni elevate, quello blu abbina cattura e stoccaggio della CO2 ma non elimina del tutto l’impronta. Quello verde, invece, è l’unico a impatto climatico nettamente ridotto lungo la filiera di produzione, ed è qui che l’Europa ha deciso di spingere con forza.
La strategia europea: obiettivi, mercati e neutralità al 2050
Con la Strategia europea sull’idrogeno varata nel 2020, Bruxelles ha fissato la rotta per creare mercati aperti e competitivi, partendo dall’installazione di almeno 40 GW di elettrolizzatori entro il 2030 e dall’ambizione di arrivare fino a 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotto. Questi target si inseriscono nella traiettoria di neutralità climatica al 2050 e negli impegni dell’Accordo di Parigi, puntando a contenere l’aumento della temperatura media globale ben sotto i 2 °C.
Il pacchetto Fit for 55 e la Direttiva RED III hanno alzato ulteriormente l’asticella: entro il 2030 almeno il 42% dell’idrogeno consumato nell’industria e il 5,5% dei carburanti nei trasporti dovranno provenire da idrogeno rinnovabile e derivati come gli e-fuels. La Commissione raccomanda di pianificare in modo integrato produzione, infrastrutture, stoccaggi e reti transfrontaliere, e progetti come il South H2 Corridor (oltre 3.300 km) collegheranno Nord Africa, Italia, Austria e Germania, portando grandi volumi di idrogeno green in Europa.
Come si produce: elettrolisi, efficienze e nuove strade
Il cuore tecnologico è l’elettrolizzatore, che separa l’acqua in idrogeno e ossigeno grazie alla corrente elettrica: l’anodo ossida gli ioni idrossido, il catodo riduce gli ioni idrogeno, generando H2 gassoso. Se l’elettricità è rinnovabile, l’intero ciclo è a emissioni quasi nulle, e l’idrogeno può essere raccolto e stoccato per usi successivi in mobilità, industria e power-to-gas.
Esistono diversi tipi di elettrolizzatori e filiere in evoluzione, ma un punto è chiave: l’elettrolisi richiede molta energia, quindi i costi dipendono in larga parte dal prezzo dell’elettricità rinnovabile e dall’efficienza della conversione. I progressi tecnologici stanno migliorando le prestazioni, ma oggi il ciclo elettricità-idrogeno-elettricità ha un’efficienza complessiva non elevata.
Una strada complementare ancora in sviluppo è l’elettroriduzione della CO2, che usa un elettrodo catalitico per convertire anidride carbonica e acqua in idrogeno e ossigeno. Questa tecnologia ERC è promettente ma necessita di ulteriori studi, investimenti e scalabilità prima di diventare competitiva, specie rispetto all’elettrolisi classica.
Il quadro industriale sta accelerando: molte realtà europee affiancano ai parchi eolici e solari sistemi di accumulo per alimentare la crescente capacità di elettrolisi. Q ENERGY, ad esempio, sta lavorando a soluzioni e partnership per accelerare l’introduzione di sistemi H2 green, valorizzando proprio l’integrazione fra rinnovabili e stoccaggi, così da fornire un flusso pulito e stabile agli elettrolizzatori.
Trasporto e stoccaggio: gas, liquido e vettori alternativi
L’idrogeno è il vettore più leggero e ha bassa densità volumetrica: questo impone attenzioni su compressione, sicurezza e logistica. In forma gassosa si trova tipicamente intorno ai 30 bar, ma per alcune applicazioni di mobilità si usano 500-900 bar. Lo stoccaggio in bombole o serbatoi cilindrici ad alta pressione è la soluzione più diffusa e conveniente rispetto alle alternative criogeniche.
La liquefazione richiede temperature vicine a -253 °C e circa 15 kWh per ogni chilo liquefatto, un processo energivoro e costoso. Su base costo per kg di capacità stoccata, il gas è da 10 a 25 volte meno costoso del liquido, sebbene quest’ultimo garantisca densità energetica superiore e quindi vantaggi in spazi molto ridotti o per trasporti su lunghissime distanze.
Esistono poi percorsi di conversione in altri vettori chimici (per esempio derivati sintetici), utili per la distribuzione o l’uso in settori specifici. In ogni caso, sicurezza e gestione del rischio sono centrali perché l’idrogeno è altamente infiammabile, motivo per cui standard, certificazioni e buone pratiche operative sono imprescindibili.
Nel breve periodo, una via pragmatica può essere l’iniezione di piccole percentuali di idrogeno nella rete di gas naturale, in modo da sfruttare infrastrutture esistenti riducendo gradualmente l’impronta carbonica. Questa opzione di blending è già al centro di sperimentazioni e norme tecniche in aggiornamento, con l’obiettivo di garantire affidabilità e compatibilità con gli impianti a valle.
Applicazioni: dove l’idrogeno verde fa davvero la differenza
La mobilità pesante è tra i primi ambiti di adozione: autobus a lunga percorrenza, treni non elettrificati, trasporto navale e logistica industriale sono casi d’uso in cui la densità energetica conta. Le celle a combustibile alimentate a idrogeno offrono rifornimenti rapidi e lunghe autonomie, elementi critici per flotte e servizi pubblici.
Nei processi industriali ad alta temperatura, come ceramica, cemento, carta e siderurgia, l’idrogeno può sostituire combustibili fossili e ridurre drasticamente le emissioni. Nell’industria chimica, inoltre, l’idrogeno è materia prima insostituibile per ammoniaca e fertilizzanti, e qui passare dal grigio al verde ha un impatto climatico immediato.
L’accumulo energetico è un altro tassello: quando la produzione rinnovabile eccede la domanda o la capacità di rete, si può convertire elettricità in idrogeno e usarlo in seguito. Questo power-to-gas stabilizza i sistemi elettrici con alta penetrazione di rinnovabili intermittenti, rendendo il sistema più flessibile e resiliente.
Non dimentichiamo poi gli usi stazionari per generazione elettrica locale o cogenerazione. In prospettiva, caldaie e sistemi termici a idrogeno potrebbero coprire porzioni dei fabbisogni di calore, specie dove non conviene l’elettrificazione diretta, anche se sono necessarie infrastrutture e standard ad hoc.
Il contesto globale e le aree con più potenziale
Regioni con grande abbondanza di sole e vento come Medio Oriente, Nord Africa e Australia stanno pianificando produzioni massicce di idrogeno rinnovabile per l’export. Anche in Europa, e in Italia in particolare, sono in corso iniziative per presidiare la filiera, spesso con progetti localizzati dove la risorsa rinnovabile è più competitiva.
Il Mezzogiorno ha carte importanti da giocare grazie a irraggiamento solare ed eolico favorevoli. Progetti come le Hydrogen Valley, ad esempio nell’area di Taranto, mirano a integrare produzione da rinnovabili con domanda industriale e trasporti locali, creando hub territoriali che accelerano l’adozione.
Numeri attuali e sfide di costo
Oggi circa il 95% dell’idrogeno globale è ancora prodotto con processi fossili come reforming del metano e gassificazione del carbone, tecnologie economiche ma climalteranti. L’idrogeno verde costa tuttora più del grigio, ma i trend di costo dell’elettrolisi e delle rinnovabili stanno cambiando rapidamente lo scenario, con riduzioni attese man mano che crescono scala e innovazione.
Le stime indicano cali marcati entro il 2030 grazie a economie di scala, nuove generazioni di elettrolizzatori e crollo dei costi dell’energia rinnovabile. Resta cruciale migliorare l’efficienza dei cicli e ridurre i CAPEX dei componenti chiave, così da spingere la competitività rispetto ai combustibili fossili e all’idrogeno tradizionale.
Innovazione industriale: il ruolo delle MEA e il caso UFI Hydrogen
Nel cuore di elettrolizzatori e celle a combustibile ci sono le Membrane Electrode Assembly, o MEA, che determinano prestazioni ed efficienza. In Italia, UFI Hydrogen ha aperto a Serravalle, in Trentino, un polo da 14.000 metri quadrati con un investimento iniziale di 50 milioni di euro per produrre MEA, frutto di sette anni di ricerca e sviluppo e un team internazionale di alto profilo.
Le tecnologie MEA stanno evolvendo verso una seconda generazione con drastica riduzione dell’iridio: da 3-4 mg per centimetro quadrato a 0,5 con obiettivo 0,1. Tagliare il contenuto di materiali critici abbatte costi e impatto ambientale, facilitando la scalabilità; l’azienda realizza anche soluzioni taylor made, vestendo su misura esigenze di produzione e di applicazione.
UFI Hydrogen è partner del South H2 Corridor e del Piano Mattei in Tunisia, sostenendo un impianto pilota per l’Europa, ed è stata ammessa all’IPCEI Hy2Move con circa 22 milioni di euro di finanziamento. L’iniziativa coinvolge 11 partner in 7 Paesi dell’UE per sviluppare membrane di nuova generazione destinate a treni, navi, aviazione, droni e data center, con una previsione di oltre 3.600 nuovi posti di lavoro in Europa e quasi un centinaio in Italia.
Questa filiera, mettendo insieme materiali avanzati, manifattura e integrazione di sistema, dimostra come si possa costruire in Italia un ponte concreto tra rinnovabili e industria. L’obiettivo è chiaro: produrre localmente, ridurre il costo dei componenti, integrare reti e stoccaggi e accelerare le infrastrutture per fare dell’idrogeno verde una realtà su scala.
PNRR e misure italiane: investimenti, riforme e domanda
Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la componente su energia rinnovabile, idrogeno, reti e mobilità sostenibile prevede 23,78 miliardi PNRR più 1,40 miliardi dal Piano Complementare. Le misure includono un grande impianto industriale per elettrolizzatori da 450 milioni per arrivare a circa 1 GW entro il 2026, dieci Hydrogen Valley con 500 milioni, e varie sperimentazioni nei trasporti.
Per la mobilità sono previsti 300 milioni per il ferroviario con 50 nuovi treni e 100 carrozze a propulsione elettrica e a idrogeno, oltre a 230 milioni per il trasporto stradale con 40 stazioni di rifornimento. Nel manifatturiero hard to abate sono stanziati 2 miliardi, mentre 160 milioni vanno a ricerca e sviluppo su produzione, stoccaggio e distribuzione per abbassare i costi e aumentare la competitività.
Accanto ai fondi ci sono riforme per semplificare e abilitare il mercato: norme tecniche di sicurezza, riduzione degli oneri amministrativi per piccoli impianti, regole per la partecipazione ai servizi di rete e un sistema di garanzie di origine per l’idrogeno rinnovabile. Questi strumenti aiutano a creare fiducia, trasparenza e segnali di prezzo per i consumatori, stimolando produzione e consumo nei trasporti e non solo.
Il risultato atteso è un ecosistema in cui offerta e domanda crescono di pari passo. Nel frattempo sono in corso piloti territoriali, inclusi quelli nel Sud Italia, dove la risorsa rinnovabile è più favorevole e si possono creare poli produttivi connessi a industrie e servizi locali.
Emilia-Romagna: scenari regionali e priorità
Uno studio ART-ER con Nomisma e Clust-ER Greentech ha stimato l’evoluzione della domanda regionale di idrogeno verde. In due scenari, base e ambizioso, la penetrazione al 2030 resta contenuta (circa 2% e 4%), ma diverge molto nel lungo periodo: nello scenario base si arriva all’8,5% nel 2050, mentre in quello ambizioso si tocca il 9,5% già nel 2040 per poi raggiungere il 31% nel 2050.
Per soddisfare tali fabbisogni, serviranno nuova capacità fotovoltaica e superfici disponibili. Il documento evidenzia le necessità in termini di potenza e area al 2030 e 2040, in funzione degli scenari, sottolineando quanto sia cruciale la pianificazione territorio-energia.
| Indicatore | 2030 (base/ambizioso) | 2040 (base/ambizioso) |
|---|---|---|
| Consumi di idrogeno totali previsti [ktep] | Valori stimati ART-ER | Valori stimati ART-ER |
| Potenza fotovoltaica necessaria [GW] | Dipende dallo scenario | Dipende dallo scenario |
| Superficie necessaria [ha] | Dipende dallo scenario | Dipende dallo scenario |
Stima della potenza fotovoltaica e della superficie per produrre idrogeno verde a copertura della domanda al 2030 e 2040. Fonte: ART-ER, 2022
L’ecosistema dell’innovazione regionale ha già competenze avanzate su ricerca, sviluppo, produzione e test applicativi, con università, centri di ricerca e imprese attivi nella Rete Alta Tecnologia e nei Clust-ER. Sono stati avviati progetti pilota di blending H2-gas naturale nella mobilità e nel riscaldamento, segnale di un percorso che punta a candidare l’Emilia-Romagna tra le Hydrogen Valley italiane.
Pro e contro: cosa funziona oggi e cosa migliorare
I vantaggi sono chiari: emissioni zero in produzione e uso se l’elettricità è rinnovabile, versatilità di applicazione e capacità di accumulo stagionale. Inoltre, l’idrogeno è un vettore che collega in modo flessibile produzione rinnovabile e consumo finale, aiutando a stabilizzare sistemi elettrici ad alta penetrazione di eolico e solare.
Le sfide riguardano costi, infrastrutture, efficienza e sicurezza. L’idrogeno verde è ancora più caro dei combustibili fossili e dell’idrogeno grigio, e richiede reti, stazioni di rifornimento, standard tecnici e normative adeguate. Anche il ciclo elettricità-idrogeno-elettricità comporta perdite non trascurabili, motivo per cui è importante destinare l’H2 ai casi in cui è davvero imprescindibile.
La curva di apprendimento, però, è ripida: la riduzione del costo dell’elettricità rinnovabile e l’innovazione nei componenti stanno migliorando la competitività. Gli incentivi, i progetti IPCEI e le riforme di mercato europee stanno accelerando la creazione di una filiera, con benefici attesi in termini di occupazione, export tecnologico e sicurezza energetica.
Mercati, standard e garanzie di origine
Perché un mercato dell’idrogeno funzioni servono regole chiare: definizioni di idrogeno rinnovabile, requisiti per i carburanti RFNBO, tracciabilità e certificazione. Il sistema di garanzie di origine per l’idrogeno rinnovabile attribuisce un valore alla qualità ambientale, segnalando ai consumatori il contenuto green del prodotto e aprendo la strada a contratti a lungo termine.
Le reti e gli hub logistici richiedono coordinamento transfrontaliero, pianificazione di stoccaggi e rigassificatori dedicati e sviluppo di pipeline compatibili. Il South H2 Corridor è un tassello strategico per collegare aree a basso costo di produzione con i centri di domanda industriale, integrando produzione onshore e offshore (anche da rinnovabili marine) e aumentando la resilienza del sistema europeo.
Italia sul campo: progetti, territori e casi d’uso
Oltre ai fondi PNRR, stanno nascendo iniziative pubblico-private che uniscono impianti rinnovabili, elettrolizzatori, domanda industriale e rifornimento per i trasporti. A Taranto, ad esempio, la Hydrogen Valley mira a servire industrie locali e trasporto pubblico con idrogeno prodotto da rinnovabili, un modello replicabile in altre aree del Paese.
Nel settore ferroviario, i progetti pilota puntano a decarbonizzare tratti non elettrificati con convogli fuel cell, mentre il trasporto su gomma pesante guarda a stazioni di rifornimento corridoio. Nel manifatturiero i primi utilizzi riguardano calore di processo e la sostituzione dell’idrogeno grigio in chimica, creando domanda stabile che aiuta la bancabilità degli impianti.
Dalla ricerca al mercato: competenze, formazione e consapevolezza
La transizione richiede non solo tecnologia, ma anche capitale umano qualificato, standard professionali e filiere locali. Università, centri di ricerca e imprese stanno formando nuove competenze lungo tutta la catena del valore, dalle MEA alla gestione di impianti e sicurezza, con programmi dedicati e partenariati europei.
La consapevolezza di cittadini e imprese, insieme a procedure autorizzative snelle ma rigorose, è altrettanto essenziale. Semplificazioni amministrative mirate possono accelerare i piccoli impianti di produzione distribuita, mentre criteri tecnici moderni garantiscono sicurezza e interoperabilità.
Integrare rinnovabili, elettrolizzatori e storage: la chiave di sistema
Il valore dell’idrogeno verde cresce quando si integra con fotovoltaico, eolico e sistemi di accumulo, ad esempio utilizzando l’overgeneration o il curtailment per alimentare gli elettrolizzatori. Questa sinergia rende più efficiente ogni kWh rinnovabile prodotto e aumenta la sostenibilità economica degli impianti, sbloccando nuova capacità eolica e solare.
Nel tempo, la combinazione tra riduzione dei CAPEX, miglioramento dell’efficienza e tariffe energetiche competitive permetterà di avvicinare i costi del verde a quelli delle alternative fossili. L’innovazione su compressione elettrochimica, purificazione e trasporto completerà il quadro, dando vita a catene del valore più corte e resilienti.
Guardando l’insieme, l’idrogeno verde si sta affermando come molecola ponte tra rinnovabili e industria: il quadro europeo definisce obiettivi chiari, l’Italia investe con il PNRR e progetti territoriali, la ricerca spinge su componenti cruciali come le MEA, e le applicazioni concrete crescono dalla mobilità pesante alla chimica, fino allo stoccaggio. Restano da chiudere i gap di costo, infrastruttura ed efficienza, ma la traiettoria è tracciata e i progressi sono tangibili, con benefici attesi su clima, competitività e sicurezza energetica dell’intero sistema.