- Proprietà intensive: non dipendono dalla quantità (T, p, densità, punti di fase) e sono ideali per descrivere lo stato e identificare sostanze.
- Proprietà estensive: dipendono dalla massa/scala (m, V, peso, energia, C); servono per bilanci e scalaggio di processi.
- Rapporti di estensive → intensivi: densità (m/V), volume specifico (V/m), volume molare (V/n), grandezze specifiche e molari (h, s, Cp, CV).
- Esempi numerici: ghiaccio 0,92 g/cm3, acqua ~1,0 g/cm3; p atm ~1013 hPa; n(diamante) ≈ 2,42; γ acqua ~72,75×10-3 N/m.
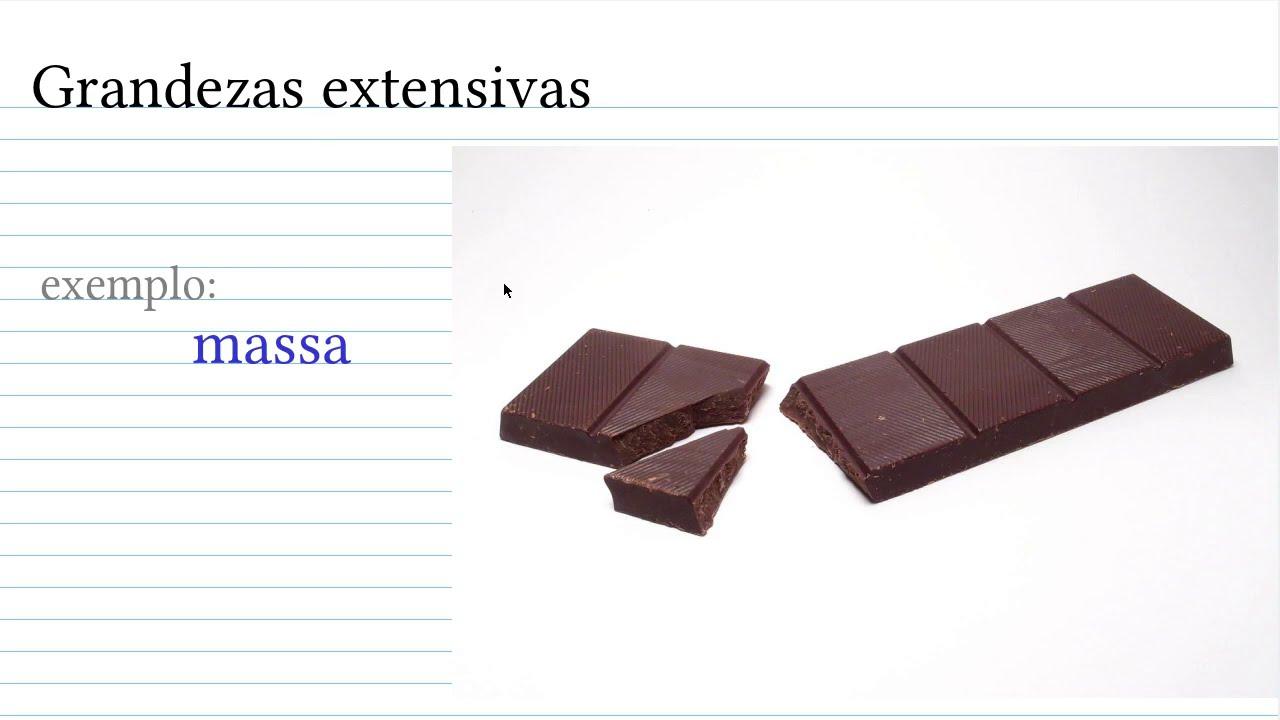
La materia può essere descritta e riconosciuta attraverso due grandi famiglie di proprietà: fisiche e chimiche. Le proprietà chimiche riguardano la capacità di trasformarsi in nuove sostanze (per esempio, combustione o ossidazione), mentre le proprietà fisiche si misurano senza cambiare la composizione del materiale. Rientrano tra le proprietà fisiche grandezze come massa, volume, temperatura, densità, punti di fusione ed ebollizione, stato di aggregazione (solido, liquido, gassoso) e proprietà organolettiche come colore, odore, sapore e durezza.
Una classificazione utilissima in fisica, chimica e termodinamica distingue le proprietà fisiche in due categorie a seconda della dipendenza dalla quantità di campione considerata. Le proprietà intensive non dipendono dalla massa o dalla dimensione del sistema (cioè rimangono invariate al variare della quantità), mentre le proprietà estensive dipendono dall’«estensione» del sistema (crescono o diminuiscono proporzionalmente alla quantità di materia). Questa distinzione è più che teorica: consente di identificare sostanze, confrontare campioni e impostare calcoli tecnici in ingegneria e scienze dei materiali.
Proprietà intensive: definizione e caratteristiche
Nella pratica di laboratorio e nell’uso quotidiano, è facile imbattersi in grandezze che non cambiano se prendiamo più o meno campione. La temperatura è un esempio tipico di proprietà intensiva: se misuriamo l’acqua che bolle in una pentola e poi ne versiamo un po’ in un bicchiere, il termometro segnerà lo stesso valore in entrambe le misurazioni, a parità di condizioni. Lo stesso vale per i punti di fusione ed ebollizione, che sono caratteristici di ciascuna sostanza e non dipendono dalla quantità presente.
Un altro caso fondamentale è la densità, definita come massa per unità di volume. Pur essendo il rapporto tra due proprietà estensive (massa e volume), la densità è intensiva, perché se raddoppiamo la massa raddoppia anche il volume occupato e il loro quoziente resta costante per una data sostanza e a determinate condizioni di temperatura e pressione.
Molte altre proprietà rientrano tra le intensive: pressione (ad esempio la pressione atmosferica locale), colore, odore e sapore (proprietà organolettiche che non cambiano con la dimensione del campione), indice di rifrazione, tensione superficiale, elasticità e concentrazione di una soluzione. Queste grandezze sono impiegate sia per caratterizzare sia per riconoscere i materiali, proprio perché non dipendono dalla quantità.
In termodinamica è comune incontrare proprietà intensive ottenute da estensive tramite normalizzazione: per esempio, proprietà molari (per mole) o proprietà specifiche (per unità di massa). Questa operazione trasforma grandezze come entalpia o entropia, intrinsecamente estensive, in misure intensive riferite a una «quantità standardizzata». Questa strategia facilita confronti e calcoli, indipendentemente dalla scala del sistema.
Esempi chiave di proprietà intensive
Per orientarsi meglio, ecco una selezione di proprietà intensive molto utili, con definizioni concise ed esempi numerici dove possibile. Ogni voce mette in risalto un aspetto pratico impiegato in chimica, fisica e in applicazioni tecnologiche.
- Temperatura: misura lo stato termico di un sistema. Esempio: un campione d’acqua a 32 °C resta a 32 °C sia che siano 200 cm3 sia che siano 2 L, a condizioni identiche. La misura non dipende dalla quantità.
- Punto di ebollizione: temperatura alla quale la pressione di vapore del liquido uguaglia la pressione esterna. Per l’acqua al livello del mare vale circa 100 °C. La soglia non cambia con la massa del campione.
- Punto di fusione: temperatura alla quale un solido diventa liquido. Per l’acqua, fusione e solidificazione sono a 0 °C in condizioni standard, ma esistono eccezioni: l’agar-agar fonde a circa 85 °C e solidifica tra 31 e 40 °C. Valore caratteristico della sostanza.
- Pressione: forza per unità di superficie. La pressione atmosferica si esprime spesso in hPa; un valore tipico a livello del mare è 1013 hPa. Proprietà locale e intensiva.
- Densità (m/V): massa per unità di volume. Esempio: la densità del ghiaccio è circa 0{,}92 g/cm3 (a T < 0 °C), mentre quella dell’acqua è circa 1{,}0 g/cm3 (a ~4 °C). Il ghiaccio galleggia proprio per questa differenza.
- Volume specifico (v): volume per unità di massa (v = V/m), grandezza inversa della densità. Per l’acqua a 20 °C, v è circa 0{,}001002 m3/kg. Intensiva per definizione.
- Concentrazione: rapporto tra quantità di soluto e quantità di solvente (o volume della soluzione). Maggiore è il soluto per la stessa quantità di solvente, più è concentrata la soluzione. Restituisce informazione indipendente dalla scala assoluta.
- Indice di rifrazione (n): rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e quella nel mezzo. Esempi: n(vuoto) = 1; n(aria) ≈ 1{,}0002926; n(diamante) ≈ 2{,}42. Identificativo ottico molto impiegato.
- Tensione superficiale: forza tangenziale per unità di lunghezza sul bordo della superficie del liquido. Esempi: acqua ≈ 72{,}75 × 10-3 N/m; acetone ≈ 23{,}70 × 10-3 N/m; etanolo ≈ 22{,}75 × 10-3 N/m. Spiega fenomeni come le gocce che si formano.
- Elasticità: capacità di un materiale di ritornare alla forma originale dopo una deformazione. Indipendente dalla massa in gioco, ma legata alla microstruttura del materiale.
- Colore e sapore: proprietà organolettiche; in ambito chimico il sapore si valuta raramente per motivi di sicurezza, ma appartiene comunque alle intensivi.
Proprietà estensive: che cosa cambia con la quantità
Le proprietà estensive sono quelle che dipendono dall’estensione del sistema. Se raddoppiamo la quantità di materia, raddoppiano anche i loro valori. Sono fondamentali per bilanci di materia ed energia, per stime di scala e per la progettazione di processi.
La massa è la misura dell’inerzia di un corpo e della quantità di sostanza; il volume quantifica lo spazio occupato in tre dimensioni; il peso è la forza gravitazionale su un corpo, quindi cambia con il campo gravitazionale anche se la massa resta la stessa (sulla Luna il peso è minore). Tutte e tre sono grandezze estensive e crescono con la dimensione del campione.
Rientrano tra le estensive anche energia potenziale (dipendente da massa, posizione e, in generale, dalle forze in gioco), inerzia (intesa come resistenza al cambiamento dello stato di moto di un sistema), estensione lineare (lunghezza) e capacità termica o calorifica (quantità di calore necessaria per variare di 1 K la temperatura di un corpo). Maggiore è il sistema, maggiore sarà il valore di queste grandezze a parità di condizioni.
Esempi quotidiani aiutano a visualizzare il concetto: 1 kg di cotone occupa un volume molto più grande di 1 g di cotone; durante una combustione, l’energia liberata da un singolo fiammifero è assai inferiore a quella sprigionata da una catasta di legna. In entrambi i casi, aumentando la quantità di materia aumenta la proprietà misurata.
In termini di misure operative, la capacità termica totale C cresce con la massa: serve più calore per scaldare 1 litro d’acqua di quanto ne serva per mezzo litro. Da qui l’utilità di passare a grandezze intensive come il calore specifico, ottenuto per unità di massa o di mole, per confronti diretti tra materiali.
Proprietà derivate: quando un rapporto di estensive diventa intensivo
Una regola pratica potentissima è che il rapporto (o il quoziente) tra proprietà estensive genera spesso una proprietà intensiva. La densità ne è il caso più noto: ρ = m/V è indipendente dalla dimensione del campione per una data sostanza e a date condizioni. Lo stesso accade per il volume specifico v = V/m, che è l’inverso della densità, e per il volume molare Vm = V/n, riferito a una mole.
In termodinamica classica, molte grandezze fondamentali sono estensive: energia interna (U), entalpia (H), entropia (S), energia di Gibbs (G). Dividendo per la massa o per le moli otteniamo grandezze intensive come entalpia specifica (J·kg-1), entalpia molare (J·mol-1), entropia specifica (J·K-1·kg-1) ed entropia molare (J·K-1·mol-1). Questa normalizzazione consente di confrontare materiali e processi in modo indipendente dalla scala.
Lo stesso principio vale per la capacità termica: la capacità termica totale C è estensiva, mentre il calore specifico cp o cv (per unità di massa) e la capacità termica molare Cp o CV (per mole) sono intensive. Queste grandezze ottimizzano calcoli e confronti in progettazione termica, processi chimici e scambio termico.
Densità: il caso emblematico e perché è intensiva
Chiarire perché la densità è intensiva aiuta a fissare il concetto. Per definizione, densità = massa/volume. Se prendiamo un campione di sostanza e raddoppiamo la massa mantenendo costante la sostanza e le condizioni, il volume occupato raddoppia, e il rapporto rimane invariato. Questo vale sia che si considerino piccoli campioni sia grandi quantità dello stesso materiale.
Esempio celebre: il ghiaccio ha densità circa 0{,}92 g/cm3, mentre l’acqua liquida circa 1{,}0 g/cm3 (alla temperatura di massima densità, ~4 °C). Ciò spiega perché un cubetto di ghiaccio e un iceberg, pur avendo masse e volumi enormemente diversi, galleggiano entrambi: la densità del ghiaccio resta la stessa e rimane inferiore a quella dell’acqua circostante.
Il ragionamento si applica a qualsiasi sostanza pura alle stesse condizioni: cambiando la quantità non si altera la densità. Questo rende la densità uno strumento pratico per identificare materiali e controllarne la purezza confrontando misure con tabelle di riferimento (tenendo conto di temperatura e pressione, che influenzano le grandezze).
La densità non è l’unica proprietà di questo tipo: anche il volume specifico v = V/m è intensivo e spesso più comodo in ambito termico, poiché molte equazioni dei gas e dei fluidi lo utilizzano direttamente. La scelta tra ρ e v è spesso una questione di comodità nel modello o nel problema trattato.
Punti di fusione ed ebollizione: firme termiche delle sostanze
I punti di fusione e di ebollizione sono tra le prime «impronte digitali» di una sostanza pura. Per l’acqua, il punto di fusione è 0 °C e quello di ebollizione 100 °C al livello del mare; questi valori non variano con la quantità di campione. Essi possono variare con la pressione esterna (per questo indicare le condizioni è cruciale), ma, a condizioni fissate, costituiscono valori caratteristici.
L’agar-agar mostra come possano esistere eccezioni interessanti: fonde intorno a 85 °C ma solidifica già tra 31 e 40 °C. Questo comportamento anomalo è dovuto alla struttura del materiale e alle transizioni di fase coinvolte; rimane comunque intensivo, perché non dipende dalla massa del campione.
In laboratorio, misurare con accuratezza questi punti consente di identificare o verificare la purezza dei composti. Impurezze, infatti, tendono a abbassare e allargare l’intervallo di fusione, fornendo un indizio sulla qualità del campione testato.
Pressione, indice di rifrazione e tensione superficiale: tre intensivi cruciali
La pressione è l’azione della forza per unità di area e svolge un ruolo centrale in fluidodinamica e meteorologia. Un valore di riferimento molto usato è 1013 hPa per la pressione atmosferica media al livello del mare. È una proprietà intensiva locale, utile per descrivere lo stato del sistema senza riferimento alla sua massa complessiva.
L’indice di rifrazione fornisce una misura ottica dell’interazione tra luce e materiale: vale 1 nel vuoto, circa 1{,}0002926 nell’aria, 1{,}33 nell’acqua e 2{,}42 nel diamante. Poiché non dipende dalla quantità di materiale, è perfetto per identificazioni ottiche e per la progettazione di lenti e rivestimenti antiriflesso.
La tensione superficiale governa fenomeni come la forma sferica delle gocce e il galleggiamento di piccoli insetti sull’acqua. Valori tipici: acqua ≈ 72{,}75 × 10-3 N/m, acetone ≈ 23{,}70 × 10-3 N/m, etanolo ≈ 22{,}75 × 10-3 N/m. Differenze di pochi millinewton per metro possono produrre effetti macroscopici evidenti.
Massa, volume, peso ed energia: lo zoccolo duro delle estensive
Massa e volume sono le estensive più intuitive: sommare due campioni somma le loro masse e i loro volumi (tranne nei casi di miscelazione non ideale, ma il concetto generale resta valido). Il peso dipende dal campo gravitazionale: è perciò una forza e varia da pianeta a pianeta, pur mantenendo invariata la massa.
Energia potenziale legata alla posizione in un campo (gravitazionale, elettrico, ecc.) è anch’essa estensiva: più massa o più «altezza» significano più energia accumulata. Lo stesso vale per l’inerzia, intesa come proprietà di opporsi ai cambiamenti di moto, che cresce con la massa.
La capacità termica totale (o calorifica) misura il calore necessario a variare di 1 K la temperatura di un corpo: con più materia occorre più energia per ottenere lo stesso incremento di temperatura. Per questo si usano spesso il calore specifico e quello molare, che sono intensivi e comparabili tra diverse sostanze e campioni.
Infine, tra le estensive si menzionano comunemente la quantità di sostanza (moli, n), l’energia interna U, l’entalpia H, l’entropia S e l’energia di Gibbs G. Tutte queste grandezze dipendono dalla scala del sistema e vengono convertite in forme intensive dividendo per massa o per moli quando serve il confronto tra materiali o condizioni diverse.
Soluzioni, concentrazione e proprietà organolettiche
Nelle soluzioni è molto utile ragionare in termini di concentrazione, una proprietà intensiva definita dal rapporto tra quantità di soluto e quantità di solvente (o volume totale). Aumentando il soluto rispetto al solvente, la soluzione diventa più concentrata; diminuendo il soluto, più diluita. Questo parametro non dipende dalla scala ed è perfetto per ricette, protocolli e controllo qualità.
Tra le proprietà fisiche di rapida valutazione rientrano anche colore, odore e sapore. In chimica analitica moderna il sapore quasi non si usa per motivi di sicurezza, ma resta una proprietà intensiva ben definita e, in contesti alimentari, di immediata utilità per la caratterizzazione sensoriale.
Differenze operative tra grandezze specifiche e molari
Quando si passa da proprietà estensive a forme intensive, si adottano due strade comuni: per unità di massa (specifiche) o per mole (molari). Le prime hanno unità per chilogrammo (ad esempio J·kg-1, J·K-1·kg-1), le seconde per mole (J·mol-1, J·K-1·mol-1). La scelta dipende dal contesto: in ingegneria di processo si preferiscono spesso grandezze specifiche, mentre in chimica pura sono comuni le molari.
Esempi: entalpia specifica h (J·kg-1), entropia specifica s (J·K-1·kg-1), entalpia molare Hm (J·mol-1), entropia molare Sm (J·K-1·mol-1), capacità termica specifica cp o cv (J·K-1·kg-1) e capacità termica molare Cp o CV (J·K-1·mol-1). Queste forme sono tutte intensive e risultano comode per confronti trasversali.
Uso pratico delle proprietà per il riconoscimento delle sostanze
In analisi e controllo qualità, combinare più proprietà intensive è il modo più affidabile per identificare una sostanza: densità, punto di fusione, punto di ebollizione, indice di rifrazione, colore e odore, oltre a dati come la tensione superficiale quando pertinente. Ogni proprietà aggiunge un tassello, riducendo la possibilità di falsi positivi.
Nei processi industriali, sapere quali proprietà siano intensive o estensive consente di scalare correttamente una ricetta o un impianto. Le estensive servono per tutto ciò che si somma (bilanci di materia ed energia), le intensive servono per definire lo stato e per confrontare materiali o miscele. Questo doppio sguardo è essenziale nella progettazione e nell’ottimizzazione.
Anche in didattica, distinguere questi concetti evita errori frequenti: scambiare il peso per la massa, confondere densità con massa o volume, o usare impropriamente punti di ebollizione senza specificare le condizioni. Chiarezza terminologica = calcoli corretti.
Un ultimo consiglio operativo: quando un valore sembra cambiare solo perché «abbiamo preso più campione», con ogni probabilità stiamo misurando un’estensiva. Se invece il valore resta uguale (a parità di condizioni), allora è quasi certamente un’intensiva. Questo «test mentale» rapido aiuta a classificare le grandezze sul campo.
Le proprietà intensive descrivono lo stato della materia indipendentemente dalla quantità (temperatura, pressione, densità, punti di fusione/ebollizione, indice di rifrazione, tensione superficiale, elasticità, concentrazione), mentre le proprietà estensive crescono con la dimensione del sistema (massa, volume, peso, energia potenziale, inerzia, estensione lineare, capacità termica, quantità di sostanza, U, H, S, G). I rapporti appropriati tra estensive generano intensivi, come densità, volume specifico, volume molare e tutte le forme specifiche/molari delle grandezze termodinamiche, fornendo strumenti versatili per analisi, progettazione e identificazione dei materiali.
