- La legge di Newton unifica caduta dei corpi e moti celesti con F=G·M·m/r², dopo secoli di idee da Aristotele a Keplero.
- Tradizioni indiane e mondo arabo prepararono linguaggio e concetti (gurutvakarshan, gravis, thiql) che confluirono nella sintesi moderna.
- Cavendish misurò G con la bilancia di torsione; Einstein reinterpretò la gravità come curvatura dello spazio-tempo.

La gravità sembra così naturale che spesso non ci facciamo caso, eppure è una delle idee più potenti mai concepite dalla mente umana. fenomeni quotidiani e dinamiche cosmiche. In questo viaggio ripercorriamo come ci si è arrivati: dalla filosofia antica alle intuizioni scientifiche moderne, fino alla formulazione matematica che ha rivoluzionato per sempre la fisica.
Nel Seicento, Sir Isaac Newton riuscì a unificare il cielo e la Terra sotto un’unica legge. curiosità e osservazione, anche se gli storici suggeriscono che sia più mito che cronaca. Quello che conta davvero è il percorso: domande semplici, calcoli ingegnosi, confronto con risultati precedenti, e l’audacia di proporre una legge universale.
La leggenda della mela e ciò che sappiamo davvero
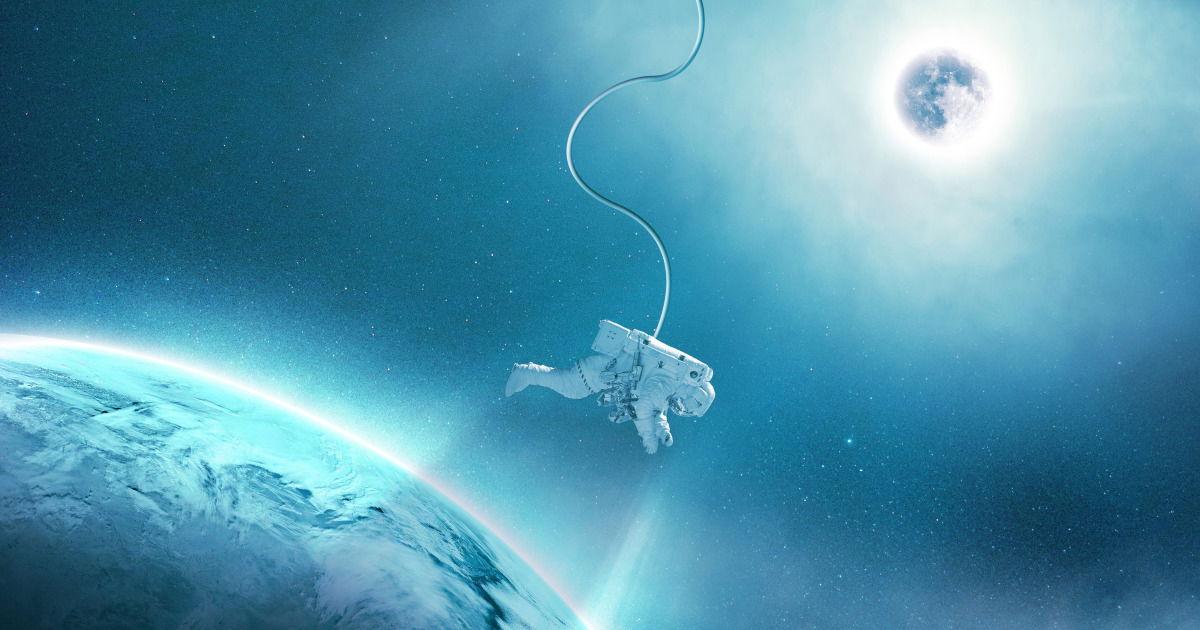
Secondo un racconto riportato solo decenni dopo, Newton avrebbe riflettuto sulla gravità osservando una mela che cadeva nel giardino di Woolsthorpe. William Stukeley. Non c’è prova che la mela gli sia caduta in testa; l’episodio funziona piuttosto da metafora: uno sguardo al quotidiano capace di accendere lampi di teoria.
Al netto del folclore, l’idea chiave è limpida: idea chiave. Newton impiega anni per dare forma matematica a questa intuizione, confrontandola con le leggi di Keplero e con i dati disponibili, fino a ottenere un principio quantitativo che lega masse e distanza.
Prima di Newton: Aristotele e i “luoghi naturali”
Nell’antichità, l’interpretazione più influente fu quella aristotelica. ‘luogo naturale’. Il mondo aveva un centro, la Terra, e i corpi pesanti cadevano perché ricercavano quel centro. Questa cornice concettuale, pur non corrispondendo alla fisica moderna, ha dominato per secoli scuole e università, fornendo una base logica e coerente al sapere del tempo.
L’idea che il comportamento dei corpi derivasse da ‘tendenze’ era così consolidata che persino quando la ricerca fece passi avanti, linguaggio dei ‘luoghi naturali’. Solo con la rivoluzione scientifica, tra Rinascimento e Seicento, si affermarono nuovi schemi concettuali in grado di sostituire definitivamente quella visione.
Intuizioni antiche in India e trasmissione araba: dal ‘gurutvakarshan’ al ‘gravis’
Molto prima di Newton e perfino di Aristotele, in tradizioni filosofiche indiane compaiono tracce di un’attrazione cosmica. forza cosmica. Nella scuola Vaisheshika, il saggio Kaṇāda (VI sec. a.C.) legava il ‘peso’ alla caduta, una intuizione che, pur lontana dalla fisica moderna, puntava nella giusta direzione concettuale.
Interessante anche la storia delle parole. In sanscrito si incontra ‘gurutvakarshan’: gurutvakarshan. In latino si afferma ‘gravis’, da cui ‘gravità’. Dal mondo arabo arrivarono in Europa traduzioni e testi che, dall’VIII secolo, consolidarono l’uso erudito di termini legati al ‘peso’. Le prime università (Bologna, Parigi, Oxford) contribuirono a diffondere questa nomenclatura, preparando il terreno linguistico su cui si innestò poi la fisica newtoniana.
Tra tardoantico e Medioevo: impeto, inerzia e nuove idee
Nel mosaico pre-newtoniano non mancarono proposte originali. al-Kindī, una visione qualitativa di forze che si propagano e interagiscono con la materia. Più tardi, Solomon Ibn Gabirol ragionò su perché certi corpi più pesanti sembrassero più ‘restii’ al movimento, anticipando l’idea di inerzia.
Un contributo notevole arrivò da ʿAbd al-Raḥmān al-Khāzinī, al-Khāzinī. Nel frattempo, Giovanni Filopono (Iohannes Philoponus) propose una teoria dell’impeto: quando lanci un oggetto, una ‘forza motrice’ impressa dal lanciatore ne sostiene il moto e poi si dissipa. Per la caduta, riconobbe però un’azione della Terra che richiama i corpi verso il suo centro.
Non tutti erano concordi: Jean Buridan avanzò una spiegazione alternativa basata su una spinta interna che conduceva i corpi verso il basso, pur senza identificarne la causa. In età rinascimentale, Leonardo da Vinci collegò la velocità di caduta a densità e resistenza dell’aria, mentre Galilei stabilì con esperimenti e ragionamenti che in assenza di attrito tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione. Nessuno di loro, comunque, arrivò a una legge universale applicabile al cielo e alla Terra insieme.
La svolta newtoniana: dall’intuizione alla legge
Fra il 1665 e il 1666, durante la chiusura di Cambridge per la peste, Newton tornò a Woolsthorpe e si immerse nello studio. accelerazione della Luna, abbozzando stime preliminari. Servirono anni per raffinare calcoli e ipotesi, ma il filo conduttore era semplice e audace: una stessa forza agisce ovunque.
Affidandosi alle leggi di Keplero e spingendo l’analisi matematica, dipendenza 1/r². Parallelamente indagò le maree, la forma della Terra, il problema dei tre corpi e altri fenomeni. Nel 1687 pubblicò i Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, fissando le leggi del moto e la legge di gravitazione universale: F = G·M·m / r². La materia attrae materia in proporzione alle masse e inversamente al quadrato della distanza.
Forza gravitazionale, masse e costante G
La legge di Newton consente di calcolare la forza tra due corpi una volta note le masse e la distanza tra i loro centri. costante G, un numero minuscolo che spiega perché tra oggetti ordinari la forza sia impercettibile.
Il valore di G fu misurato alla fine del Settecento da Henry Cavendish con una bilancia di torsione: esperimento di Cavendish. Da non confondere G con g: la minuscola indica la accelerazione di gravità locale, che sulla Terra è circa 9,80665 m/s² ma non uniforme, perché il pianeta non è una sfera perfetta.
Newton differenziava tra massa inerziale (resistenza ai cambiamenti di moto) e massa gravitazionale (capacità di attrarre/essere attratti). principio di equivalenza, dove la gravità emerge come curvatura dello spazio-tempo indotta dalla massa-energia.
Gravità terrestre, altri pianeti e il respiro delle maree
La gravità determina il peso (forza) avvertito da un corpo su un pianeta: peso cambia con g. Ecco alcuni valori tipici dell’accelerazione di gravità in m/s²:
| Corpo celeste | g (m/s²) |
|---|---|
| Sole | 273,42 |
| Mercurio | 3,78 |
| Venere | 8,60 |
| Terra | 9,80 |
| Marte | 3,72 |
| Giove | 24,8 |
| Saturno | 10,5 |
| Urano | 8,5 |
| Nettuno | 10,8 |
| Plutone | 5,88 |
| Luna | 1,67 |
Sulla Luna, per esempio, un astronauta pesa circa un sesto rispetto alla Terra. maree, oscillazioni periodiche del livello del mare che variano in ampiezza e frequenza secondo la latitudine e la morfologia costiera.
In molte coste (come in ampie zone del Brasile) si registrano due alte e due basse maree al giorno; ampiezza di marea. I massimi di alta marea e i minimi di bassa marea definiscono l’ampiezza di marea. Le escursioni maggiori si osservano in prossimità di Luna nuova e piena, mentre diminuiscono intorno ai quarti: è la danza regolare impressa dalla gravità celeste ai nostri oceani.
Gravità, accelerazione e relatività: dall’equivalenza alla curvatura
La fisica classica descrive il moto come risposta alle forze; per Newton, gravità e accelerazione. Con Einstein cambia la prospettiva: in caduta libera non si avverte il peso, come se la gravità fosse ‘annullata’ localmente, segno che accelerazione e gravità sono due facce dello stesso fenomeno.
In orbita attorno alla Terra non c’è “gravità zero”: microgravità. La sensazione di assenza di peso nasce perché stazione e astronauti cadono incessantemente verso la Terra seguendo una traiettoria curva, mentre la velocità orizzontale li mantiene in orbita: è la microgravità.
Un’idea correlata è la velocità di fuga: 11,2 km/s. Superata questa soglia (ignorando attriti e rotazioni), un veicolo non resta più legato gravitazionalmente alla Terra. Altrimenti, se la spinta termina con velocità insufficiente, l’oggetto ricade o resta in orbita secondo le condizioni iniziali.
La gravità nella cultura pop: il film ‘Gravity’ come pretesto per capire
Il film ‘Gravity’ di Alfonso Cuarón, pur essendo un’opera di finzione, film ‘Gravity’. Una nube di detriti (effetto a catena tipico dello scenario di sindrome di Kessler) colpisce uno shuttle in missione di manutenzione al telescopio Hubble, costringendo gli astronauti a un drammatico tentativo di salvataggio.
Nella trama compaiono installazioni reali come la ISS, le capsule Soyuz e la stazione cinese Tiangong, con sequenze in cui piccoli getti di gas o persino un estintore micro-propulsori. È un modo spettacolare per ricordare che in orbita tutto fluttua non perché la gravità sia scomparsa, ma perché si è in caduta continua attorno al pianeta.
Applicazioni, conti rapidi ed esempi
La legge di gravitazione universale si presta a calcoli semplici ma istruttivi. F cresce di 16 volte, perché F è proporzionale a M·m e a 1/d²: F′ = G·(2M)·(2m)/(d/2)² = 16·G·M·m/d².
Un altro classico è la stima della forza tra Sole e Terra. Inserendo numeri tipici (Msole ≈ 2×10³⁰ kg, Mterra ≈ 6×10²⁴ kg, distanza ≈ 1×10¹¹ m, G ≈ 6,67×10⁻¹¹ N·m²/kg²), ≈10²³ N. Questi conti mostrano come una legge concisa consenta previsioni quantitative coerenti con le osservazioni astronomiche.
La stessa formula chiarisce perché le orbite rispondano alle leggi di Keplero: chiude ellissi. È proprio quella dipendenza quadratica dalla distanza a legare armonicamente caduta dei gravi e moti planetari.
Infine, un aspetto concettuale moderno: nello schema di Einstein, geodetiche dello spazio-tempo. Le equazioni di Newton restano straordinariamente accurate in moltissimi contesti quotidiani e ingegneristici, mentre la relatività generale è necessaria quando entrano in gioco campi intensi, velocità prossime a quella della luce o precisioni estreme (come nei sistemi di navigazione satellitare).
Anche i significati culturali delle parole raccontano un pezzo di storia. Dalla radice latina ‘gravis’ e dal sanscrito ‘gurutvakarshan’ fino alle dispute medievali e alle traduzioni arabe, terminologia della gravità è la traccia linguistica di una lunga catena di idee che convergono nella sintesi di Newton e si allargano con Einstein. Oggi continuiamo a interrogarci su cosa sia davvero la gravità a livello quantistico: una storia in corso.
Guardando all’insieme, emerge un filo continuo che parte dalle intuizioni di filosofi indiani e greci, passa per gli studiosi del mondo arabo, attraversa il Rinascimento e approda alla grande rivoluzione newtoniana, poi raffinata da Einstein. la gravità unisce fenomeni diversissimi e, proprio perché è così onnipresente, resta il primo fondale su cui non pensiamo… finché non proviamo a spiegarlo.
