- Il Metabolismo concepisce città e edifici come sistemi viventi, tra strutture permanenti e moduli sostituibili.
- Progetti emblematici: Piano per Tokyo, Sky House, Yamanashi, Shizuoka e Nakagin Capsule Tower.
- L’Expo Osaka 1970 segnò l’apice del movimento, prima della svolta post-crisi petrolifera.
- Eredità viva: da Maki e la “forma di gruppo” a riletture contemporanee e sperimentazioni modulari.
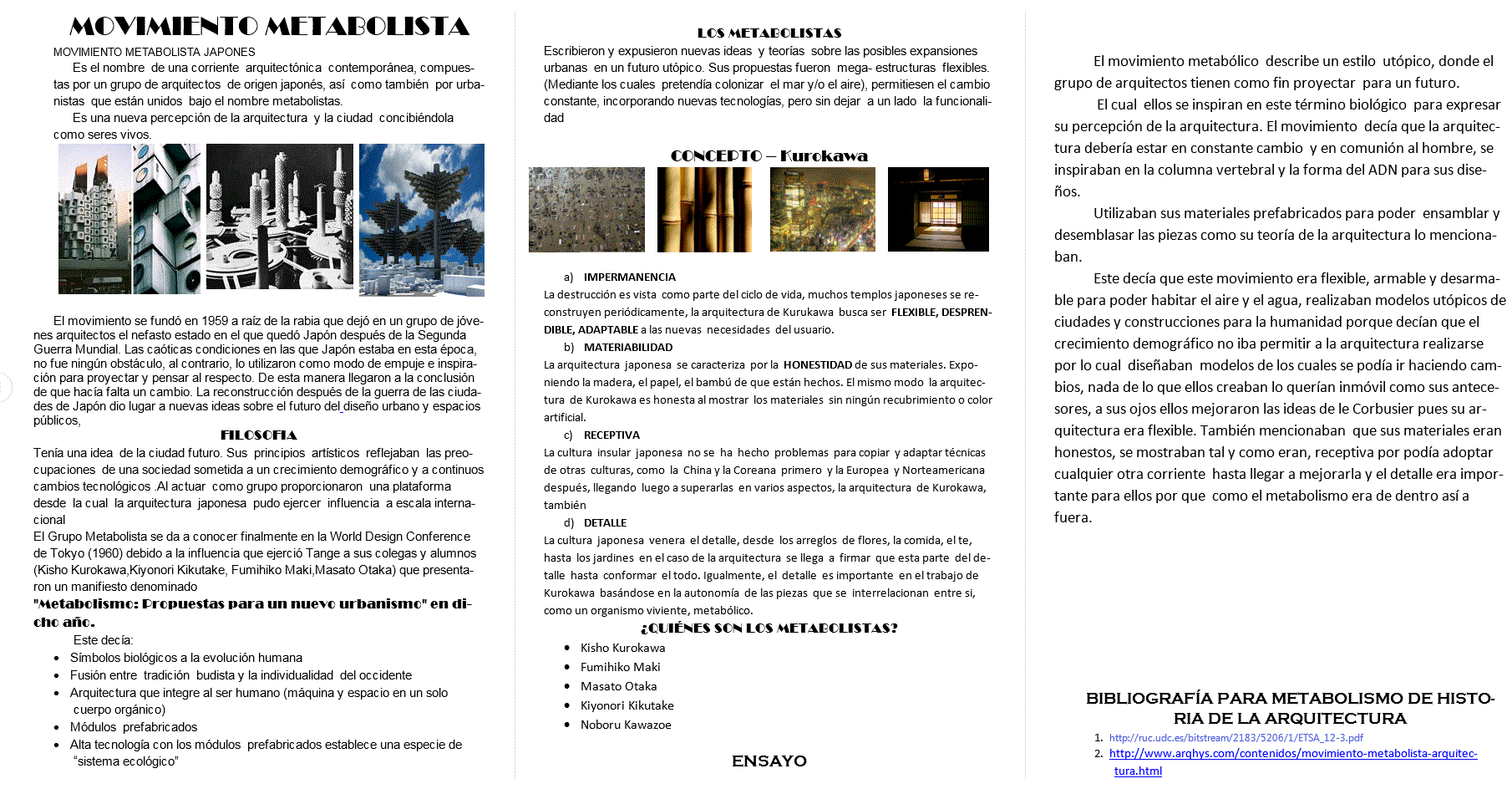
Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli Sessanta, in Giappone prese forma un’idea che avrebbe cambiato il modo di pensare la città: il Metabolismo. Non si trattava solo di un movimento architettonico, ma di una visione sistemica che interpretava l’ambiente costruito come un organismo vivo, fatto di parti che nascono, si trasformano e si sostituiscono nel tempo. In un paese alle prese con una crescita urbana tumultuosa e scarsità di suolo edificabile, questa proposta aveva una forza quasi inevitabile.
Dietro a questa ondata di progetti e manifesti c’erano figure che sarebbero diventate centrali nella cultura architettonica mondiale: Kenzo Tange, Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki, Masato Otaka e il critico Noboru Kawazoe, tra gli altri. Le loro idee combinavano mega-infrastrutture, pre-fabbricazione, cicli di vita “biologici” e un’inedita attenzione alla flessibilità, cercando risposte reali per città iper-dense e in continua evoluzione.
Che cos’è il Metabolismo in architettura
Il Metabolismo definisce un approccio in cui città ed edifici vengono concepiti come sistemi dinamici e adattabili. La continuità tra “strutture permanenti” (spine, tralicci, nuclei) e “componenti temporanei” (moduli, capsule, cellule abitative) è la chiave: le prime assicurano stabilità, i secondi consentono rinnovamento ciclico e ampliamenti successivi. In questo modo la crescita urbana diventa programmabile, come un organismo che sostituisce periodicamente i suoi tessuti.
Già nel 1959, al CIAM di Otterlo, Kenzo Tange presentò al mondo due progetti teorici di Kiyonori Kikutake: la “Tower-shaped City” e la “Sky House”. La metafa della “città come albero”, con tronco durevole e foglie che nascono e cadono, riassume perfettamente la logica metabolista: infrastrutture robuste e componenti residenziali rinnovabili, capaci di crescere e ritirarsi in base alle necessità.
Origini: CIAM, Team 10 e il contesto giapponese del dopoguerra
Il CIAM, nato nel 1928, aveva promosso una visione funzionalista della città basata su quattro funzioni cardine: abitare, lavorare, muoversi, svagarsi. Negli anni Cinquanta il Team 10 (tra cui Bakema e gli Smithson) contestò l’impostazione meccanicistica, introducendo concetti come “associazione umana”, “cluster” e “mobilità”. In Giappone, intanto, la ricostruzione postbellica e il boom economico spingevano verso soluzioni urbane nuove e radicali.
Nell’ambiente di Tokyo, con Tange come figura di riferimento, un gruppo di giovani progettisti e designer cominciò a tessere una rete trasversale tra architettura, ingegneria e cultura. Durante la preparazione della World Design Conference del 1960, Takashi Asada, Noboru Kawazoe, Kisho Kurokawa, Kiyonori Kikutake, Masato Otaka, Kenji Ekuan e Kiyoshi Awazu unirono le forze: nacque qui il terreno del manifesto metabolista.
Il manifesto “Metabolism 1960” e un lessico nuovo
Alla World Design Conference del 1960, a Tokyo, fu distribuito il volumetto “Metabolism 1960: The Proposals for a New Urbanism”, con testi e progetti che esplicitavano l’idea della società umana come processo vitale e della città come sistema in metabolizzazione continua. Il termine stesso “Metabolismo” derivò dalla parola giapponese “shinchintaisha”, suggerita da Kawazoe per esprimere la sostituzione del vecchio con il nuovo.
Non era una semplice analogia biologica: i metabolisti rivendicavano la volontà di orientare attivamente quel metabolismo attraverso il progetto, con “terre artificiali”, cicli di sostituzione programmati e megastrutture capaci di accogliere moduli standardizzati. La metodologia scientifica a tre stadi del fisico Mitsuo Taketani (ripresa da Kikutake come ka, kata, katachi) offrì una cornice teorica: dal sistema generale, all’immagine, alla soluzione costruita.
Concetti cardine: terra artificiale, strutture primarie/secondarie, città in crescita
La “terra artificiale” (grandi piattaforme, ponti, pareti attrezzate) permetteva di liberare il suolo naturale, concentrando agricoltura, industria e residenze su piani infrastrutturali sospesi o flottanti. Le strutture “primarie” ospitavano reti di trasporto e servizi, mentre le “secondarie” erano costituite da capsule o moduli abitativi sostituibili in cicli regolari.
Nei progetti di Kikutake – “Marine City”, “Ocean City” e la già citata “Tower-shaped City” – la città poteva galleggiare libera sul mare, crescere organicamente, auto-rinnovarsi e perfino “affondare” quando obsoleta. In “Ocean City”, due anelli tangenti separavano funzioni residenziali e produttive, con crescita per “moltiplicazione cellulare”, evocando la divisione biologica.
I progetti di Kurokawa: Neo-Tokyo, Wall City, Agricultural City e Mushroom House
Kisho Kurokawa articolò le sue proposte in “Space City”: il “Neo-Tokyo Plan” decentrava la capitale in pattern cruciformi con “Bamboo-shaped Cities”, rispettando anche il limite di altezza di Tokyo dell’epoca (circa 31 metri). “Wall City” immaginava una lunga parete urbana con residenze da un lato e lavoro dall’altro, integrando servizi e trasporto nella sezione muraria.
Dopo il tifone Vera (1959), Kurokawa pensò a una “Agricultural City” sollevata su palafitte di 4 metri, con una grande piastra che unificava agricoltura e industria. Qui comparivano le “case a fungo” (Mushroom-shaped house), involucri continui né sola copertura né sola parete, concepiti come camere da tè e spazi abitativi, e destinati a “spuntare” attraverso la lastra urbana.
Forma di gruppo: Maki e Otaka oltre la megastruttura
Fumihiko Maki e Masato Otaka proposero la “forma di gruppo”, un urbanismo più flessibile rispetto alle megastrutture monumentali, capace di coordinare addizioni progressive e aggregazioni omogenee. Il loro schema per l’area della stazione di Shinjuku prevedeva una “terra artificiale” sopra i binari con funzioni commerciali, uffici e intrattenimento.
Maki, che in seguito coniò e criticò a sua volta il termine “megastruttura”, approdò a una visione in cui la forma collettiva avrebbe gestito meglio l’irregolarità della città reale. La sua evoluzione si vede bene nel lungo cantiere del “Hillside Terrace” (1967–1992), dove materiali, facciate e relazioni con il contesto si raffinano a ogni fase.
Dal laboratorio alla città: Boston Bay, il Piano per Tokyo e la Megalopoli Tōkaidō
Quando Tange fu visiting professor al MIT, impostò con gli studenti un progetto per una comunità di 25.000 abitanti nella Baia di Boston: si sperimentava la distinzione tra strutture primarie e secondarie, circolazioni multilivello e moduli residenziali. Queste idee confluirono nel “Plan for Tokyo – 1960”, una città lineare di circa 80 km, organizzata in moduli di 9 km con anelli di autostrade sovrapposte.
Il Piano per la Baia di Tokyo, presentato anche in TV nel 1961, prevedeva assi infrastrutturali dominanti, strade ortogonali per le residenze e grandi telai A che ospitavano case costruite dagli stessi abitanti. Sebbene non realizzato, ispirò varianti di Kikutake e Kurokawa e aprì alla proposta della “Megalopoli Tōkaidō” (1964), un’estensione lineare dell’idea metropolitana per riequilibrare la popolazione del Giappone.
Opere chiave: Sky House, Yamanashi, Shizuoka e la Nakagin Capsule Tower
La “Sky House” (1958) di Kikutake era una piattaforma sostenuta da quattro setti con copertura a guscio iperbolico-parabolico: un unico ambiente articolato da nuclei di servizio mobili e adattabili, ricomposti più volte nei decenni. È l’archetipo della flessibilità metabolista su piccola scala.
Il “Yamanashi Press and Broadcasting Center” (1967) di Tange organizzava tre funzioni aziendali condividendo servizi in sedici torri cilindriche in c.a. da 5 metri di diametro. All’interno della griglia, “contenitori” indipendenti potevano essere ricomposti. Le torri, volutamente a quote differenti, suggerivano future espansioni, pur attirando critiche per l’eccesso di enfasi strutturale rispetto all’uso quotidiano.
La “Shizuoka Press and Broadcasting Tower” (1966), sempre di Tange, affidava a un nucleo centrale i servizi e sbalzava blocchi uffici in acciaio e vetro, con piani-cerniera vetrati per enfatizzare il bilanciamento. Le casseforme in alluminio segnarono finitura e processo, un lessico caro al movimento.
La “Nakagin Capsule Tower” (1972) di Kurokawa, eretta in circa 30 giorni, era composta da 140 capsule agganciate a due nuclei (11 e 13 piani). Ogni unità, prefabbricata in fabbrica, misurava circa 2,5 x 4 m con un oblò di 1,3 m, arredata con letto, armadi, bagno, TV a colori, frigorifero, aria condizionata e optional (radio). Pur pensata per produzione di massa, la domanda non esplose.
Dal 1996 inserita nelle liste DoCoMoMo, nel 2007 i residenti votarono per la demolizione e ricostruzione. Nonostante ciò, l’edificio è rimasto in piedi per anni, con un numero ridotto di abitanti e perfino forme di ospitalità low-cost (circa 30 dollari a notte), testimoniando sia le potenzialità sia i limiti della capsula urbana.
Expo Osaka 1970: apoteosi metabolista e prime crepe
All’Esposizione Universale di Osaka del 1970, il Giappone mise in vetrina la sua fiducia nella tecnologia e nella pianificazione sistematica. Kenzo Tange coordinò la “Festival Plaza” con un enorme tetto a reticolo spaziale, soluzione ingegneristica raffinata grazie alle giunzioni sferiche senza saldatura ideate da Mamoru Kawaguchi.
Kisho Kurokawa realizzò il “Takara Beautillion”, un sistema di capsule montate in pochi giorni, e il padiglione “Toshiba IHI” con reticoli tetraedrici, eco della sua “Helix City” capace di crescere in molte direzioni. Kikutake eresse la “EXPO Tower” come landmark sulla collina più alta del sito. L’Expo fu celebrata come il picco del Metabolismo, ma non mancarono voci critiche sulla distanza tra visioni e vita quotidiana.
La crisi petrolifera del 1973 mostrò la vulnerabilità dell’economia giapponese e spostò l’attenzione da utopie su vasta scala a interventi urbani più misurati. In quel passaggio, molti metabolisti si orientarono verso pratiche più convenzionali, pur lasciando un’eredità progettuale potente.
Dialoghi e confronti: Kahn, Archigram, megastrutture e forma di gruppo
Alla World Design Conference, Louis Kahn dialogò a lungo con i giovani architetti giapponesi. Il suo laboratorio di Richards a Philadelphia fu letto come un esempio di articolazione tra servizi e spazi principali, suggerendo strategie di scomposizione funzionale care ai metabolisti. Queste risonanze culturali contribuirono alla ricezione internazionale del gruppo.
Spesso accostati all’Archigram, condividevano immagini di megastrutture e moduli “cellulari”, ma differivano nelle finalità: maggiore enfasi sociale e urbana in Giappone, più visione mediatico-tecnologica nel gruppo londinese. La nozione di “megastruttura”, rilanciata da Reyner Banham, verrà in seguito problematizzata da Maki a favore della “forma di gruppo”.
Dopo il 1973: Medio Oriente, Africa e città sull’acqua
Nel clima post-Expo, i metabolisti guardarono oltre il Giappone, verso Paesi del Medio Oriente e dell’Africa con forti disponibilità economiche legate al petrolio e interesse per grandi strategie urbane. Kenzo Tange vinse concorsi per una città dello sport in Kuwait e per impianti sportivi a Riyadh; restano significative, pur se in parte sospese o cancellate, le sue pianificazioni per Teheran.
Kurokawa, dal canto suo, sviluppò progetti come il Teatro Nazionale di Abu Dhabi, una torre a capsule per un hotel a Baghdad e una città nel deserto in Libia. Kikutake concretizzò la visione di torri flottanti con “Aquapolis” (Okinawa Ocean Expo, 1975): una struttura galleggiante di 100 x 100 m con uffici, residenze per 40 persone e sala banchetti, costruita a Hiroshima e rimorchiata fino a Okinawa.
Radici culturali: tradizione giapponese, Marxismo e cicli di rigenerazione
Il Metabolismo non rifiutava la storia: assorbiva i cicli di rigenerazione del Santuario di Ise (ricostruito ogni 20 anni) e le lezioni del Palazzo di Katsura, unendo rigore geometrico e flessibilità d’uso, pur mantenendo una sintassi formale più assertiva del modernismo europeo. Alcuni membri furono influenzati dalla teoria marxista e da una lettura scientifica dei processi sociali, cercando di coniugare “civiltà tecnologica” e identità locale.
La fiducia nella pre-fabbricazione era assoluta: standardizzazione e montaggio rapido come risposta a scala urbana. Questa “tecno-latria” venne poi riletta criticamente: se le case diventano “prodotti”, i cicli di obsolescenza rischiano di non allinearsi alla durata attesa dell’architettura e alle economie reali del cantiere.
Maki e il lungo cantiere di Daikanyama
Nel suo opuscolo “Investigations in Collective Form”, Maki analizzò tre tipologie urbane (composizionale, megastruttura e forma di gruppo). Nel progetto “Hillside Terrace” (1967–1992), si vede come la forma esterna si emancipi progressivamente dalla funzione interna, adottando materiali e linguaggi diversi per sintonizzarsi con il luogo. L’effetto, a distanza, è stato quello di catalizzare la trasformazione del quartiere di Daikanyama.
La sua posizione maturata negli anni mette in luce un nodo: tra l’energia visionaria delle megastrutture e l’agilità della forma di gruppo, è quest’ultima a dialogare meglio con la città imperfetta. È un lascito fondamentale del dibattito metabolista.
Un capitolo francese: il SIRH di Claude Prouvé
La parabola del Metabolismo ebbe eco anche fuori dal Giappone. In Francia, Claude Prouvé – figlio di Jean Prouvé – sviluppò il processo SIRH (Société Industrielle de Recherche et de Réalisation de l’Habitat), un sistema di cellule abitative prefabbricate combinabili, pensato per configurazioni illimitate. La struttura prototipale di Ludres (Lorena), avviata nel 1973, contava 60 moduli su 8 piani.
I moduli standard misuravano circa 3,8 x 3,8 m per 2,5 m di altezza: telaio in acciaio inox, pavimento/soffitto in acciaio zincato (medesimo componente), interni in lamiera di alluminio, montanti riempiti con schiuma polimerica. I pannelli di facciata, pieni o finestrati, avevano telai lignei. Due torri in calcestruzzo ospitavano circolazioni e davano ancoraggio all’intero sistema.
Il montaggio, eseguito da squadre di 3–4 persone con gru, testimoniava l’efficienza industriale perseguita dal movimento. Poco prima della conclusione (1974) la società fallì; la struttura rimase incompiuta e fu demolita nel 2012. Molti videro nel SIRH una minaccia per filiere edilizie consolidate: al di là delle cause, resta uno dei test più lucidi sulle promesse e i limiti dell’industrializzazione spinta dell’abitare.
Ricezione internazionale e impatto culturale
La World Design Conference del 1960 ebbe enorme eco in Europa e negli Stati Uniti. Il Metabolismo si presentava come un “ismo” compiuto, con forti legami con l’Occidente (Maki studiò a Harvard con Sert; Kurokawa dialogò con il Team 10 e invitò figure come Safdie, Cook e Hollein). Parallelamente, Tange e colleghi mostrarono al mondo un’elaborazione visiva e teorica senza eguali.
Critici come Reyner Banham ne colsero insieme fascinazione e fragilità: grande autorità teorica nei piani di Tange, visionarietà magnetica in Kikutake e Kurokawa, ma anche il rischio di un “accademismo dell’utopia”. Kenneth Frampton sottolineò la distanza tra immaginari marini di Kikutake e praticabilità quotidiana, pur riconoscendo intuizioni potentissime.
Toyo Ito e l’attualità del Metabolismo
Ancor oggi, architetti contemporanei rileggono il Metabolismo alla luce delle nuove tecnologie e dei rischi climatici. Toyo Ito ha riflettuto sulla figura di Kikutake e sulla vitalità delle sue idee, dalla città come flusso alla provvisorietà come valore, mostrando come capsule, cicli di sostituzione e “terre artificiali” possano ispirare nuove forme di resilienza.
Persino esperimenti come gli “EcoPods” (Boston, 2009) testimoniano la persistenza dell’idea di involucro modulare e temporaneo, adattabile ai vuoti urbani e a esigenze transitorie. Il filo metabolista, insomma, continua a intrecciarsi con l’innovazione.
Oggi, tra rigenerazione, densificazione e crisi ambientale, un approccio che mescoli strutture longeve e parti rimpiazzabili conserva un forte potenziale. Se l’eccesso di fede nella macchina e nella prefabbricazione totale ha mostrato i suoi limiti economici e sociali, la lezione di fondo – la città come processo, la progettazione come regia di cicli e sostituzioni – resta uno degli insegnamenti più fecondi venuti dal Giappone del dopoguerra.
