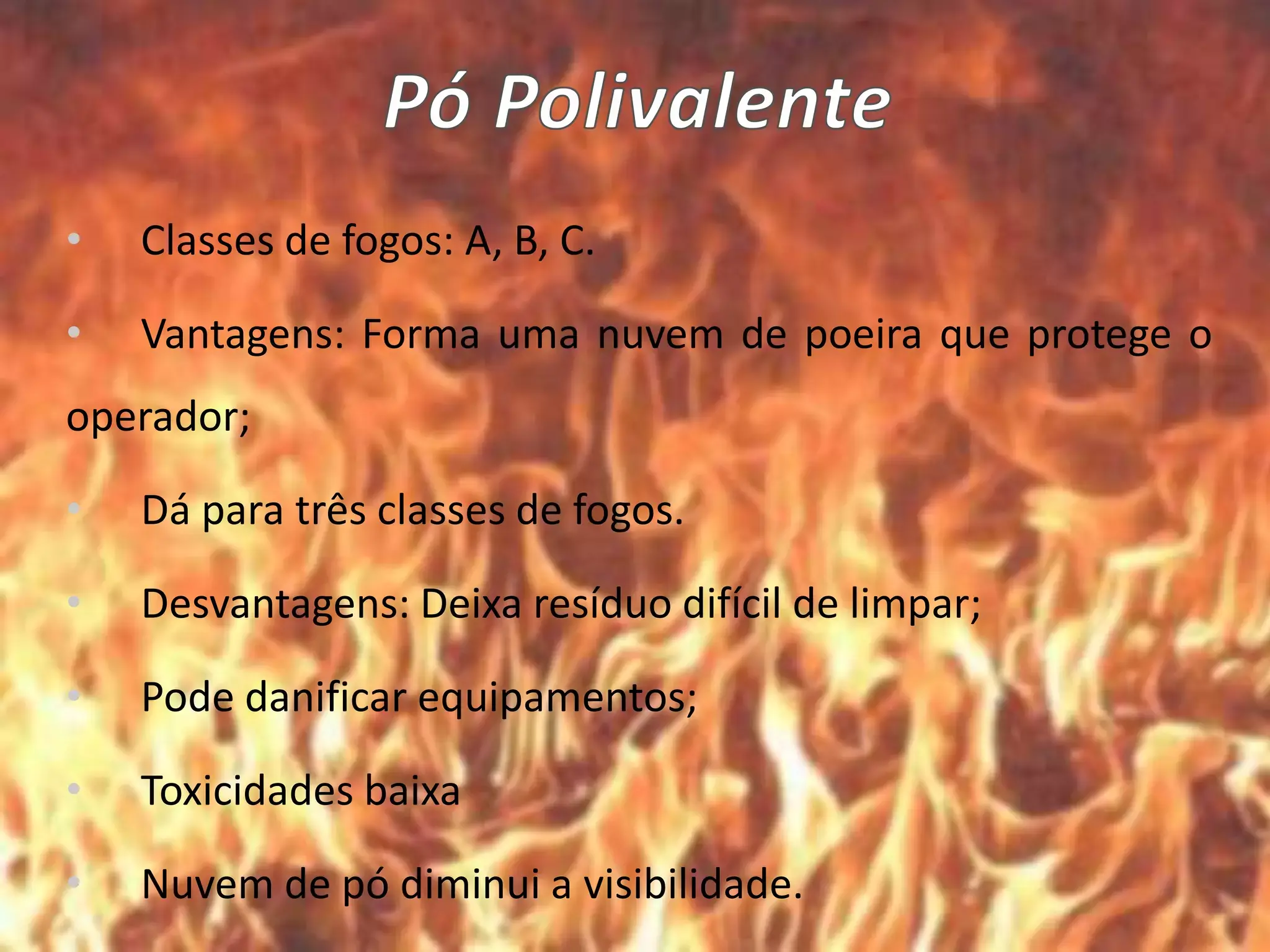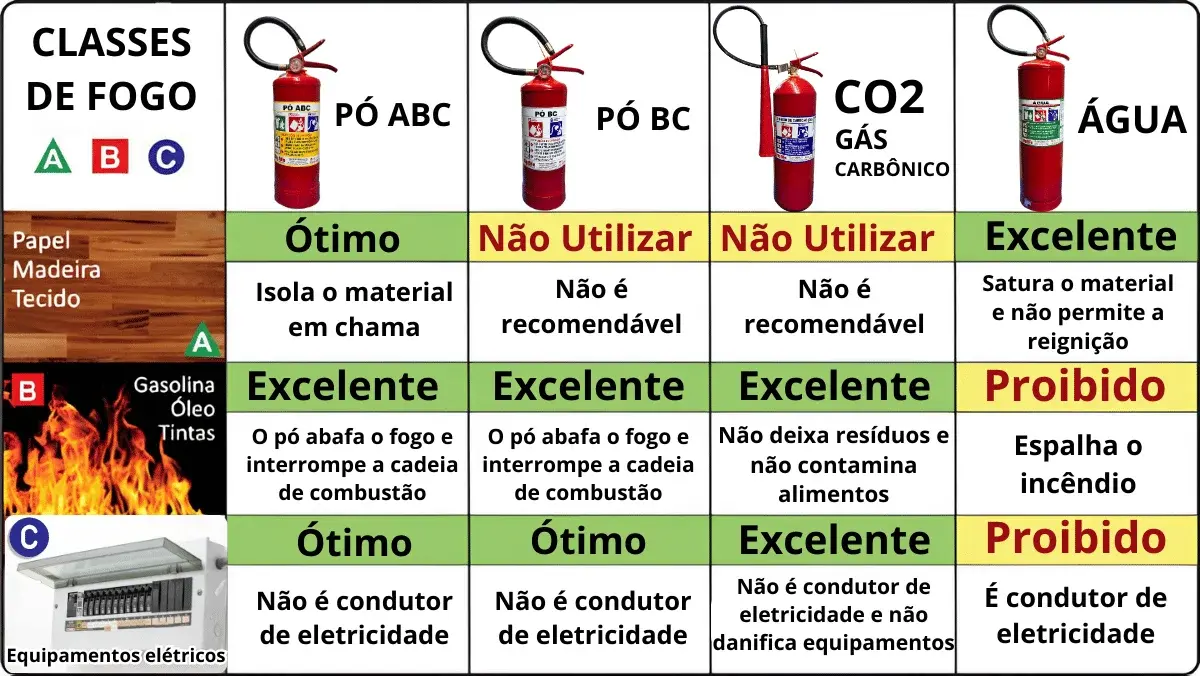- Il fuoco può offrire benefici a breve termine in ecosistemi adattati, ma ripetizione e intensità eccessive impoveriscono suolo e biodiversità.
- Gli impatti pedologici includono picchi termici superficiali, aumento temporaneo di nutrienti, pH più alto, idrofobia, erosione e perdite per ceneri.
- La legge 14.944/2024 in Brasile consente solo bruci controllati/prescritti con autorizzazioni, vietando l’uso per conversione di vegetazione nativa.
- Prevenzione e gestione integrata (tecnologia, piani, ripristino) sono decisive per ridurre rischi e impatti su ecosistemi e clima.
In molti paesaggi terrestri il fuoco è un fattore ecologico a pieno titolo: a seconda dell’intensità, della durata e del contesto ambientale, può favorire processi naturali oppure causare danni profondi. Dai suoli alle comunità vegetali e animali, il passaggio delle fiamme rimodella cicli di nutrienti, struttura del terreno e dinamiche della biodiversità, influenzando perfino il clima locale e globale.
Nei sistemi in cui il fuoco è “di casa” (come savane o alcuni tipi di boscaglia), eventi a bassa intensità possono contribuire al rinnovo della vegetazione e al riciclo temporaneo dei nutrienti. Dove invece l’elemento fuoco non è naturale, o quando l’uso umano ne altera frequenza e potenza, gli effetti diventano per lo più negativi: erosione, perdita di materia organica, impoverimento di habitat e rischi per la sicurezza. In questo quadro complesso entra anche la normativa, che in alcuni Paesi disciplina con precisione quando e come il fuoco si possa impiegare in modo controllato.
Storicamente, in agricoltura e nella gestione del territorio, il fuoco viene usato per obiettivi operativi ben precisi. Tra i motivi principali rientrano la “pulizia” di aree agricole o forestali, il rinnovo dei pascoli e l’apertura di nuove superfici coltivabili, oltre a pratiche mirate come la facilitazione della raccolta (ad esempio nella canna da zucchero) o il contenimento di infestanti, parassiti e patogeni dopo il raccolto.
- Ripulitura di residui vegetali in appezzamenti agricoli o aree boscate
- Rinnovamento del cotico erboso per il pascolo
- Espansione di frontiere agricole laddove consentito
- Supporto alla raccolta in colture specifiche
- Controllo di infestanti, insetti e malattie post-raccolta
Detto questo, molti incendi derivano da azioni umane non pianificate o negligenti: fuochi da campo mal gestiti, mozziconi accesi gettati a terra, bruci non controllati che sfuggono di mano. Esistono anche cause naturali – come fulmini, eruzioni vulcaniche o attività sismica – in grado di innescare roghi in condizioni favorevoli (vegetazione secca, vento, bassa umidità).
Perché si ricorre al fuoco: usi agricoli e fonti di innesco
La cornice normativa brasiliana recente, legge 14.944/2024, stabilisce linee guida per impiegare il fuoco in aree rurali con criteri di sostenibilità e tutela della biodiversità. La direzione è chiara: favorire metodi alternativi e limitare il fuoco a contesti ben definiti e autorizzati, con piani di gestione e misure di sicurezza.
La legge distingue fra due categorie operative: “queimadas controladas” (bruci controllati a fini agro-zootecnici, vincolati ad autorizzazioni e a un piano di gestione integrata del fuoco) e “queimadas prescritas” (bruci pianificati per conservazione, ricerca o gestione della vegetazione, anch’essi soggetti ad autorizzazione preventiva). È vietato usare il fuoco per eliminare vegetazione nativa allo scopo di conversione del suolo, salvo l’eccezione della combustione controllata dei soli residui vegetali.
Quando la fiamma non è più governata da un piano e da barriere di contenimento, si parla a tutti gli effetti di incendio: in tal caso la propagazione segue solo clima, topografia e disponibilità di combustibile, con esiti spesso disastrosi.

Effetti del fuoco sul suolo: fisica, chimica e biologia
Nutrienti minerali: una fertilizzazione lampo, poi effetti opposti
Al passaggio del fuoco, i nutrienti immagazzinati nella biomassa vengono trasferiti alla superficie del suolo. Nell’immediato, diversi studi riportano aumenti di azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca) e magnesio (Mg) in forme mineralizzate: è una “spinta” nutrizionale che dura settimane o pochi mesi, per poi tornare ai livelli precedenti. Con ricorrenza di bruci, o nel lungo periodo, la tendenza è l’impoverimento per perdita di sostanza organica e dilavamento/volatilizzazione.
In incendi intensi il quadro può capovolgersi già a breve termine: N e zolfo (S) si volatilizzano con facilità, e oltre ~600 °C persino il P può andare perso. Le ceneri, portatrici di cationi, possono essere disperse dal vento o trascinate via dall’acqua di ruscellamento, sottraendo nutrienti al sito. Un risultato peculiare osservato in alcuni suoli acidi: gli ioni di alluminio nella porzione superficiale calano fino a valori trascurabili subito dopo la bruciata, riducendo temporaneamente la fitotossicità legata all’alluminio; l’effetto però svanisce con il tempo.
pH: più basi dalle ceneri, acidi tamponati
La combustione di materia organica comporta la perdita preferenziale di anioni rispetto ai cationi; le ceneri risultano ricche di ossidi e carbonati di base in grado di neutralizzare l’acidità. Per questo, in molti suoli tropicali si osserva un aumento del pH dopo il passaggio del fuoco. Si tratta comunque di un effetto che dipende da quantità e composizione delle ceneri, intensità del rogo e tessitura del suolo.
Temperatura del suolo: picchi superficiali, poca penetrazione
Nell’istante della combustione, la temperatura alla superficie del suolo può toccare punte molto elevate (in condizioni estreme si citano fin quasi 1000 °C), ma il calore penetra poco in profondità. Rilievi sperimentali hanno mostrato, ad esempio, incrementi limitati già a pochi centimetri sotto la superficie, con valori di poche unità di grado a 5 cm. Il contenuto d’acqua modula fortemente il riscaldamento: suoli umidi si scaldano meno (evaporazione, maggiore calore specifico e conducibilità). Anche l’umidità del combustibile e l’ora del giorno, tramite temperatura e UR, incidono sull’andamento delle fiamme.
Nel lungo periodo, la superficie scurita dalla combustione assorbe più radiazione solare, innalzando le temperature diurne; scompare anche l’ombreggiamento della copertura vegetale, per cui aumenta l’ampiezza termica giornaliera (più caldo di giorno, più freddo di notte).
Materia organica: mineralizzazione lampo e variabilità degli esiti
Il fuoco accelera drasticamente la mineralizzazione della frazione più superficiale della sostanza organica, trasformando in minuti ciò che richiederebbe mesi o anni. Alcuni lavori hanno rilevato incrementi del carbonio nel suolo subito dopo la bruciata, altri invece diminuzioni: il segno dipende dall’intensità dell’incendio, dal tipo di residui e dal contenuto iniziale. La sostanza organica più profonda, schermata dal calore, è meno colpita. Nei pascoli, per esempio, il continuo ricambio radicale può mantenere stabile la dotazione di sostanza organica a breve termine, pur in presenza di bruci superficiali.
Microrganismi e biologia del suolo
All’inizio, la perdita di lettiera e la riduzione del carbonio labile possono deprimere porzioni della micro- e mesofauna. Tuttavia, con l’arrivo delle prime piogge dopo il passaggio del fuoco, diversi studi hanno osservato un aumento temporaneo del numero e dell’attività microbica, alimentato dall’incremento del pH e dalla disponibilità di nutrienti delle ceneri; successivamente i livelli tendono a decrescere verso valori più prossimi al controllo. L’alcalinizzazione favorisce anche microrganismi azotofissatori liberi in superficie.
Umidità, idrofobia superficiale e infiltrazione
Il fuoco può indurre o accentuare la reppellenza all’acqua (idrofobia) nella fascia superficiale, per via di composti idrofobici volatili che si riorganizzano nel profilo. Ciò comporta riduzione dell’infiltrazione e maggiore scorrimento superficiale. In parallelo, la rimozione della copertura vegetale riduce ombra e ritenzione d’acqua, asciugando più rapidamente il suolo.
Erosione, porosità e struttura
L’assenza di lettiera espone il suolo all’impatto diretto delle gocce di pioggia, aumentandone la disgregazione superficiale e favorendo l’erosione. Le particelle fini e le ceneri possono occludere i pori, diminuendo porosità e ossigenazione, con un possibile aumento della densità apparente e una riduzione della stabilità degli aggregati. Su versanti e in eventi piovosi intensi, le perdite per ruscellamento si amplificano, portando via anche nutrienti e carbonio. In letteratura l’erosione post-incendio è spesso indicata come uno degli impatti più duraturi e problematici.
Ecosistemi, biodiversità e atmosfera: cosa cambia dopo le fiamme
Gli incendi possono radere al suolo habitat complessi come foreste, praterie e zone umide, con perdita di siti di rifugio e fonti trofiche per molte specie. La fauna meno mobile o colta di sorpresa può soccombere, mentre la flora sensibile viene spesso eliminata nella parte aerea. Di conseguenza la biodiversità locale si riduce, e in alcuni casi si rischiano estinzioni puntuali.
Nei mesi successivi, le nuove condizioni possono favorire l’ingresso di specie vegetali invasive, che competono con le native e alterano cicli di nutrienti e processi di rinnovazione. Se gli eventi di fuoco diventano troppo frequenti o intensi, gli ecosistemi possono non avere il tempo di recuperare, scivolando verso stati più degradati.
Sul fronte atmosferico, la combustione di biomassa libera CO₂ e altri gas/climalteranti, entrando nel ciclo del carbonio; quando la stagione secca si prolunga e le temperature aumentano, si innesca un circolo vizioso: più caldo e siccità → incendi più probabili e severi → ulteriori emissioni e impatti sulla vegetazione.
Dove e quando si concentrano gli incendi in Brasile
Le regioni tropicali brasiliane affrontano periodicamente picchi di incendi, con intensità variabile a seconda di clima, gestione e deforestazione. In Amazzonia, foresta densa e condizioni calde-umide si sommano a pressioni antropiche: disboscamento e uso del fuoco per “pulire” aree agricole restano fattori cruciali. La stagione secca (indicativamente da luglio a settembre) coincide con il massimo rischio; negli anni di maggiore conversione d’uso, il numero di focolai aumenta sensibilmente.
Anche il Cerrado, mosaico di savane e boscaglie, è regolarmente interessato da incendi, specie nella secca. I bruci controllati per la preparazione dei terreni possono, se mal gestiti, trasformarsi in incendi fuori controllo. Nel Pantanal, la più grande pianura allagabile del mondo, la stagione asciutta espone a roghi che minacciano fauna e sistemi acquatici di grande valore ecologico.
Vantaggi e svantaggi del fuoco: come valutare caso per caso
Nel breve termine e in contesti idonei, il fuoco può facilitare il ricircolo di nutrienti, controllare accumuli di combustibile e innescare un rinnovamento della vegetazione. In ecosistemi adattati (per esempio alcune savane), interventi a bassa intensità e ben cronometrati possono essere uno strumento di gestione funzionale, riducendo il rischio di grandi incendi catastrofici.
Sul piatto opposto, i costi ambientali e pedologici crescono rapidamente se le bruciature si ripetono spesso, sono intense o avvengono in ecosistemi non adattati: perdita di sostanza organica, erosione, declino della qualità del suolo nel lungo periodo e danni alla biodiversità. Inoltre, le perdite per volatilizzazione e trasporto di ceneri possono superare i benefici della “fertilizzazione lampo”.
Gestione e prevenzione: quando il fuoco è strumento, quando è minaccia
Laddove la legge lo consente e gli studi eco-pedologici lo supportano, i bruci controllati/prescritti vanno pianificati tramite piani di gestione del fuoco: obiettivi chiari, finestre climatiche idonee, break di vegetazione, autorizzazioni e squadre preparate. Lo scopo è ridurre il carico di combustibile e gestire dinamiche ecologiche, minimizzando gli impatti collaterali.
Sul fronte della prevenzione, la tecnologia è un alleato: satelliti, droni e sistemi di allerta rapida aiutano a individuare focolai e a coordinare le risposte. Accanto a questo, contano la sensibilizzazione pubblica sui rischi legati al fuoco, l’applicazione delle norme sulle attività a rischio e la predisposizione di piani di emergenza/evacuazione per le aree più esposte.
Infine, il lavoro non finisce con lo spegnimento: servono ripristino ecologico (per contenere erosione e invasive), monitoraggi del suolo e ricerca continua sugli effetti a lungo termine e sulla resilienza degli ecosistemi. Le evidenze mostrano che i risultati variano con clima, copertura vegetale, tipo di suolo e intensità del fuoco: per questo ogni territorio richiede diagnosi e protocolli su misura.
Considerando insieme normativa, ecologia e suolo, emerge un punto chiave: il fuoco non è “buono” o “cattivo” in assoluto. È uno strumento potentissimo che, senza pianificazione e regole, moltiplica i danni; con conoscenza, finestre meteorologiche corrette e controlli rigorosi, può avere un posto circoscritto nella gestione di paesaggi adattati, evitando al contempo che le fiamme diventino un problema ricorrente per ambiente, agricoltura e comunità.