- I meteoriti derivano da meteoroidi e conservano la composizione del corpo madre (più spesso asteroidi), con tre famiglie: rocciosi, ferrosi e misti.
- L’ingresso atmosferico genera crosta di fusione, regmaglipti e, talvolta, campi di dispersione; i ferrosi sono i più capaci di creare crateri.
- La maggioranza dei ritrovamenti proviene da Antartide e deserti; esistono reti di osservazione e una tassonomia moderna complessa.
- Scoperte di acqua e molecole organiche nei meteoriti offrono indizi sull’origine della vita e sulla storia del Sistema Solare.

I meteoriti sono i frammenti solidi di origine spaziale che sopravvivono alla discesa nell’atmosfera e raggiungono la superficie di un pianeta o di una luna. Possono essere rocciosi, metallici o misti, presentano una tipica crosta scura di fusione e spesso superfici segnate da cavità e fratture. Arrivano in tutte le dimensioni, dal micrometeorite grande come un granello di sabbia fino a blocchi di più metri e molte tonnellate.
Ben lontani dall’essere un’esclusiva terrestre, i meteoriti possono cadere su qualunque corpo del Sistema Solare. Alcuni hanno masse stupefacenti: il più grande trovato integro, l’Hoba in Namibia, pesa circa 60 tonnellate. Altri sono minuscoli e cadono ogni giorno in quantità enormi senza che ce ne accorgiamo.
Che cos’è un meteorite?

Nel linguaggio dell’astronomia, i termini si distinguono così: un meteoroide è un frammento che viaggia nello spazio; quando entra nell’atmosfera e la sua scia diventa luminosa, il fenomeno si chiama meteora (la classica “stella cadente”); se una parte di quel corpo non si consuma completamente e raggiunge il suolo, il resto prende il nome di meteorite.
Molti meteoroidi arrivano nell’atmosfera a velocità elevatissime, in media possono toccare decine di chilometri al secondo (valori massimi tipicamente dell’ordine di 72 km/s). L’attrito li incandescenza e produce la scia; secondo la NASA, i frammenti che riescono ad arrivare al suolo rappresentano spesso circa il 5% della massa iniziale. La traversata più energetica avviene in alta atmosfera e, per i casi che superano la disintegrazione, il tratto finale avviene a velocità terminale.
La superficie esterna di un meteorite mostra quasi sempre la crosta di fusione, sottile e scura, dovuta alla fusione superficiale durante la discesa. Questa crosta può apparire lucida o opaca e, in alcuni casi, più chiara negli acondriti. Le forme sono irregolari e la morfologia spesso include piccole cavità aerodinamiche (i regmaglipti), segni di frattura e depressioni.
Da cosa sono fatti i meteoriti?
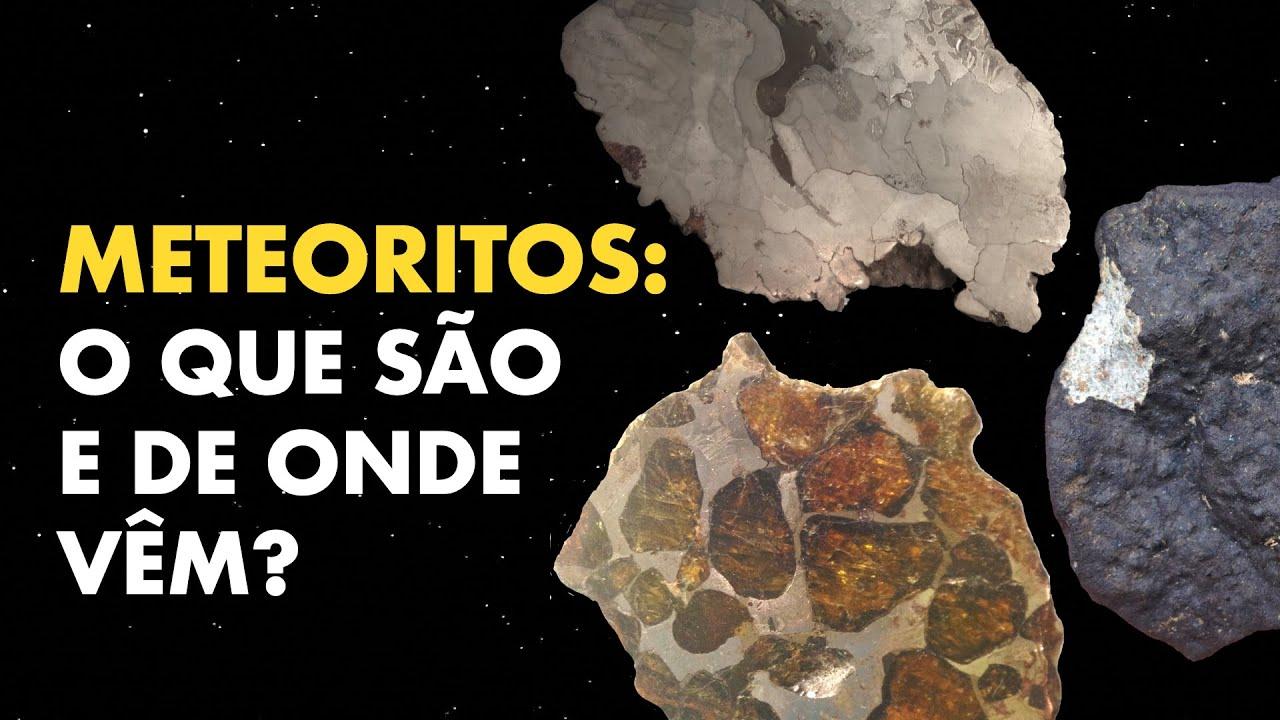
I meteoriti conservano la firma chimico-mineralogica del corpo celeste di origine (asteroide, cometa o, più raramente, Luna o Marte). La loro composizione determina tre grandi famiglie: rocciosi, ferrosi e ferro-rocciosi. In media, la maggior parte di quelli ritrovati sulla Terra è di natura rocciosa.
- Meteoriti rocciosi (aeroliti): dominati da silicati; sono i più comuni.
- Meteoriti ferrosi (sideriti): composti principalmente da ferro e nichel, molto densi e pesanti.
- Meteoriti ferro-rocciosi (sideroliti): un mix di metallo e silicati, meno abbondanti ma spettacolari.
Meteoriti rocciosi: condriti e acondriti
Tra i rocciosi, le condriti sono il gruppo dominante, circa l’86% di tutti i meteoriti. Si riconoscono per la presenza di condrule, sferule millimetriche di materiale silicatato, e possono includere piccole quantità di carbonio e composti organici. La loro età è estremamente antica, dell’ordine di 4,5 miliardi di anni, e rappresentano materiale primitivo del Sistema Solare.
Le acondriti non contengono condrule e assomigliano spesso a rocce ignee terrestri; derivano da corpi differenziati, dove processi geologici hanno separato le frazioni metalliche da quelle silicatiche. Sono meno comuni delle condriti e, pur avendo età simile, registrano storie termiche più complesse.
Meteoriti ferrosi
I ferrosi sono principalmente leghe ferro-nichel (camacite, taenite e altre fasi). Sono i campioni più densi e spesso mostrano strutture interne caratteristiche, come i pattern di Widmanstätten nelle sezioni lucidate e incise. Nelle statistiche di caduta, si attestano attorno a circa il 5%, anche se nelle collezioni storiche e tra i ritrovamenti casuali possono apparire sovrarappresentati perché facili da riconoscere.
Meteoriti ferro-rocciosi
La famiglia mista, circa l’1%, comprende soprattutto pallasiti (cristalli di olivina immersi in metallo Fe-Ni) e mesosideriti. Questi campioni offrono una finestra unica sulla transizione tra nucleo metallico e mantello silicatico nei planetesimi differenziati.
Entrata atmosferica e tracce visibili

Durante l’ingresso in atmosfera, la superficie del meteoroide si riscalda, fonde e subisce ablazione. Questo processo scolpisce il corpo e crea le tipiche cavità superficiali denominate regmaglipti. Se l’orientamento rimane stabile a lungo, il profilo può diventare un cono di prua o scudo termico, testimonianza del flusso di gas in regime ipersonico.
Quando la decelerazione riduce la velocità, lo strato fuso si solidifica nella crosta di fusione, di solito nera e sottile. Nei meteoriti rocciosi la zona termicamente alterata è spesso limitata a pochi millimetri; nei meteoriti ferrosi, più conduttivi, gli effetti del calore possono estendersi fino a circa 1 cm sotto la superficie.
Le meteore possono apparire in colori diversi (giallo, verde, rosso), legati alla composizione chimica del corpo e dell’atmosfera. Non sono rari boati, detonazioni e onde d’urto durante le frammentazioni in quota; talvolta rimane in cielo un tracciato di polveri che persiste per minuti. I resoconti sullo stato termico all’impatto variano: alcuni campioni sono descritti come “bollenti al tatto”, altri così freddi da condensare umidità e perfino formare brina.
I meteoroidi che si disintegrano generano talvolta una pioggia di meteoriti con molti individui. L’area di caduta, detta campo di dispersione, è in genere ellittica, allungata nella direzione di volo; spesso i frammenti più massicci si ritrovano nella porzione più lontana del campo.
Dimensioni, impatti e crateri
Le dimensioni dei meteoriti non seguono un formato tipico: tra il 98% e il 99% di quelli che arrivano al suolo rientrano nella scala tra micrometeoriti (granelli) e piccoli ciottoli di circa 6,5 cm di diametro. Eppure, esistono cadute maggiori in grado di creare crateri da impatto ben visibili.
I meteoroidi ferrosi, più resistenti, attraversano l’atmosfera con maggior probabilità e sono spesso associati a crateri iperveloci (esempi classici: Cratera di Barringer in Arizona, Odessa in Texas, Wabar in Arabia e Wolf Creek in Australia). I corpi rocciosi o ghiacciati, anche di dimensioni considerevoli, spesso si frammentano in atmosfera senza lasciare un cratere; eventi rari ma energetici come Tunguska ne sono un esempio.
Su scala planetaria gli impatti hanno un ruolo importante. La grande struttura di Chicxulub (diametro dell’ordine di centinaia di chilometri, spesso indicata attorno a 300 km) è legata all’evento di estinzione di massa di circa 65 milioni di anni fa. Altre strutture note includono Manicouagan, Popigai, Vredefort e il Chesapeake Bay impact.
Cadute, ritrovamenti e reti di osservazione
Un meteorite è detto “caduta osservata” quando la discesa viene vista o registrata e l’oggetto è poi recuperato; in caso contrario, si parla di “ritrovamento”. Le cadute documentate nei database moderni superano le mille unità (oltre 1.100), mentre i ritrovamenti totali classificati contano decine di migliaia di esemplari. La distribuzione delle cadute verificate è influenzata dalla densità di popolazione: si concentrano nelle aree più abitate.
Storicamente e fino a oggi, diverse reti hanno osservato e recuperato meteoriti: il Př\u00edbram in Cecoslovacchia (1959) fu il primo con orbita calcolata da foto multiple; seguirono la Prairie Network negli USA, il progetto canadese MORP, la European Fireball Network e sistemi automatizzati della NASA che monitorano frequentemente i bolidi sul Sud-Est degli Stati Uniti.
Dove si cercano: Antartide e deserti caldi
L’Antartide ha rivoluzionato la ricerca: i flussi di ghiaccio concentrano i meteoriti nelle aree di blue ice. La decima spedizione giapponese scoprì nel 1969 i primi nove campioni a Yamato; negli anni seguenti nacquero programmi sistematici come ANSMET (USA), consorzi europei (EUROMET) e il PNRA italiano. Da queste campagne sono arrivati più di 23.000 campioni classificati e migliaia in attesa.
Anche i deserti caldi sono miniere a cielo aperto: la piana del Nullarbor in Australia, i regs e hamadas della Libia e dell’Algeria (campi come Dar al Gani e Dhofar) favoriscono l’individuazione di rocce scure su sfondi chiari. Negli anni 1990 è esploso il commercio dei meteoriti del Nord-Ovest dell’Africa (NWA), con campioni poi depositati e studiati in collezioni scientifiche, ma anche venduti a collezionisti privati. In Om\u00e0n sono stati recuperati migliaia di esemplari (anche lunari e marziani), e oggi vige una legislazione nazionale che ne proibisce la rimozione senza permessi.
Negli Stati Uniti, i deserti del Sud-Ovest (Mojave, Sonora, Bacino del Grande Lago Salato e Chihuahua) hanno restituito migliaia di meteoriti; esemplari come l’Old Woman (circa 3 tonnellate) e i campi di Franconia e Gold Basin sono celebri. A metà Novecento l’educatore e cacciatore H. H. Nininger dimostrò che i meteoriti sono più comuni di quanto si pensasse, coinvolgendo le comunità rurali (storico il caso della contea di Roosevelt nel New Mexico).
Nomi, tassonomia e alterazione terrestre
I meteoriti prendono il nome dalla località di ritrovamento (città o riferimento geografico); quando le scoperte sono numerose nello stesso luogo, si aggiunge un numero o una lettera (per esempio Allan Hills 84001). La classificazione moderna è complessa e integra tipo, classe, gruppo e caratteristiche petro-mineralogiche.
Una volta sulla Terra, i campioni subiscono alterazione meteorica (acqua, ossigeno, sali). Per i condriti comuni si usa spesso una scala qualitativa W0–W6 per descrivere il grado di alterazione. Esistono perfino meteoriti fossili, molto trasformati ma riconoscibili in rocce sedimentarie antiche: celebri i ritrovamenti ordoviciani in Svezia, con il peculiare \u00d6sterplana 065, tipo “estinto” non più osservato oggi.
Numeri, esempi celebri e casi in Brasile
Si stima che sulla Terra siano stati recuperati oltre 60.000 meteoriti, mentre micrometeoriti cadono quotidianamente in quantità enormi. Tra i giganti, oltre a Hoba (60 t, Namibia), va citato Gancedo in Argentina, circa la metà del peso di Hoba. Tra gli eventi connessi a grandi impatti spicca Chicxulub (diampia scala, area dello Yucat\u00e1n, spesso riportato attorno a 300 km di diametro), legato a una grande estinzione.
Tra i meteoriti più noti ricordiamo Allende (grande condrite carbonacea), ALH 84001 (marziano), Kaidun (condrite complessa), Murchison (ricco di organici), N\u014dgata (caduta datata all’861), Sikhote-Alin (impatto ferroso spettacolare del 1947), Willamette (il più grande trovato negli USA), Campo del Cielo e Cape York. Eventi moderni includono Carancas (Per\u00f9, 2007) e il bolide di Chelyabinsk (Russia, 2013) che ha prodotto frammenti recuperati. E non solo sulla Terra: sulla Luna le missioni Apollo trovarono frammenti meteoritici tra i campioni (per esempio Bench Crater e Hadley Rille), mentre su Marte i rover hanno identificato esemplari come Block Island e Heat Shield Rock.
In Brasile sono stati catalogati finora tra 70 e 80 meteoriti, con prevalenza di tipi rocciosi. I casi storici includono il celebre Bendeg\u00f3 (circa 5,6 t, ferro-nichel, scoperto nel 1784 a Monte Santo, Bahia), Macau (circa 1,5 kg, caduta del 1816 nel Rio Grande do Norte), Santa Luzia (circa 1,9 t, trovato nel 1921 nell’area dell’attuale Luzi\u00e2nia, Goi\u00e1s) e Campinorte (quasi 2 t, 1992, Goi\u00e1s). Recentemente, nel 2021, un nuovo ritrovamento è stato segnalato a Patos de Minas (Minas Gerais) dopo l’avvistamento di una meteora nella regione del Triângulo Mineiro.
Meteorite, meteora, asteroide e cometa: le differenze
Un asteroide è un corpo roccioso o metallico che orbita il Sole, di taglia intermedia (da metri a centinaia di chilometri). Una cometa è più ricca di ghiacci e polveri, sviluppa chioma e coda in prossimità del Sole. Un meteoroide è un frammento più piccolo (da micron a metri) proveniente da questi corpi. La meteora è il fenomeno luminoso causato dall’attrito del meteoroide in atmosfera. Il meteorite è ciò che raggiunge il suolo senza vaporizzarsi del tutto.
Molecole organiche, acqua e indizi sull’origine della vita
I meteoriti non raccontano solo di rocce e metalli. Nel 2015, esperimenti di laboratorio hanno mostrato che partendo da pirimidina (molecola trovata nei meteoriti) è possibile formare uracile, citosina e timina in condizioni simulate di spazio. Nel 2018 sono stati riportati acqua liquida e composti organici complessi in meteoriti antichissimi (circa 4,5 miliardi di anni).
Nel 2019, per la prima volta, sono state rilevate nei meteoriti molecole di zucchero come la ribosio, suggerendo vie chimiche per produrre mattoni fondamentali della vita nei corpi minori. E nel 2022 analisi su meteoriti ricchi di carbonio hanno identificato tutte le basi azotate del DNA e dell’RNA (A, T, G, C, U), rafforzando l’ipotesi che ingrediente e ricette chimiche possano essere stati distribuiti nello spazio e consegnati ai pianeti attraverso le cadute.
Cultura, storia e casi documentati
I meteoriti hanno segnato anche la nostra storia culturale. Le più antiche perle di ferro meteoritico note (Egitto, circa 3200 a.C.) testimoniano l’uso di questo metallo prima della siderurgia. Il culto del Tempio di Artemide a Efeso è stato talvolta associato alla venerazione di una “pietra caduta dal cielo”. La Pietra Nera della Kaaba è stata ipotizzata come meteoritica, ma le prove restano inconclusive.
Nel 1064 d.C., il polimata cinese Shen Kuo descrisse un evento con cratere e corpo roccioso ancora caldo. Nel 1794 il fisico Ernst Chladni propose con coraggio l’origine extraterrestre dei meteoriti; l’idea fu consolidata nel 1803 dallo studio di Jean-Baptiste Biot dopo la spettacolare pioggia di L’Aigle in Francia.
I casi moderni includono Sylacauga (Alabama, 1954: meteorite che fer\u00ec una persona), Mbale (Uganda: un piccolo frammento colp\u00ec un ragazzo senza gravi conseguenze) e il caso del 2021 a Golden (Columbia Britannica), quando un meteorite attravers\u00f2 un tetto e atterr\u00f2 su un letto senza ferire nessuno. A scala globale, ogni anno da cinque a dieci cadute vengono osservate, recuperate e descritte scientificamente.
Per finire, vale una nota tassonomica: non confondiamo i tectiti con i meteoriti. I primi sono vetri naturali formati dall’impatto di grandi corpi con la Terra, gocce di roccia fusa poi rapidamente solidificata; frequenti fraintendimenti li hanno erroneamente etichettati come meteoriti, ma l’origine \u00e8 terrestre sebbene innescata da un impatto extraterrestre.
Questo viaggio tra origine, tipi, cadute e ritrovamenti mostra quanto i meteoriti siano archivi geologici e chimici del Sistema Solare: raccontano di asteroidi e comete, di impatti che hanno modellato pianeti e di molecole prebiotiche forse cruciali per la vita. Dalle pianure ghiacciate antartiche ai deserti nordafricani, fino ai musei e ai laboratori, ogni campione \u00e8 una pagina di storia cosmica caduta a portata di mano.
