- Demarcazione multilivello: criteri teorici e pratici per separare scienza, antiscienza e pseudoscienza.
- Metodi e norme: falsificabilità, progresso dei programmi di ricerca, ethos di Merton e checklist in 7 punti.
- Esempi concreti: astrologia, design intelligente, omeopatia, pseudoarcheologia e negazionismi.
- Implicazioni: scuola, sanità, tribunali, media e ambiente richiedono criteri rigorosi e prove robuste.
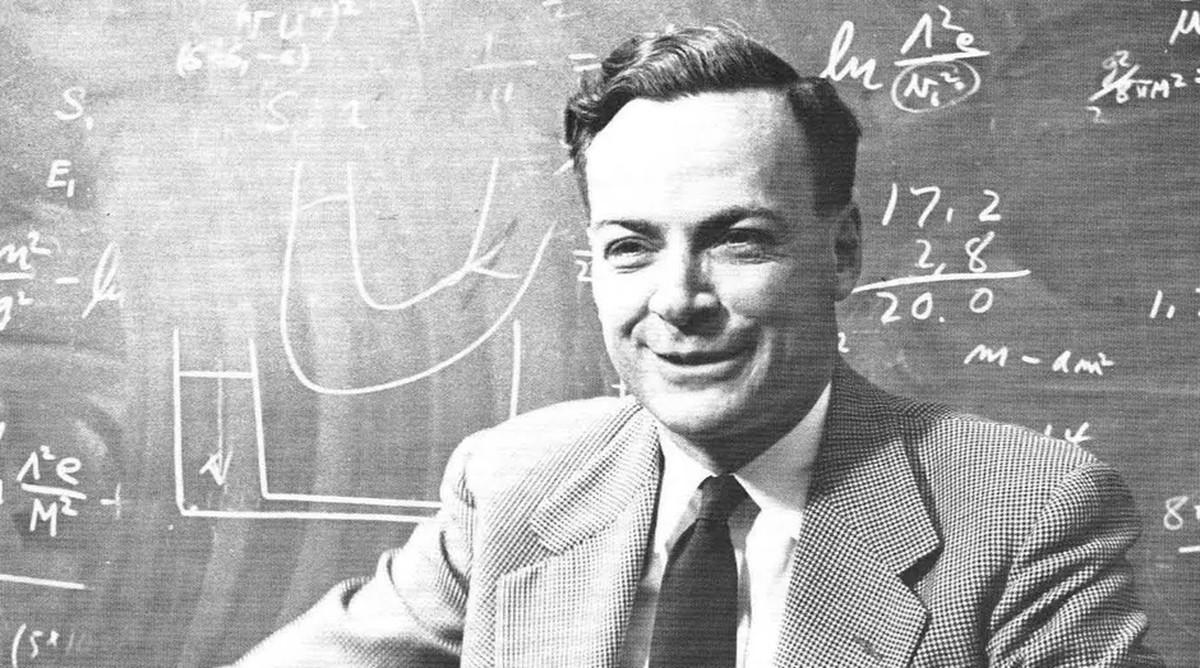
Capire dove finisce la scienza e dove iniziano pseudoscienza e credenza non è un esercizio accademico: incide su salute, giustizia, informazione e democrazia. In questo articolo trovi una guida completa, con criteri di demarcazione, esempi concreti e le principali idee filosofiche che hanno segnato il dibattito, da Popper a Kuhn fino a Lakatos e Merton. Per orientarsi è utile il pensiero critico come strumento di valutazione.
La parola “pseudoscienza” ha sempre avuto una connotazione denigratoria, ma non basta dire che qualcosa “non è scienza”. Serve distinguere tra non‑scienza, antiscienza e pseudoscienza, capire come si applicano i criteri e perché il confine non può essere fuori dal tempo. Inoltre, c’è molto più accordo su casi specifici (astrologia, creazionismo, omeopatia, negazionismi vari) che non sui criteri universali da usare: un segnale che il lavoro filosofico qui è ancora aperto. Per definire meglio le competenze richieste si può consultare una sintesi sugli elementi del pensiero critico.
Perché la demarcazione conta
Separare scienza e pseudoscienza ha risvolti teorici e pratici. Sul piano teorico, illumina cosa renda giustificate le nostre credenze; sul piano pratico, orienta scelte in sanità, tribunali, politiche ambientali, scuola e giornalismo. La scienza è la fonte più affidabile di conoscenza in molte aree, perciò distinguere il sapere robusto dalle sue imitazioni è cruciale. Il processo richiede spesso approcci di pensiero analitico per valutare prove e metodi.
- Assistenza sanitaria: servono criteri per non finanziare né proporre interventi inefficaci o rischiosi camuffati da “scientifici”.
- Prove in tribunale: il giudizio esperto deve basarsi sul miglior sapere disponibile, non su tecniche screditate.
- Politiche ambientali: distinguere tra rischi supportati da prove e allarmi infondati guida decisioni preventive sensate.
- Istruzione scientifica: i curricula devono filtrare dottrine non affidabili presentate come scienza.
- Giornalismo: evitare “false controversie” tra consenso esperto e tesi confutate riduce disinformazione su clima, vaccini e simili; capire l’importanza dei media è parte della soluzione.
Che cosa intendiamo per scienza, non‑scienza, antiscienza e pseudoscienza
Nel linguaggio comune “scienza” è in parte descrittivo e in parte normativo: chiamiamo scienza ciò che reputiamo affidabile, ma il termine è nato storicamente. In senso ampio (alla tedesca “Wissenschaft”), include tutte le indagini sistematiche e critiche su natura, persone e società, dalle naturali alle sociali fino alle umanistiche. La distinzione tocca anche i tipi di pensiero che usiamo per interpretare i dati.
Non‑scienza copre attività al di fuori della metodologia scientifica (es. metafisica, religione, saperi pratici). Antiscienza è più stretto: indica ostilità o conflitto con risultati e metodi scientifici. Pseudoscienza è ancora più ristretto: è non‑scienza che si presenta come scienza o come il sapere più affidabile sul tema, pur violando metodi e risultati consolidati. In questi casi spesso entrano in gioco diversi tipi di ragionamento usati in modo parziale o fuorviante.
Il “pseudo” di pseudoscienza: pretese, dottrine e casi limite
Etimologicamente “pseudo” significa “falso”: molte pratiche falliscono perché mimano la scienza (linguaggio tecnico, formule, strumenti) senza la sostanza metodologica. Due condizioni spesso ricorrono: non è scienza e i principali promotori creano l’impressione di scientificità oppure di rappresentare “il sapere più sicuro” anche senza dirsi scienza. Comprendere queste dinamiche richiede anche pensiero complesso, che valuta relazioni e contesti.
Un punto chiave è il componente dottrinale: la pseudoscienza tende a promuovere una dottrina deviante persistente, non solo errori isolati. Ecco tre scenari tipo (parafrasati): un errore sperimentale isolato è cattiva scienza, una carriera piena di errori senza dottrina alternativa è ancora cattiva scienza, ma una serie di lavori scadenti usati per sostenere una teoria non ortodossa sconfessata dai dati rientra nella pseudoscienza. In questi casi può mancare un adeguato pensiero interrogativo che metta in crisi le assunzioni.
Quando e dove applicare la demarcazione
I “bersagli” della demarcazione sono vari: programmi di ricerca, discipline, teorie, pratiche, singole indagini o problemi. È sensato applicare i criteri a più livelli, ma è difficile ridurre tutti i giudizi a un solo piano fondamentale. Contano tanto le istituzioni e la critica organizzata quanto le capacità del singolo ricercatore. Spesso occorrono strategie creative di pensiero, come il pensiero laterale, per esplorare nuovi test e ipotesi.
Importante anche l’aspetto temporale: la scienza evolve, quindi una demarcazione “fuori dal tempo” non regge. Una dottrina può essere stata “scienza” in un’epoca e non esserlo più una volta rifiutate le confutazioni ben fondate e ignorati i progressi metodologici.
I grandi criteri a confronto: dal verificacionismo al falsificazionismo
I positivisti logici puntavano sulla verificabilità per distinguere scienza e metafisica, ma la linea con la pseudoscienza rimaneva sfocata. Popper spostò l’attenzione sulla falsificabilità: una teoria è scientifica se può entrare in conflitto con osservazioni possibili. Questa svolta ha segnato la filosofia della scienza del Novecento. Interpretare queste teorie richiede anche conoscenze di come il pensiero illustrato ha influenzato la diffusione delle idee scientifiche.
La falsificabilità, però, ha limiti pratici: rischia di escludere scienza legittima o includere tesi strampalate se strutturate in modo confutabile. Alcune pratiche pseudoscientifiche, come l’astrologia, sono state testate e confutate, senza che ciò le renda scienza. D’altra parte, scienze complesse possono essere “difficili da testare” senza essere per questo non scientifiche.
Scienza normale e risoluzione di rompicapi
Kuhn osserva che la scienza vive soprattutto nella fase di “scienza normale”: risoluzione di rompicapi entro un paradigma. Qui sta la differenza con la pseudoscienza: quando un’osservazione va storta, lo scienziato cerca misure migliori o aggiusta la teoria, generando nuovi rompicapi e ricerca. In discipline come l’astrologia, gli insuccessi non aprono programmi di indagine, segno che manca l’ecosistema tipico della scienza. L’uso di tecniche di pensiero laterale e creativo è spesso fondamentale nella risoluzione di rompicapi reali.
Popper criticò l’idea di “rompicapo” come criterio, temendo un approccio sociologico più che razionale. Ma il punto kuhniamo resta utile: la vitalità interna di una disciplina nel generare e risolvere problemi è un indicatore prezioso di scientificità.
Programmi di ricerca e progresso: Lakatos, Thagard e altri
Per Lakatos la demarcazione si applica ai programmi di ricerca, sequenze di teorie con un “nucleo” stabile. Un programma è progressivo se produce previsioni nuove confermate e degenerativo se rincorre i fatti a posteriori. La scienza avanza quando il contenuto empirico cresce e le teorie più nuove spiegano più della precedente. Valutare questi processi spesso si fa con approcci che combinano diversi .
Thagard propone due criteri: una teoria o disciplina è pseudoscientifica se non progredisce e se la comunità dei praticanti non tenta seriamente di risolvere i problemi, selezionando conferme e ignorando smentite. Altri, come Rothbart e Reisch, sottolineano rispettivamente i criteri di eleggibilità al test e l’integrazione nella rete delle scienze come marcatori di scientificità.
Etica e norme della pratica scientifica: Merton e oltre
Merton riassume l’“ethos” della scienza in quattro imperativi: universalismo (valutare idee con criteri impersonali), comunalità (i risultati appartengono alla comunità), imparzialità (controlli per frenare interessi personali o ideologici) e scetticismo organizzato (apertura al controllo anche di credenze radicate). Queste norme, pur discusse, spiegano perché la scienza è affidabile. L’adozione di pratiche trasparenti è anche parte di una cultura di pensiero illustrato e condiviso.
Molti autori convergono su approcci a criteri multipli: non esiste un unico attributo definitorio, ma una famiglia di somiglianze (alla Wittgenstein). La pseudoscienza può deviare in modi diversi, motivo per cui serve una checklist articolata.
Checklist pratica: sette segnali di allarme
Ecco una lista sintetica di scostamenti tipici dalla buona pratica scientifica. Più voci compaiono insieme, più probabile che sia pseudoscienza.
- Autorità al posto delle prove: verità fissate da “figure speciali” da accettare senza verifica.
- Esperimenti irripetibili: risultati che nessuno replica nelle stesse condizioni.
- Cherry picking: selezione di esempi favorevoli, ignorando il quadro complessivo.
- Resistenza al test: si evita di mettere alla prova la teoria, pur potendolo fare.
- Ignorare le confutazioni: dati contrari accantonati o sminuiti.
- Scappatoie incorporate: test architettati per confermare sempre e non smentire mai.
- Spiegazioni abbandonate senza sostituzioni: la nuova versione spiega meno della precedente.
Perché attecchisce la pseudoscienza: fiducia cieca e volti assenti
La scienza gode di ampia fiducia pubblica, ma spesso senza volto né luoghi riconosciuti. Un’indagine citata a livello nazionale mostrava come molte persone si fidino della scienza ma non sappiano nominare scienziati o istituzioni di ricerca del proprio Paese. Questo vuoto di riconoscibilità rende facile per chiunque appropriarsi dell’etichetta “scientifico” e beneficiare della sua credibilità.
Quando l’“aura scientifica” diventa una scorciatoia retorica, strumenti e gergo sostituiscono i metodi: ecco perché apparenze di complessità (formule, grafici, dispositivi “misteriosi”) seducono. Ma la scienza vera è rigore, umiltà, scetticismo, apertura e flessibilità: senza questi ingredienti, resta solo la facciata.
Esempi tipici: pseudoarcheologia, astrologia, design intelligente, omeopatia
L’pseudoarcheologia esemplifica bene il problema: collezione di reperti e letture forzate senza metodo, spesso a sostegno di tesi come gli “antichi alieni”. Queste narrazioni ignorano la convergenza di datazioni, filologia, stratigrafia e analisi materiali che caratterizza l’archeologia scientifica.
L’astrologia sostiene che la posizione dei corpi celesti influenzi personalità e eventi. La ricerca empirica ha ripetutamente messo in discussione tali affermazioni: ad esempio, studi pubblicati su riviste di psicologia non hanno trovato correlazioni robuste tra indicatori astrologici (Sole, Luna, Ascendente) e tratti di personalità autoreferiti o giudicati da terzi. Inoltre, alcuni lavori hanno trovato associazioni tra credulità astrologica e tratti narcisistici, con un possibile legame alla resistenza ai fatti quando l’astrologia è percepita come “supportata dalla scienza”.
Il design intelligente propone che certe strutture biologiche siano “troppo complesse” per l’evoluzione, invocando un progettista. Questa mossa è stata criticata scientificamente e smonta l’evidenza comparativa, genetica e paleontologica. In pratica, non genera previsioni testabili migliori del darwinismo, ma sposta il mistero un passo indietro senza accrescerne il contenuto empirico.
L’omeopatia è uno dei casi più discussi in sanità: diluizioni estreme che, sotto verifica, non mostrano efficacia superiore al placebo in maniera consistente. Il placebo esiste e può far sentire meglio, ma il suo campo d’azione è limitato e non sostituisce terapie efficaci. Affidare risorse a trattamenti che non superano test rigorosi sottrae opportunità a cure realmente efficaci.
Religione come teoria? Una lettura filosofica controversa
Alcuni filosofi propongono di considerare la religione come un insieme di ipotesi interconnesse che spiegano aspetti del mondo (origini, morale, eventi storici). Con questa lente, si può chiedere: le sue previsioni osservative sono confermate? In molti casi storici, affermazioni tradizionali (es. terra di 6000 anni, diluvio globale, coppia unica a fondare la specie, efficacia della preghiera intercessoria come fenomeno misurabile) non superano controlli empirici moderni.
Alla luce di Lakatos, si può domandare se il “programma” religioso produca previsioni nuove e confermate o se ripieghi su aggiunte ad hoc non testabili, su reinterpretazioni allegoriche post hoc o su negazione di smentite consolidate. Quando prevale la seconda dinamica, il programma degenera. Questa è una tesi filosofica discussa e non vincola la sfera di fede personale, ma chiarisce lo scontro metodologico tra conoscenza pubblica testabile e convinzione non sottoponibile a prova.
Pseudoscienza, negazione e resistenza ai fatti
Non tutta la pseudoscienza “promuove” teorie; una parte importante è negazionismo: contestare risultati robusti creando false controversie mediatiche. È accaduto storicamente con relatività, con i danni del tabacco, avviene con il cambiamento climatico o con i vaccini. Le tattiche includono selezione di outlier, attacchi agli scienziati e confusione tra dissenso legittimo e posizioni confutate.
Il termine “scetticismo” è usato in tre sensi: scetticismo filosofico (metodologico), difesa della scienza (smontare pseudoscienze) e negazione mascherata da scetticismo (“scettici del clima”). Chiamare quest’ultima forma pseudoscetticismo evita ambiguità: qui lo scetticismo è selettivo e non applicato alle tesi preferite.
Cosa significa per media, scuola, sanità, tribunali e ambiente
Per i media, la sfida è rappresentare correttamente l’incertezza reale senza par condicio tra scienza e tesi smentite. Nella scuola, servono criteri di inclusione che proteggano gli studenti da dottrine già confutate. In sanità, piani e assicurazioni devono basarsi su efficacia provata. In tribunale, il metodo deve prevalere su prove seducenti ma inattendibili. Nelle politiche ambientali, va applicato il principio di precauzione quando le prove, anche se non definitive, indicano rischi concreti.
Intorno a queste applicazioni pratiche, la comunità scientifica mostra ampia convergenza su molti casi specifici di demarcazione: creazionismo, astrologia, omeopatia, rabdomanzia, bioeletrografia, teorie degli “antichi astronauti”, negazione dell’Olocausto o del riscaldamento globale sono riconosciute come pseudoscienze. Rimangono zone grigie (es. alcuni ambiti psicoanalitici), ma il quadro generale è sorprendentemente unitario.
Riconoscere la pseudoscienza diventa semplice con un po’ di pratica: quando mancano rigore, test severi, apertura alle confutazioni e integrazione con il resto della conoscenza, resta solo la superficie. La scienza, invece, si riconosce da umiltà, scetticismo organizzato, trasparenza e capacità di cambiare idea davanti a buone prove.
