- I principali oncovirus (HPV, HBV, HCV, EBV, HHV-8, HTLV-1, MCPyV) causano una quota rilevante di tumori a livello globale.
- Vaccini (HBV, HPV), eradicazione di H. pylori e terapie per HCV riducono nettamente il rischio di cancro.
- Il carico attribuibile a infezioni varia per area e reddito; serve integrazione tra programmi infettivologici e oncologici.
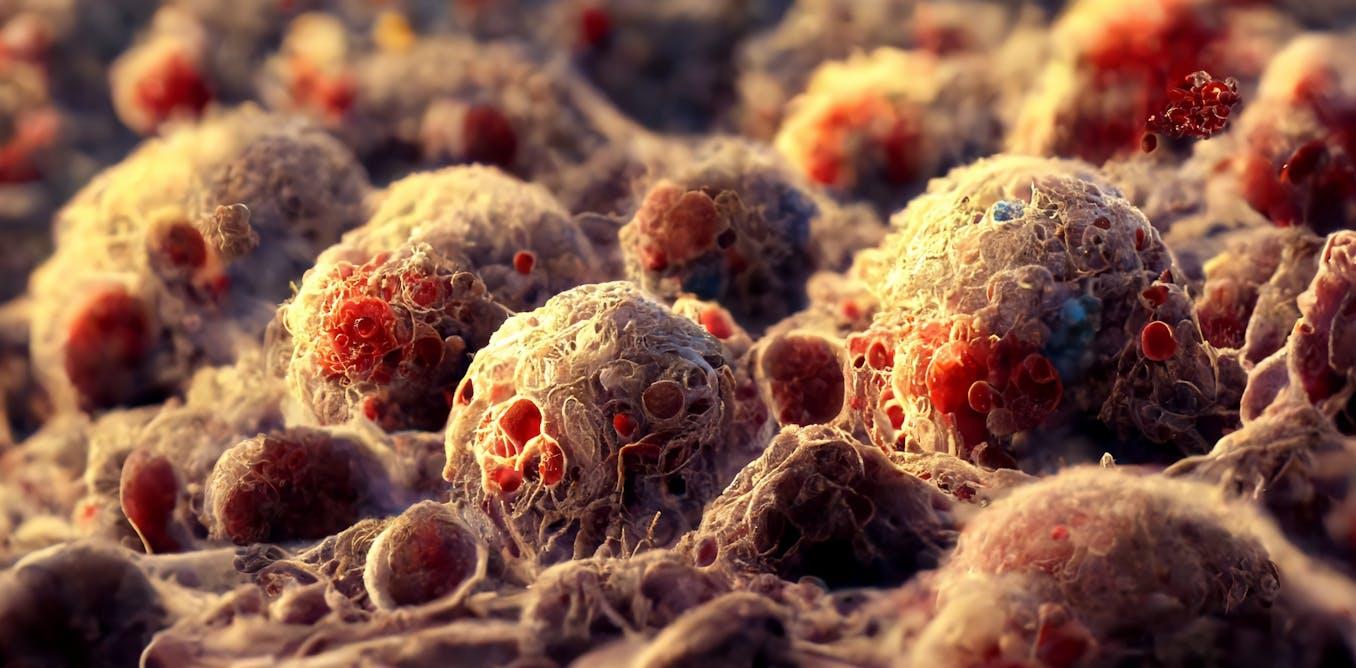
Quando si sente la parola “virus” ormai molti pensano subito a pandemie, e non a torto; tuttavia, alcuni virus hanno un’altra faccia meno discussa: possono contribuire allo sviluppo di tumori. Non si tratta di un evento immediato, né inevitabile, ma di un legame complesso in cui l’infezione virale, l’immunità dell’ospite e altri fattori ambientali convivono per anni prima che compaia il cancro.
Per capire il quadro completo, vale la pena distinguere cos’è un virus, come nasce un tumore e quali agenti infettivi sono coinvolti. La scienza ha identificato almeno sette oncovirus principali e diversi altri microrganismi (batteri e parassiti) che, in specifiche condizioni, aumentano il rischio oncologico. E la buona notizia è che per alcuni di essi esistono vaccini efficaci o terapie capaci di ridurre drasticamente il rischio.
Che cos’è un virus
Un virus è un “pacchetto” microscopico di materiale genetico (DNA o RNA) rivestito da proteine che, per replicarsi, sfrutta la macchina cellulare dell’organismo che infetta. Alcuni virus sono in grado di integrare il proprio genoma in quello della cellula ospite, alterando i circuiti di controllo della crescita cellulare e promuovendo l’instabilità genetica.
Questa integrazione, insieme a processi come l’infiammazione cronica, può indurre mutazioni e spegnere i freni fisiologici che impediscono alle cellule di proliferare senza controllo. È uno dei motivi per cui certe infezioni di lunga durata, in rari casi e dopo anni o decenni, si associano a specifiche forme di cancro.
Che cos’è il cancro e come si sviluppa
Il cancro è una malattia genetica caratterizzata da perdita di controllo della divisione cellulare, fuga dai meccanismi di riparazione e capacità di invadere altri tessuti (metastasi). Non tutte le infezioni portano a tumore: anzi, la maggior parte no. Quando succede, in genere è il risultato di una lunga “collaborazione” tra l’agente infettivo e fattori aggiuntivi come immunosoppressione, predisposizione genetica, mutazioni casuali o esposizione a carcinogeni ambientali.
È utile ricordare che la cronologia è lenta: i tumori associati ai virus emergono di solito molti anni dopo l’infezione primaria. Per questo prevenzione, diagnosi precoce e controllo dei cofattori sono determinanti.
Virus oncogeni: panoramica
Si stima che dal 12% al 20% dei tumori a livello globale sia collegato ad agenti infettivi. La quota attribuibile ai virus oscilla intorno al 15% e in alcuni Paesi a medio-basso reddito può arrivare a circa un terzo di tutti i casi. I principali oncovirus noti includono EBV (virus di Epstein-Barr), HBV e HCV (virus delle epatiti B e C), HPV (papillomavirus umano), HHV-8/KSHV (herpesvirus associato al sarcoma di Kaposi), HTLV-1 (virus linfotropico T umano tipo 1) e MCPyV (poliomavirus a cellule di Merkel).
Questi virus condividono caratteristiche funzionali: stabiliscono infezioni persistenti, possono modulare le risposte immunitarie, e spesso codificano proteine che stimolano la proliferazione o bloccano i soppressori tumorali dell’ospite. I tumori collegati all’infezione compaiono molto tempo dopo l’esposizione (anche 15–40 anni), confermando un processo multistep.
Virus a DNA correlati ai tumori
Epatite B (HBV)
Sul fronte della prevenzione, la vaccinazione anti-HBV ha ridotto drasticamente incidenza e mortalità. Nei Paesi come la Spagna il vaccino è nel calendario infantile (dosi, ad esempio, a 2, 4 e 11 mesi) e ha dimostrato impatto nella riduzione delle infezioni. La ricerca esplora anche vie vaccinali alternative (per esempio, somministrazione orale) per semplificare logistica e costi.
Herpesvirus umano 8 (HHV-8/KSHV)
Studi recenti hanno identificato come HHV-8 rimodelli il metabolismo delle cellule infette attivando vie che coinvolgono le chinasi CDK6 e l’enzima CAD per spingere la produzione di nucleotidi e la glicolisi. L’inibizione farmacologica (per esempio, palbociclib per CDK6) ha mostrato in modelli preclinici riduzioni importanti della replicazione virale, blocco della progressione linfomatosa e forti cali del volume tumorale, suggerendo possibili nuove strategie terapeutiche.
Virus di Epstein-Barr (EBV)
EBV, un herpesvirus, è estremamente diffuso: oltre il 90% degli adulti è portatore. È l’agente della mononucleosi infettiva e si associa a linfomi a cellule B e T, malattia di Hodgkin e carcinoma nasofaringeo (sede di infezione primaria spesso nel distretto rinofaringeo). Solo una minoranza degli infetti sviluppa tumori, segno che servono cofattori (per esempio, fumo, inquinanti, pesticidi o altri elementi ambientali).
In età pediatrica e adolescenziale, EBV contribuisce a una piccola quota dei tumori (ad esempio circa il 2,2% in analisi statunitensi), ma la sua rilevanza epidemiologica resta alta per diffusione e tropismo per il sistema linfoide.
Papillomavirus umano (HPV)
La vaccinazione anti-HPV è una misura di prevenzione cardine: in Spagna è gratuita e raccomandata soprattutto per le ragazze tra 11 e 14 anni; molti Paesi hanno esteso la raccomandazione ad entrambi i sessi in età preadolescenziale. Gli studi mostrano efficacia elevata (anche fino al 95%) nel prevenire lesioni precancerose cervicali correlate ai tipi di HPV coperti.
Virus a RNA correlati ai tumori
Epatite C (HCV)
HCV è un virus a RNA (Flaviviridae) che induce epatite cronica, con possibile evoluzione in cirrosi e carcinoma epatocellulare. La trasmissione avviene per contatto con sangue (per esempio, condivisione di aghi) e attraverso rapporti sessuali a rischio; la prevalenza globale dei portatori è stata stimata intorno al 3%.
A differenza dell’HBV, non esiste un vaccino efficace contro HCV a causa dell’elevata variabilità del suo genoma; tuttavia, le terapie antivirali ad azione diretta consentono oggi la guarigione virologica nella maggior parte dei pazienti, riducendo il rischio di HCC se trattati per tempo.
Virus dell’immunodeficienza umana (HIV)
HIV è un retrovirus che provoca immunosoppressione, riducendo l’efficienza del sistema immunitario nel tenere a bada gli oncovirus. Le persone con HIV hanno un rischio più alto di sarcoma di Kaposi, linfomi (Hodgkin e non-Hodgkin), tumori della cervice e altri (ano, fegato, bocca-gola, polmone). Si trasmette tramite sangue, sperma, secrezioni vaginali e latte materno.
La terapia antiretrovirale di combinazione ha cambiato la storia naturale dell’infezione, ma la prevenzione dei tumori legati a co-infezioni rimane una priorità, inclusa la vaccinazione anti-HBV e l’accesso a screening mirati (per esempio per HPV).
Virus linfotropo T umano di tipo 1 (HTLV-1)
HTLV-1 è un retrovirus associato a leucemia/linfoma a cellule T dell’adulto (ATLL), con un lungo periodo di latenza (20–30 anni). Una volta che la malattia si manifesta, la progressione può essere rapida e la sopravvivenza media bassa (anche intorno a 8 mesi).
Si trasmette per via sessuale, perinatale e tramite sangue. A livello globale si stima che interessi decine di milioni di persone (circa 12–25 milioni). Non esistono vaccini specifici e la prevenzione passa per lo screening delle donazioni e l’educazione ai comportamenti a rischio.
Altri agenti infettivi carcinogeni
Oltre ai virus, alcuni batteri e parassiti sono classificati come carcinogeni. Le principali evidenze riguardano Helicobacter pylori e due trematodi epatici/urinarî, ma esistono altri agenti con vari gradi di evidenza.
Helicobacter pylori è collegato alla maggior parte dei tumori gastrici non cardiali e al linfoma MALT; si acquisisce spesso nell’infanzia e si trasmette probabilmente con alimenti/acqua contaminati o per via oro-orale. La sua eradicazione con antibiotici riduce il rischio di cancro dello stomaco.
Opisthorchis viverrini, diffuso nel Sud-est asiatico, è associato al colangiocarcinoma e si contrae mangiando pesce d’acqua dolce crudo o poco cotto; il trattamento prevede antiparassitari.
Schistosoma haematobium, presente in Africa e Medio Oriente, può aumentare il rischio di cancro della vescica. L’infezione avviene con il contatto cutaneo in acque dolci contaminate; anche in questo caso si utilizzano farmaci antiparassitari specifici.
Poliomavirus a cellule di Merkel (MCPyV) è associato all’aggressivo carcinoma a cellule di Merkel, un raro tumore cutaneo che interessa spesso volto, testa-collo e arti superiori. Il rischio cresce in età avanzata e in soggetti immunodepressi; ridurre l’esposizione ai raggi UV e controllare cambiamenti cutanei sospetti sono misure prudenti.
Quali tumori sono legati alle infezioni (evidenza)
Le classificazioni dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) separano gli agenti in base alla forza delle prove: Gruppo 1 (cancerogeni certi), 2A (probabili) e 2B (possibili). Nel Gruppo 1 rientrano, tra gli altri, H. pylori, HTLV-1, KSHV/HHV-8, Schistosoma haematobium, Opisthorchis viverrini, EBV, HBV, HCV, HIV e alcuni tipi di HPV; in 2A troviamo MCPyV, Plasmodium falciparum e altri tipi di HPV; in 2B i poliomavirus BK e JC, Schistosoma japonicum e ulteriori tipi di HPV.
Siti tumorali e agenti con evidenza sufficiente includono: cavità orale (HPV-16), orofaringe/tonsille (HPV-16), nasofaringe (EBV), stomaco (H. pylori), ano (HPV-16, HIV), fegato (HBV, HCV), vie biliari (Opisthorchis viverrini), sarcoma di Kaposi (HHV-8, HIV), vulva/vagina/pene/collo dell’utero (diversi tipi di HPV e HIV), vescica (S. haematobium), linfomi (EBV, HHV-8, HCV, HIV) e ATLL (HTLV-1).
In altri distretti le prove sono limitate o in valutazione (per esempio, EBV nello stomaco, HPV nella laringe, MCPyV nel carcinoma cutaneo non melanoma). In generale, HIV agisce come amplificatore di rischio in combinazione con altri agenti oncogeni.
Carico globale e differenze geografiche
Secondo le stime GLOBOCAN 2018, sono stati attribuiti alle infezioni 2,2 milioni di nuovi casi di tumore, pari a circa 25 casi ogni 100.000 persone/anno. Oltre il 90% di questi casi è dovuto a H. pylori (~810.000; 8,7/100.000), HPV (~690.000; 8,0/100.000), HBV (~360.000; 4,1/100.000) e HCV (~160.000; 1,7/100.000).
Il carico varia molto: in Asia orientale si raggiungono ~37,9/100.000 (la Cina contribuisce a circa un terzo dei casi globali), nell’Africa subsahariana ~33,1/100.000, mentre in Asia occidentale e in Europa settentrionale si stimano ~13,8 e ~13,6/100.000. Il carico attribuibile a HPV cresce al diminuire del reddito (circa 3,6/100.000 nei Paesi ad alto reddito contro ~16,1/100.000 in quelli a basso reddito).
Analisi GLOBOCAN 2012 attribuivano alle infezioni circa il 15,4% dei tumori globali (uno su sei), con picchi oltre il 30% in alcune aree a medio-basso reddito. In Africa subsahariana, per esempio, il sarcoma di Kaposi è stato tra i maggiori contributori del carico oncologico.
Studi nazionali confermano differenze interne: in Spagna (2013–17), circa 1 decesso su 12 per cancro è stato attribuito a infezioni cancerogene, con H. pylori responsabile di quasi la metà dei casi e, insieme a HCV, HPV e HBV, di oltre il 95% del totale.
Nei Stati Uniti (2017), il 4,3% dei tumori dell’adulto è stato attribuito a otto agenti (HPV, H. pylori, HCV, EBV, HBV, MCPyV, KSHV, HTLV-1). Il contributo era più alto nei 20–34 anni (donne ~9,6%; uomini ~6,1%) e più basso ≥65 anni (donne ~3,2%; uomini ~3,3%). Nei bambini e adolescenti, EBV rappresentava circa il 2,2% dei casi oncologici.
Fattori di rischio oncologici da considerare
Oltre alle infezioni, numerosi fattori modulano il rischio di cancro. Tra i principali: tabacco, alcol, dieta, obesità, inattività fisica, radiazioni ionizzanti, inquinanti ambientali, ormoni, invecchiamento, familiarità, infiammazione cronica e immunosoppressione. Limitare l’esposizione ai fattori evitabili, insieme alla prevenzione delle infezioni oncogene, può ridurre in modo sostanziale il rischio.
Prevenzione, controllo e vaccinazioni
Quattro grandi protagonisti del carico oncogeno infettivo (H. pylori, HPV, HBV e HCV) sono oggi affrontabili con vaccini (HPV, HBV) o con terapie efficaci (eradicazione di H. pylori e cura dell’HCV). Interventi comportamentali (sicurezza alimentare, sesso protetto, riduzione delle esposizioni a sangue e aghi condivisi) riducono ulteriormente la trasmissione.
Molti Paesi, tra cui la Spagna, adottano la vaccinazione universale anti-HBV nel primo anno di vita (per esempio 2–4–11 mesi) con strategie di recupero per suscettibili fino ai 18 anni e programmi per gruppi a rischio (operatori sanitari, immunodepressi). Analogamente, la vaccinazione anti-HPV in preadolescenza è raccomandata e sempre più spesso offerta a ragazze e ragazzi (10–12 anni) con recupero fino ai 18 anni e schemi a 2 dosi distanziate.
Per le epatiti virali, oltre al vaccino HBV, lo screening di HCV nei nati in specifici range di età e nei gruppi a rischio consente diagnosi e trattamento precoci. In caso di epatite B, mantenere uno stile di vita epatoprotettivo (niente alcol/droghe, dieta equilibrata, attività fisica, riposo adeguato) e follow-up regolari aiuta a contenere danno e progressione.
Diagnostica e nuove frontiere
La ricerca guarda oltre la prevenzione classica. Un esempio è HPV-DeepSeek, un test del sangue sperimentale che combina intelligenza artificiale e sequenziamento del genoma dell’HPV, con l’obiettivo di individuare i tumori di testa e collo associati a HPV anche anni prima dei sintomi. È una tecnologia in sviluppo, ma indica la direzione: diagnosi sempre più precoce e mirata.
Analogamente, il filone metabolico su HHV-8/KSHV mostra come colpire vulnerabilità della cellula infetta (per esempio CDK6/CAD) possa ridurre replicazione virale e crescita tumorale. Studi preclinici con palbociclib hanno riportato riduzioni importanti di massa tumorale e incrementi delle sopravvivenze in modelli selezionati, aprendo scenari per trial clinici combinati.
L’implementazione resta la sfida: serve integrazione tra programmi di controllo delle malattie infettive (vaccinazioni, screening, terapia) e piani oncologici nazionali, specialmente nei Paesi a medio-basso reddito dove il carico attribuibile a infezione è più alto.
Trasmissione e consigli pratici per agenti selezionati
EBV si diffonde soprattutto con la saliva (baci, condivisione di bicchieri/spazzolini) e anche per via sessuale, trasfusioni e trapianti; non esiste vaccino né terapia specifica per l’infezione. La maggior parte delle persone è infettata senza sviluppare sintomi o tumori.
HBV e HCV si trasmettono col sangue; HBV anche per via sessuale e verticale madre–neonato. I bambini vengono vaccinati routinariamente contro HBV dagli anni ’80; si raccomanda la vaccinazione degli adulti a rischio. Per HCV, lo screening mirato e l’accesso alle nuove terapie consentono la guarigione e riducono il rischio di HCC.
HIV aumenta il rischio oncologico in combinazione con altri agenti; si trasmette per sangue e rapporti non protetti. L’uso di terapia antiretrovirale, la prevenzione combinata (PrEP/PEP, preservativi) e lo screening per HPV, HBV e HCV riducono i rischi.
HPV si trasmette per contatto sessuale (vaginale, orale, anale). Esistono vaccini multivalenti che coprono i tipi più oncogeni; gli screening cervicali (Pap test, HPV test) rilevano alterazioni trattabili prima della trasformazione in carcinoma.
HTLV-1 si diffonde per sangue, via sessuale e perinatale; la prevenzione si basa su screening delle donazioni, informazione sui comportamenti a rischio e, dove indicato, sulla gestione dell’allattamento e del parto per ridurre la trasmissione madre–figlio.
KSHV/HHV-8 si trasmette soprattutto con la saliva e, in alcune aree, per contatti intrafamiliari; nei Paesi a bassa prevalenza il vettore principale è spesso il contatto sessuale. Non esistono vaccini; evitare pratiche a rischio e controllare l’HIV abbassa la probabilità di malattia.
Infine, per MCPyV la trasmissione avviene verosimilmente per contatti cutanei diretti/indiretti, spesso in età infantile; non sono disponibili vaccinazioni o terapie specifiche per l’infezione, quindi fotoprotezione e attenzione a lesioni cutanee atipiche rimangono centrali.
Comprendere il ruolo degli agenti infettivi nella cancerogenesi consente di agire su prevenzione primaria (vaccini, comportamenti), secondaria (screening) e terziaria (terapie mirate). Un approccio integrato, adattato al profilo epidemiologico locale, è la chiave per ridurre incidenza e mortalità dei tumori correlati a infezioni.
