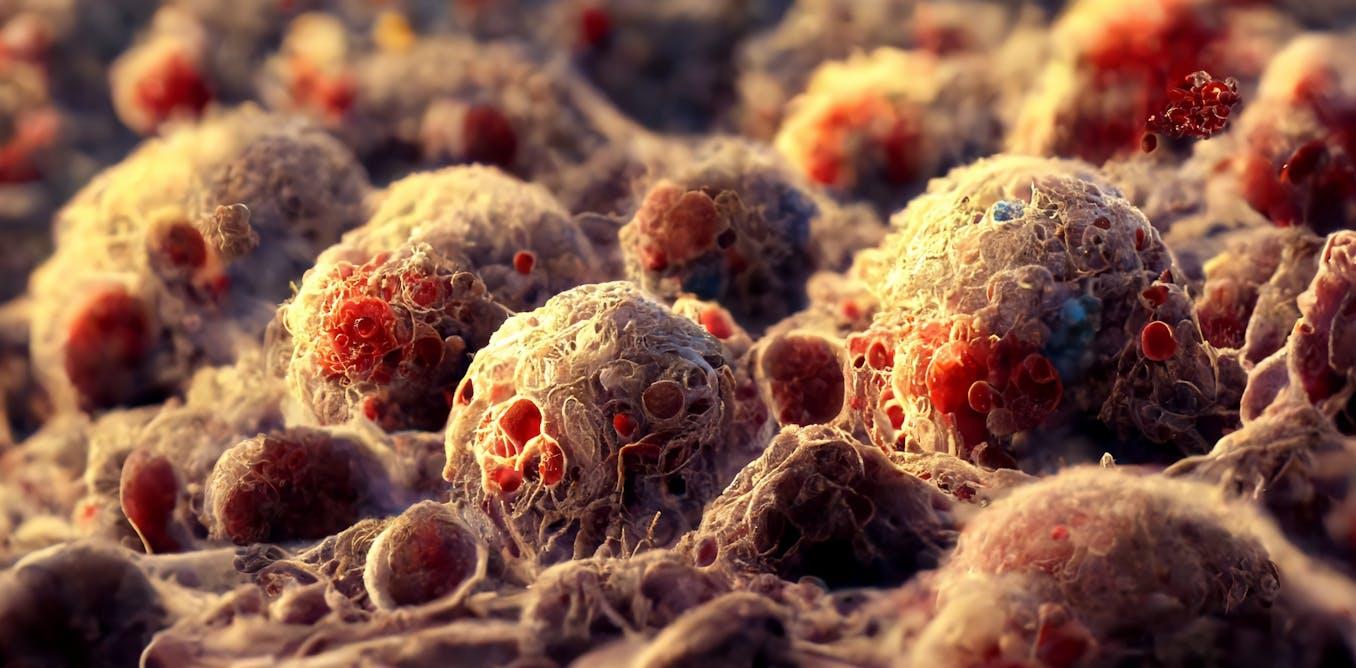- Prognosi guidata da stadio, indici (IPI/FLIPI/MIPI), età, PS e LDH
- Terapie integrate: chemio, anticorpi anti-CD20, bispecifici e coniugati
- CAR-T efficaci nei LNH aggressivi refrattari in pazienti selezionati
- Attenzione a tossicità, fertilità e follow-up per esiti a lungo termine

Ricevere oggi una diagnosi di linfoma non equivale affatto a quanto accadeva vent’anni fa: le opzioni terapeutiche sono cresciute, si sono raffinate e consentono in un numero sempre maggiore di casi di evitare il trapianto di midollo, aumentando le chance di guarigione anche in presenza di malattia estesa. Questa evoluzione nasce dall’integrazione tra chemioterapia, immunoterapia, anticorpi innovativi e terapie cellulari di nuova generazione.
In questo quadro in rapido movimento, la prognosi dipende da un insieme di fattori che includono il tipo istologico, lo stadio, l’età, le condizioni generali, alcuni parametri di laboratorio e il grado di diffusione extranodale. Conoscere come si classificano i linfomi, quali sintomi osservare, come si effettuano stadiazione e diagnosi, e quali indici predittivi vengono utilizzati è fondamentale per interpretare correttamente il percorso clinico e orientare il trattamento più adatto.
Che cos’è il linfoma e come si sviluppa
I linfomi sono tumori del sistema linfatico che originano dai linfociti, le cellule del sistema immunitario incaricate di difenderci da virus, batteri e altre minacce. Possono coinvolgere linfociti B o T e nascere nei linfonodi, nella milza, nel midollo osseo o in sedi extranodali; in pratica, qualsiasi organo può potenzialmente essere interessato quando le cellule patologiche migrano.
Alla base vi sono mutazioni genetiche acquisite che alterano i meccanismi di crescita e morte cellulare, permettendo al linfocita trasformato di replicarsi senza controllo. Non è raro che il microambiente circostante favorisca la sopravvivenza delle cellule neoplastiche. La fase di maturazione del linfocita in cui avviene la trasformazione e il tipo di alterazioni determinano i molteplici sottotipi clinici e biologici.
Dal punto di vista clinico si distinguono linfomi di Hodgkin (LH) e linfomi non-Hodgkin (LNH). I primi sono sempre di derivazione B e comprendono la forma classica e quella a predominanza linfocitaria nodulare; i secondi sono più eterogenei e possono derivare sia da cellule B (circa il 90%) che da cellule T. In funzione dell’andamento clinico, inoltre, i LNH si classificano in indolenti (a evoluzione lenta, talvolta osservabili senza terapia immediata) e aggressivi (a progressione rapida, ma spesso altamente chemio- e radiosensibili). Per una panoramica sulla classificazione delle neoplasie e le varie tipologie tumorali, è utile consultare risorse dedicate.
Tra i fattori di rischio figurano alcune infezioni virali e batteriche (per esempio EBV, HIV, HTLV-1, HCV, Helicobacter pylori, Chlamydia psittaci) e condizioni di immunodeficienza o malattie autoimmuni. Va sottolineato che, diversamente da altre neoplasie, non esistono programmi di screening di popolazione per la diagnosi precoce del linfoma.
Segni e sintomi: cosa osservare
Il campanello d’allarme più comune è l’aumento di volume persistente di uno o più linfonodi superficiali (collo, ascelle, inguine). Questi linfonodi ingranditi di solito non sono dolenti al tatto e, con il tempo, possono confluire in masse più estese. La linfoadenopatia può restare localizzata ma spesso interessa più aree corporee.
Quando la patologia coinvolge linfonodi profondi (mediastino, retroperitoneo), la massa può comprimere strutture adiacenti e provocare sintomi specifici. Tra le manifestazioni possibili si annoverano: dispnea ed edema del volto da compressione della vena cava superiore, ittero per ostruzione delle vie biliari, idronefrosi per compressione ureterale, vomito e stipsi da occlusione intestinale, oltre a versamenti chilosi o linfedema in caso di ostacolo al drenaggio linfatico.
- Compressione vena cava superiore: respiro corto ed edema facciale.
- Ostruzione biliare: comparsa di ittero e prurito.
- Compressione ureterale: idronefrosi e dolore lombare.
- Occlusione intestinale: vomito, gonfiore e stipsi ostinata.
- Interferenze del linfodrenaggio: versamento chiloso pleurico/peritoneale o linfedema degli arti.
Nei linfomi cutanei (alcuni LNH sia B sia T), la pelle può mostrare noduli eritematosi, chiazze, papule, placche o tumori; nelle carnagioni scure l’eritema può essere meno evidente. I sintomi sistemici (“B”)—febbre, sudorazioni notturne profuse, perdita di peso non intenzionale e stanchezza marcata—possono precedere la linfoadenopatia, specie nelle forme aggressive, e richiedono imaging (TC o PET) per localizzare la malattia.
L’anemia è frequente all’esordio o nel corso della malattia e riconosce cause diverse: sanguinamento da coinvolgimento gastrointestinale (con o senza piastrinopenia), emolisi (ipersplenismo o anemia emolitica autoimmune), infiltrazione midollare, soppressione midollare iatrogena da chemio/radioterapia o inibizione funzionale correlata all’infiammazione cronica.
- Perdite ematiche in caso di linfoma gastrointestinale.
- Emolisi da cause autoimmuni o ipersplenismo.
- Infiltrazione del midollo osseo da cellule linfomatose.
- Tossicità ematologica delle terapie antitumorali.
- Anemia dell’infiammazione in contesti cronici.
Alcuni sottotipi presentano quadri clinici peculiari. Il linfoma-leucemia dell’adulto a cellule T (associato a HTLV-1) ha in genere andamento fulminante con infiltrati cutanei, linfoadenopatia, epatosplenomegalia, cellule T maligne in sangue periferico e frequente ipercalcemia su base umorale. Il linfoma anaplastico a grandi cellule può invece esordire con lesioni cutanee e viscerali a rapida progressione e può simulare un linfoma di Hodgkin o un carcinoma indifferenziato.
Quando i sintomi persistono—per esempio febbricola, tosse secca, sudorazioni, calo ponderale o linfoadenopatie durevoli—è opportuno rivolgersi al medico. Ciò vale particolarmente per adolescenti e giovani adulti, tra i quali il linfoma di Hodgkin è relativamente frequente e spesso si associa a massa mediastinica con dispnea, tosse secca fastidiosa e sensazione di costrizione.
Stadiazione e lettere aggiuntive
Stabilire l’estensione della malattia (stadiazione) è cruciale per la prognosi e per decidere il trattamento. Negli LNH si utilizzano quattro stadi: stadio I (una singola stazione linfonodale), stadio II (due o più stazioni dallo stesso lato del diaframma), stadio III (stazioni su entrambi i lati del diaframma) e stadio IV (interessamento di organi extranodali, come fegato, polmoni, ossa o midollo osseo).
Accanto al numero di stadio, si aggiungono lettere che affinano la descrizione: A (assenza di sintomi sistemici), B (presenza di febbre, sudorazioni notturne profuse, calo ponderale ≥10% in 6 mesi), E (coinvolgimento extranodale contiguo), S (interessamento della milza) e X per masse voluminose (“bulky”). Queste sigle orientano intensità e strategia terapeutica insieme al tipo istologico e ad altri indici prognostici.
Diagnosi: dall’esame clinico alla biopsia
Il percorso diagnostico parte dall’esame obiettivo con palpazione delle aree linfonodali superficiali (cervicale, ascellare, inguinale, femorale), valutazione di fegato e milza e ricerca di segni compressivi. Esami di laboratorio (emocromo, indici di flogosi, LDH, β2-microglobulina) aiutano a inquadrare la massa tumorale e la velocità di crescita.
Il cardine della diagnosi è la biopsia (preferibilmente escissionale) del linfonodo o dell’organo sospetto. Il campione è sottoposto a esame istologico, immunoistochimica, immunofenotipo e, quando indicato, a analisi genetiche per identificare marcatori utili alla classificazione e alla scelta terapeutica. La biopsia del midollo osseo può completare la stadiazione, specie nei LNH indolenti.
Per mappare con precisione la malattia si ricorre a TC total-body, PET (molto sensibile ma da interpretare con cautela), radiografia del torace e, in casi selezionati, risonanza magnetica (ad esempio per SNC). In presenza di interessamento gastrointestinale sono utili gastroscopia e colonscopia; se si sospetta il coinvolgimento del sistema nervoso centrale, è indicato l’esame del liquor. La ristadiazione al termine dei trattamenti consente di valutare risposta e residuo di malattia.
Prognosi: indici predittivi e fattori chiave
La prognosi dei linfomi non-Hodgkin si stima combinando variabili cliniche e di laboratorio. L’International Prognostic Index (IPI) è il modello più utilizzato per i LNH aggressivi e integra cinque elementi: età, performance status (scala ECOG), stadio, numero di sedi extranodali e livelli di LDH. Aumentare il numero di fattori sfavorevoli sposta il paziente in classi di rischio più alte, con impatto su probabilità di remissione completa e sopravvivenza a 5 anni.
Per i linfomi follicolari si impiega il FLIPI (età, stadio, emoglobina, numero di stazioni linfonodali coinvolte, LDH), mentre per il linfoma mantellare si usa il MIPI. Questi sistemi aiutano a personalizzare intensità e sequenza terapeutica, pur non sostituendo il giudizio clinico e le peculiarità del sottotipo biologico.
| Grado | Descrizione funzionale |
|---|---|
| 0 | Nessuna limitazione; il paziente svolge attività abituali senza restrizioni. |
| 1 | Attività leggere consentite; limitazioni solo per sforzi intensi. |
| 2 | Autosufficiente ma non lavorativamente attivo; in piedi oltre il 50% del tempo. |
| 3 | Quasi sempre a riposo; deve restare a letto/seduto per più del 50% del tempo. |
| 4 | Disabilità completa; costretto a letto per la totalità del tempo. |
Storicamente, nei LNH aggressivi si osserva che i pazienti sotto i 60 anni hanno sopravvivenze a 5 anni più alte in ogni classe IPI rispetto agli over 60. Nelle coorti di riferimento si registrano, ad esempio, tassi di remissione completa che vanno da circa il 90% nel rischio più basso fino a sotto il 50% nel rischio alto, e sopravvivenze a 5 anni che calano progressivamente dal 70-80% fino a intorno al 20-30% nelle categorie più sfavorevoli. Questi numeri servono a orientare il clinico nella scelta delle strategie più adeguate, compresa l’eventuale intensificazione terapeutica.
Terapie: chemioterapia, anticorpi, farmaci mirati e CAR-T
Nel linfoma di Hodgkin la base del trattamento è la polichemioterapia ABVD (doxorubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina), alla quale può seguire radioterapia sulle aree interessate, soprattutto negli stadi iniziali. La PET precoce dopo due cicli fornisce un’indicazione prognostica utile per modulare l’intensità terapeutica.
In caso di malattia refrattaria o recidiva, si procede con schemi di salvataggio (per esempio IGEV), raccolta di cellule staminali periferiche e autotrapianto. Qualora la recidiva persista dopo autotrapianto o in scenari selezionati, si valuta il trapianto allogenico. Tra i farmaci innovativi spiccano l’anticorpo coniugato brentuximab vedotin (anti-CD30) e gli inibitori di PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) in contesti resistenti o recidivati.
Nei linfomi non-Hodgkin indolenti, l’attesa vigile (“watch and wait”) è possibile quando la malattia è paucisintomatica e poco estesa. Alla necessità di cura, lo standard è la chemioimmunoterapia con rituximab (anti-CD20) associato a schemi chemioterapici. Farmaci biologici e inibitori di pathway (come lenalidomide, ibrutinib, idelalisib) agiscono su bersagli specifici, arricchendo l’armamentario terapeutico.
Gli anticorpi monoclonali hanno rivoluzionato molti sottotipi: gli anti-CD20 hanno ridisegnato la storia naturale dei LNH B, gli anticorpi bispecifici avvicinano i linfociti T alle cellule tumorali favorendone l’eliminazione, mentre gli immuno-coniugati veicolano tossici direttamente nel tumore, massimizzando l’effetto e limitando, per quanto possibile, l’esposizione dei tessuti sani.
Capitolo a parte sono le terapie cellulari CAR-T: si prelevano linfociti T dal paziente, li si ingegnerizza per esprimere un recettore chimera (CAR) capace di riconoscere un antigene sulla cellula linfomatosa e li si reinfonde. Queste cellule “addestrate” possono riconoscere e distruggere in modo mirato le cellule malate. Nei LNH aggressivi refrattari, in cui storicamente l’alternativa era la chemioterapia ad alte dosi seguita da trapianto autologo (opzione non sempre praticabile), le CAR-T hanno offerto risposte clinicamente significative in una quota di pazienti.
Linfomi nei giovani adulti e nel contesto generale
Il linfoma di Hodgkin è tra le neoplasie più frequenti nel giovane adulto (20-30 anni), con predominanza istologica a sclerosi nodulare. Spesso esordisce con linfoadenopatia del collo e delle regioni sopraclaveari; in non pochi casi è presente una massa mediastinica di volume anche importante, responsabile di tosse secca, dispnea e talvolta difficoltà alla deglutizione.
Tra i LNH che insorgono più comunemente nei giovani ricordiamo il linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), il linfoma linfoblastico e il linfoma di Burkitt, spesso a presentazione aggressiva con rapida crescita tumorale e possibili interessamenti del sistema nervoso centrale. Nonostante l’andamento rapido, l’elevata chemio- e radiosensibilità li rende oggi tra le neoplasie potenzialmente più curabili in questa fascia di età.
Fattori come infezione da EBV o immunodeficienza sono stati associati in particolare al LH, pur in assenza di programmi di prevenzione. In termini di outcome, il LH raggiunge tassi di guarigione molto elevati, mentre per i LNH aggressivi i tassi di guarigione sono in media intorno al 60-70%, con ampia variabilità legata a stadio, biologia e risposta.
Effetti collaterali e qualità di vita
La chemioterapia agisce su cellule a rapida proliferazione e può causare alopecia, nausea, mucositi e alterazioni dell’alvo. Le citopenie determinano rischio infettivo e sanguinamenti, oltre a stanchezza rilevante; si trattano con supporti trasfusionali, fattori di crescita e antimicrobici quando necessari.
Con l’immunoterapia con anticorpi (es. rituximab) si possono verificare reazioni infusioni-simili soprattutto alle prime somministrazioni e una immunosoppressione protratta che aumenta il rischio di infezioni per mesi. I farmaci biologici come lenalidomide, ibrutinib o idelalisib hanno profili di tossicità specifici, che includono eventi ematologici (neutropenia) e non ematologici da gestire con monitoraggio attento.
Dato che le sopravvivenze si sono allungate, si pone grande attenzione a ridurre l’esposizione cumulativa e a prevenire tossicità tardive (cardiovascolari, seconde neoplasie), calibrando la terapia sul rischio individuale. Nei pazienti in età fertile, quando il quadro lo consente, è essenziale discutere precocemente strategie di preservazione della fertilità.
Domande frequenti utili al paziente
Il linfoma è ereditario? I casi familiari legati a fattori genetici sono molto rari. Non sono indicati controlli particolari per i figli dei pazienti, salvo diversa valutazione clinica.
È contagioso? No: non si trasmette da persona a persona.
Alimentazione e sole influiscono? Non c’è prova di relazione diretta tra dieta e comparsa o recidiva dei linfomi. Durante chemioterapia è prudente limitare l’esposizione solare e usare filtri ad alta protezione per evitare reazioni cutanee.
Posso usare prodotti erboristici o omeopatici? Sempre meglio confrontarsi con l’ematologo per evitare interazioni con le terapie anticancro.
Conviene partecipare a uno studio clinico? Le sperimentazioni possono offrire accesso a terapie innovative; l’efficacia non è garantita a priori, ma in centri esperti ciò avviene con garanzie di sicurezza e monitoraggio.
Oggi il percorso dal sospetto alla cura del linfoma è realmente “su misura”: parte da una diagnosi accurata con stadiazione completa, integra indici prognostici come IPI, FLIPI o MIPI per stimare il rischio, e combina chemioterapia, immunoterapie a bersaglio, anticorpi bispecifici e coniugati, fino alle CAR-T nei casi selezionati. Nell’insieme, questa strategia multidisciplinare ha aumentato le probabilità di guarigione—altissime nel linfoma di Hodgkin e significative nei LNH aggressivi—e ha reso possibile, in molte situazioni, evitare il trapianto o ridurne la necessità, bilanciando efficacia e qualità di vita nel breve e nel lungo periodo.